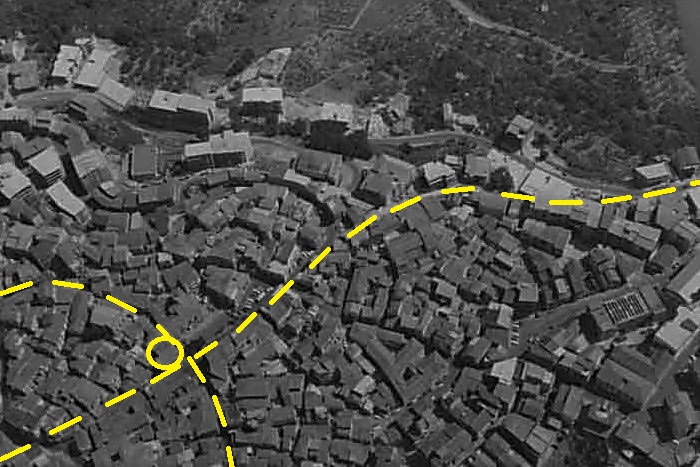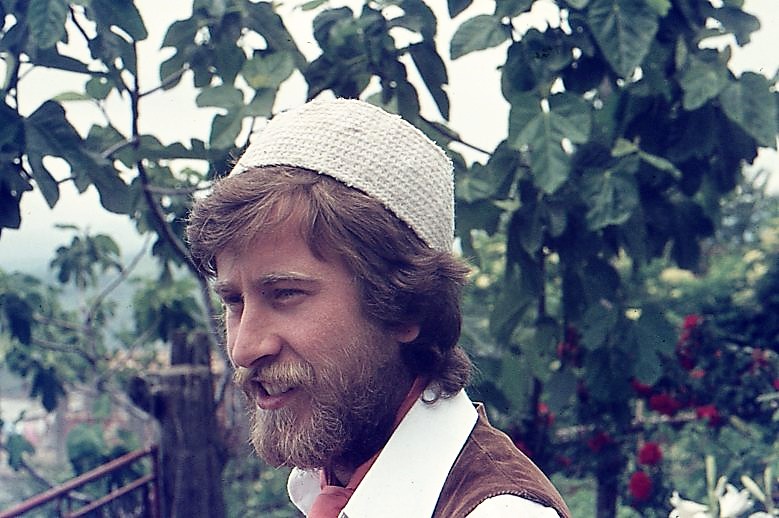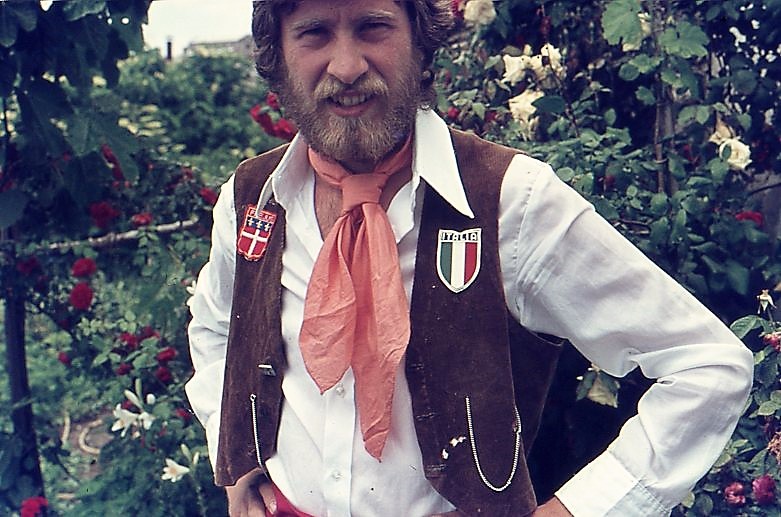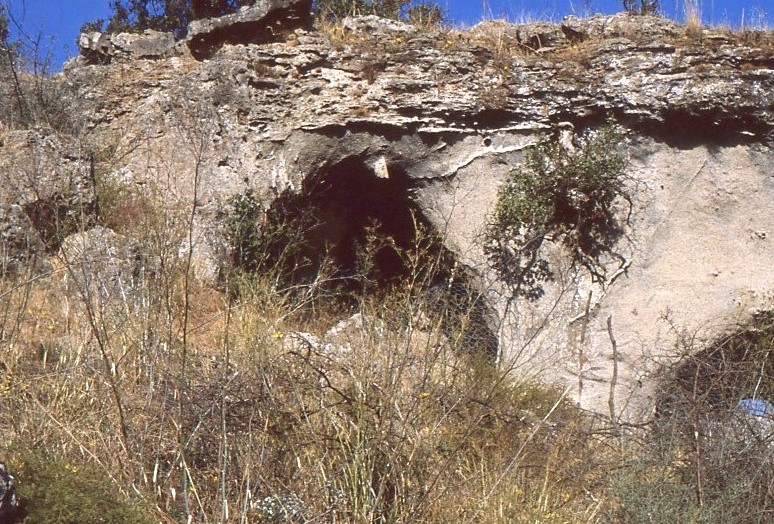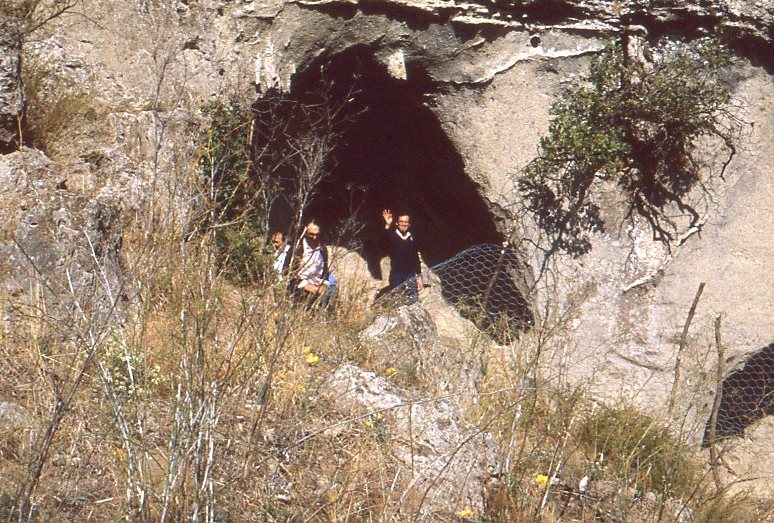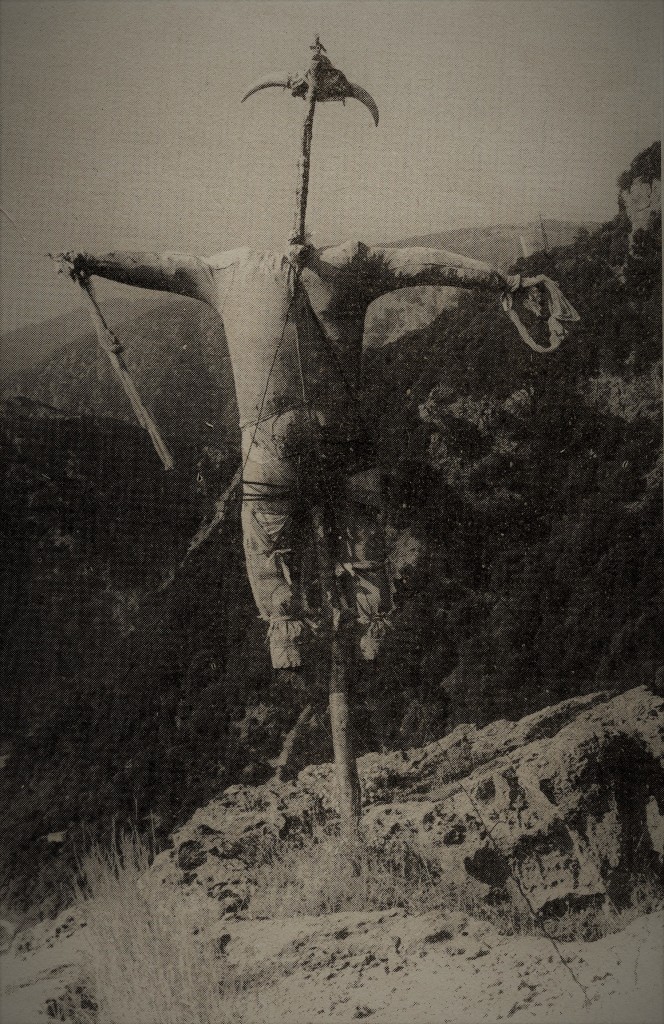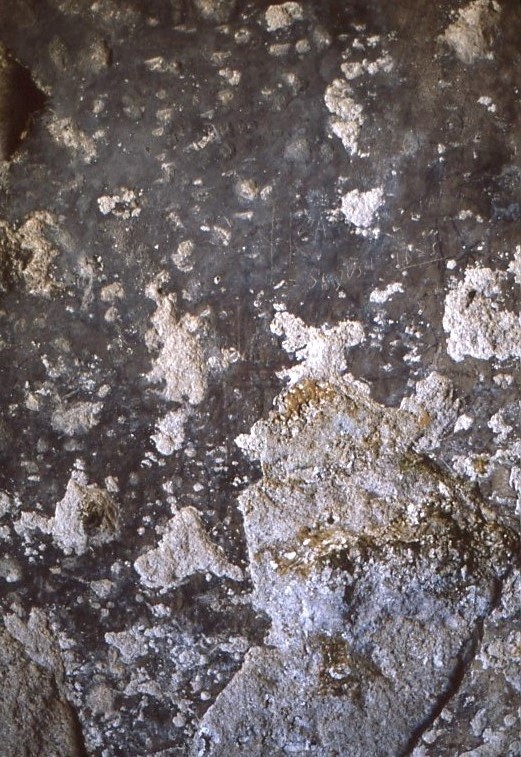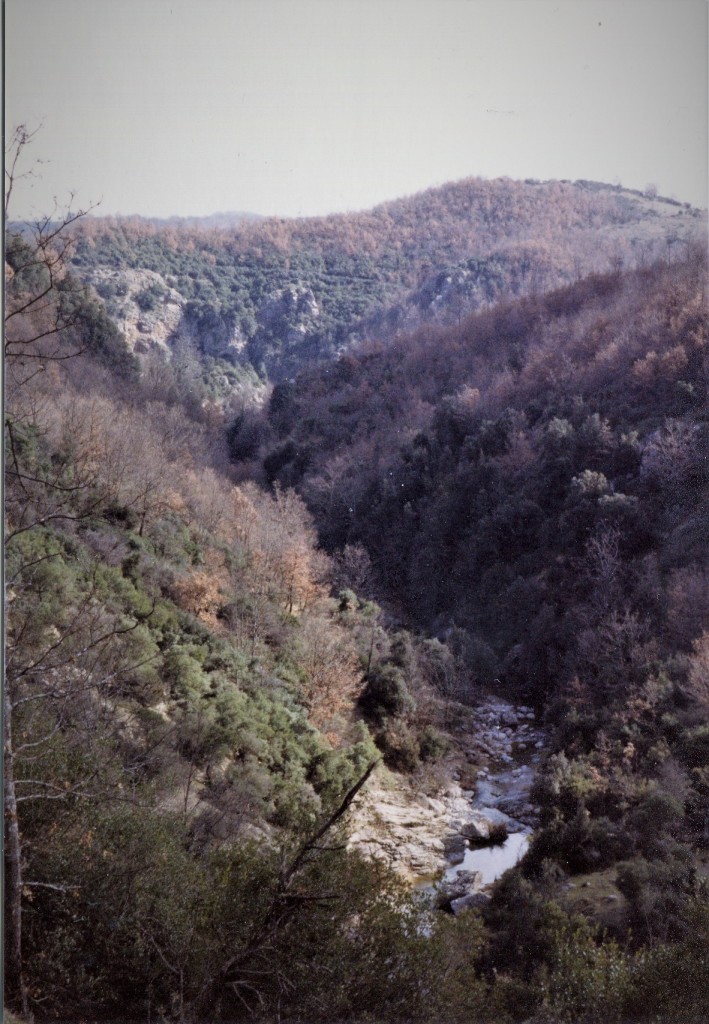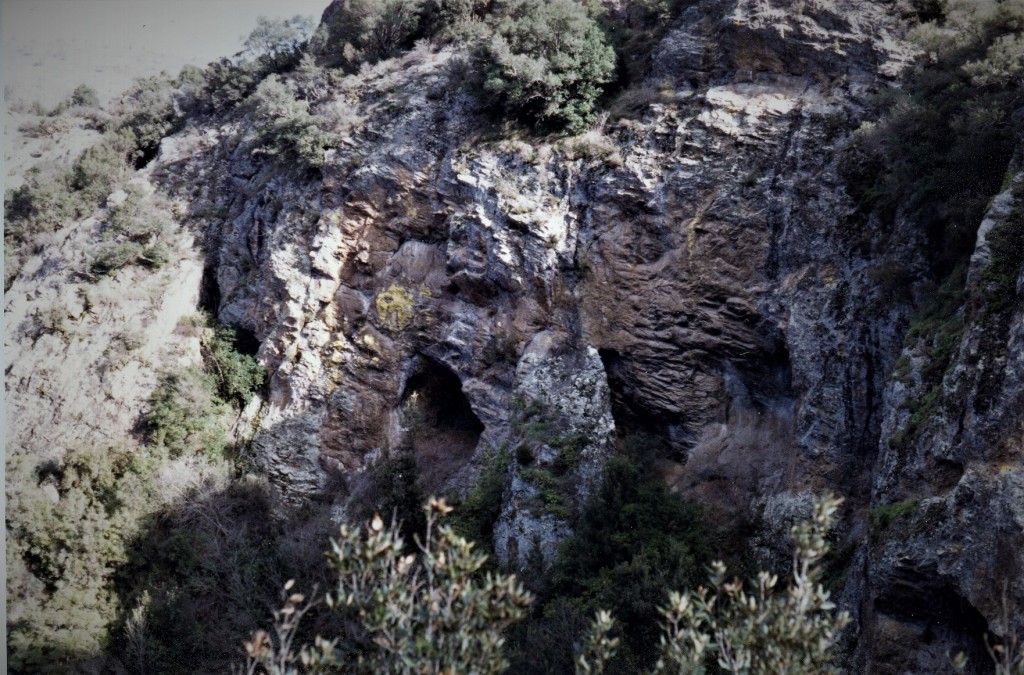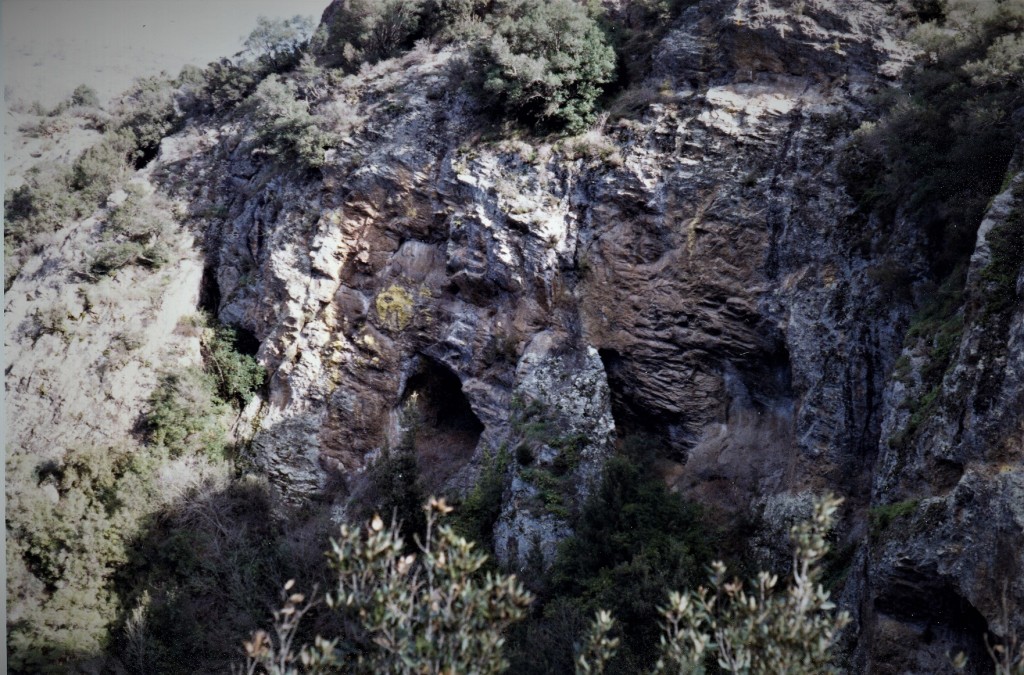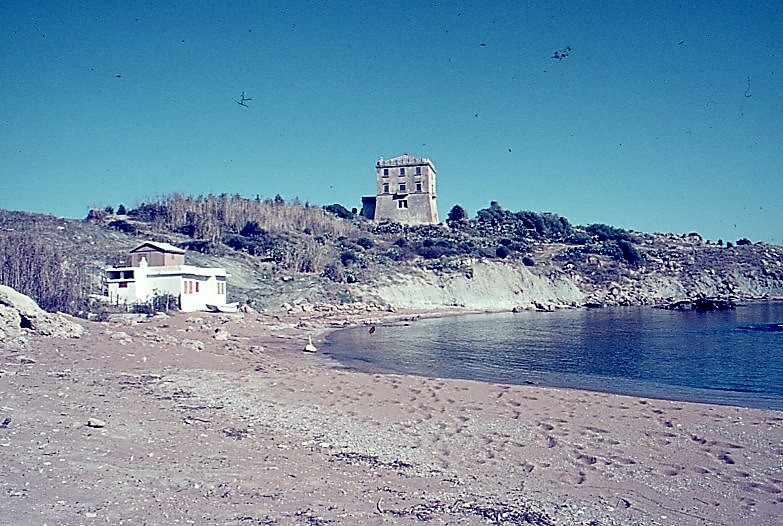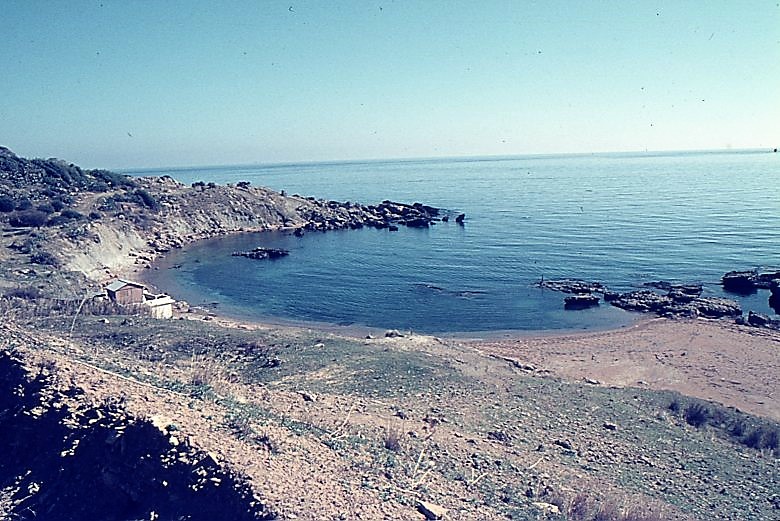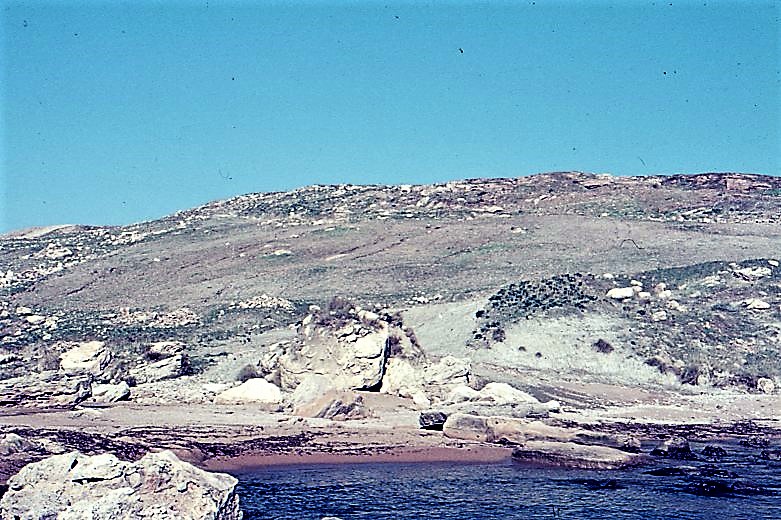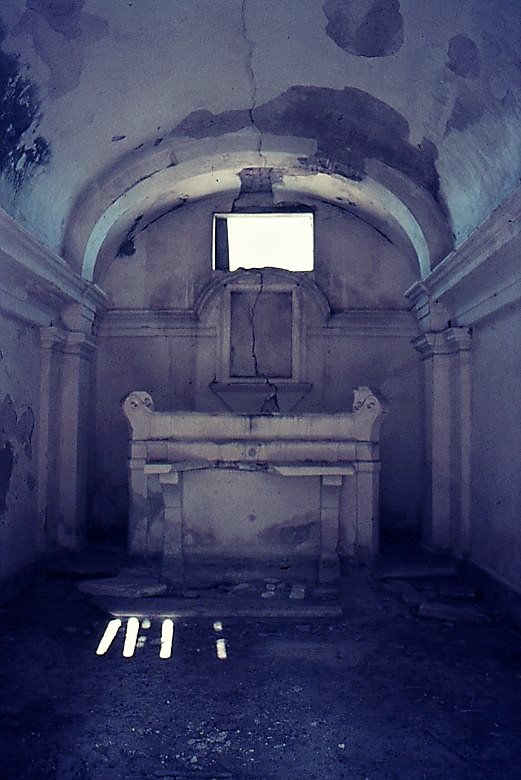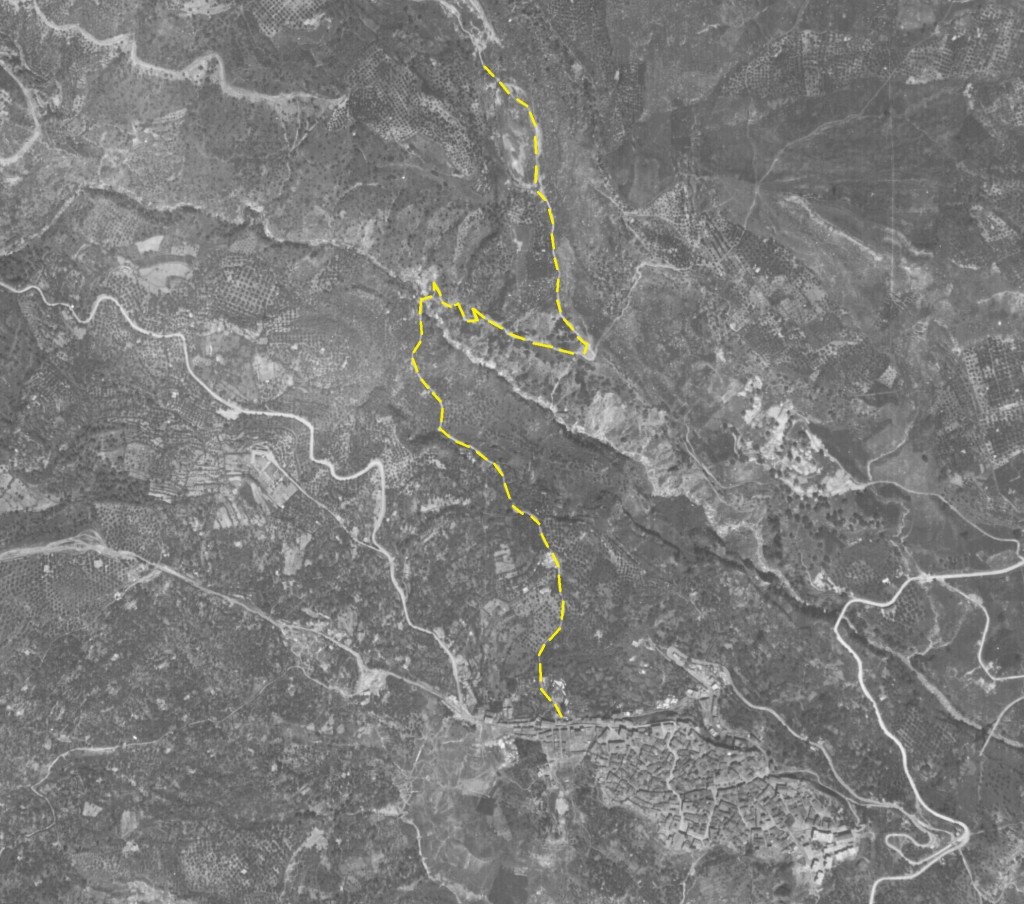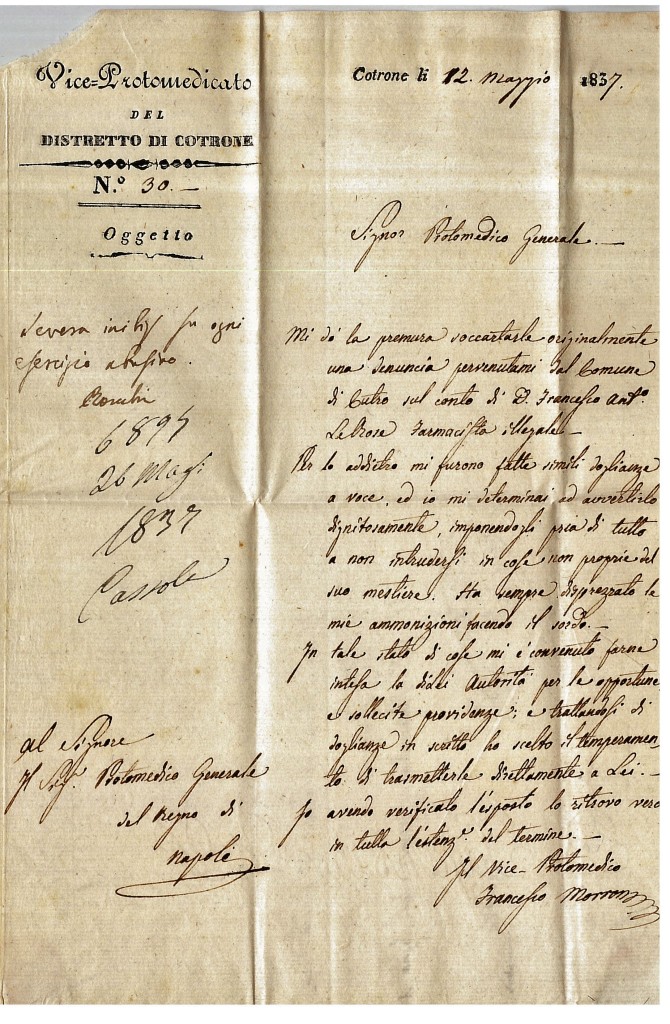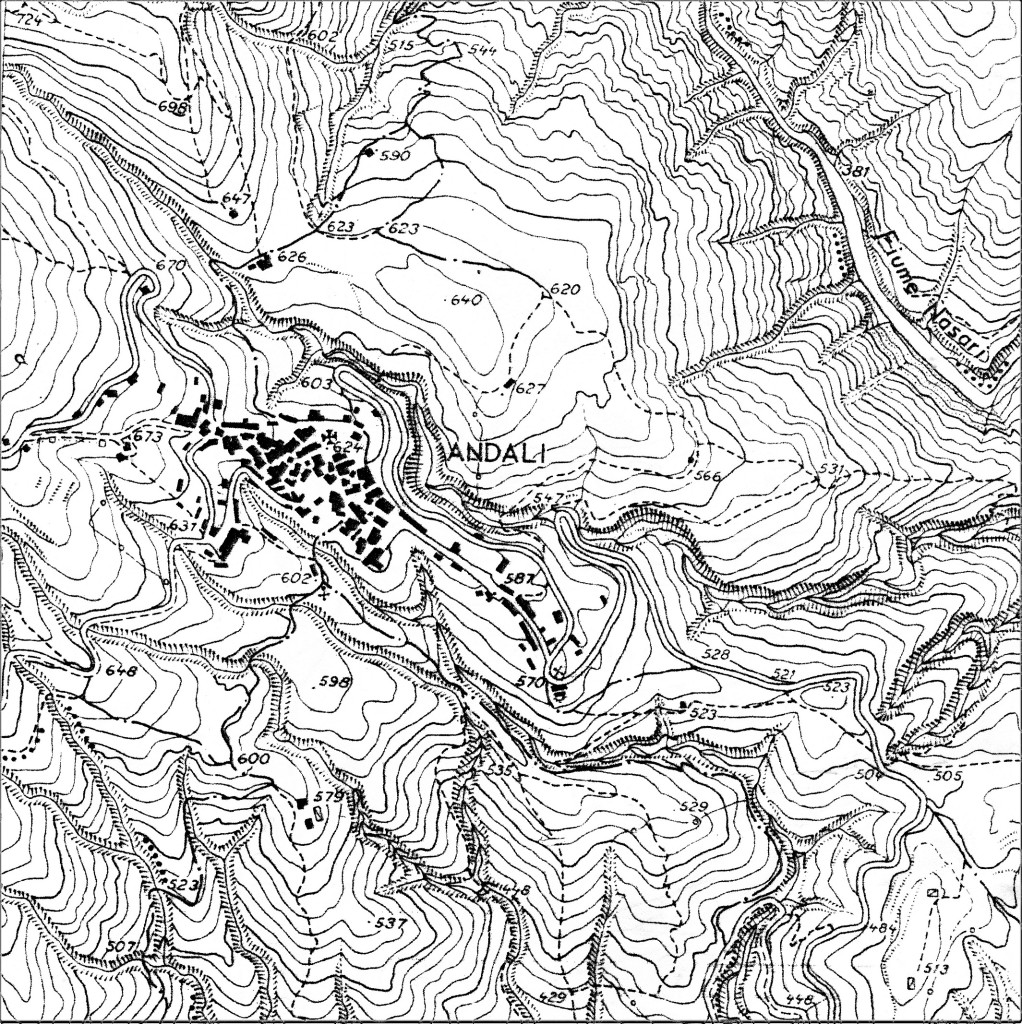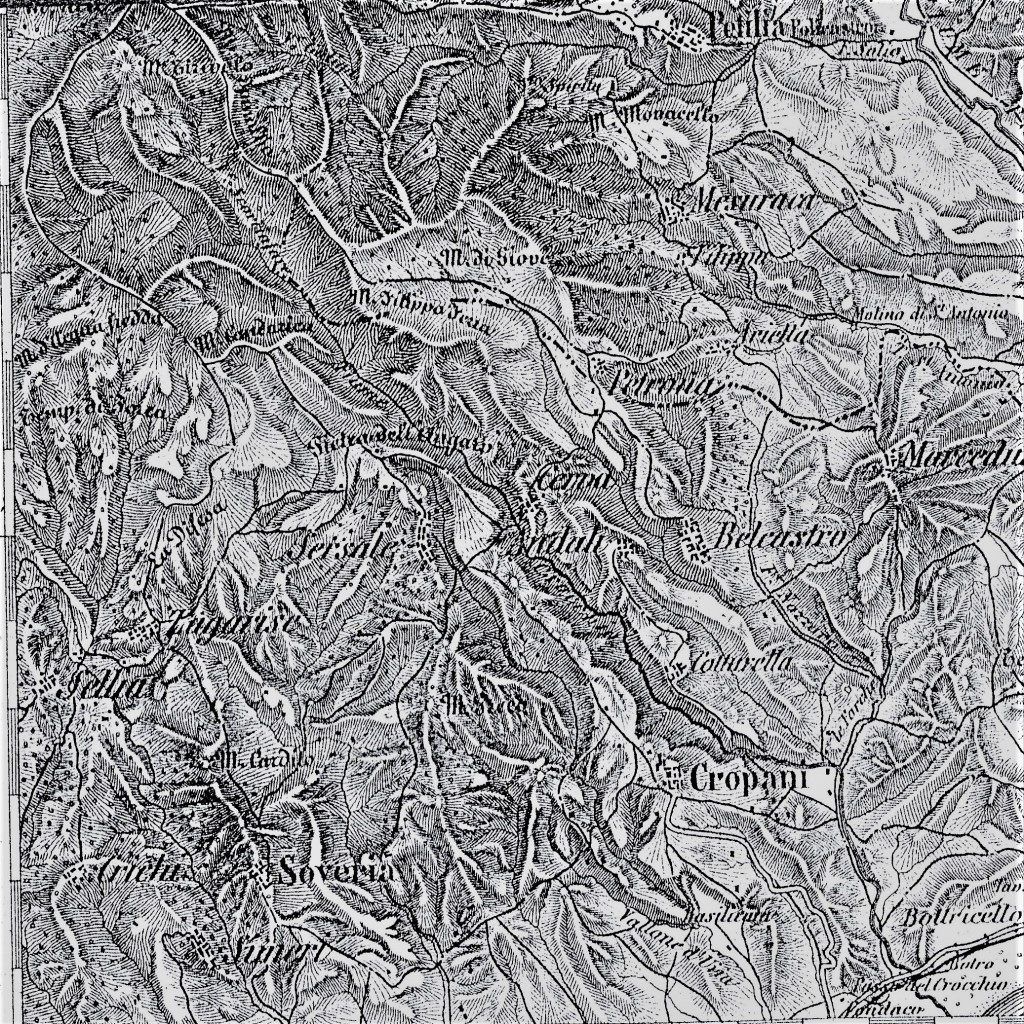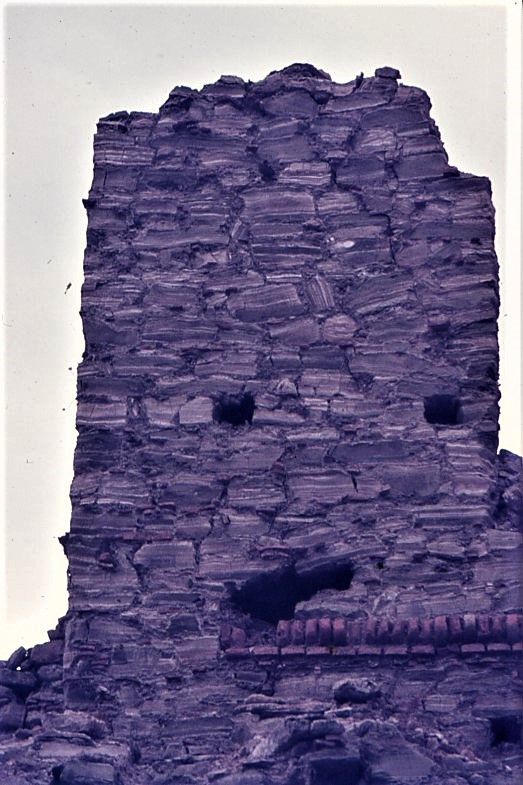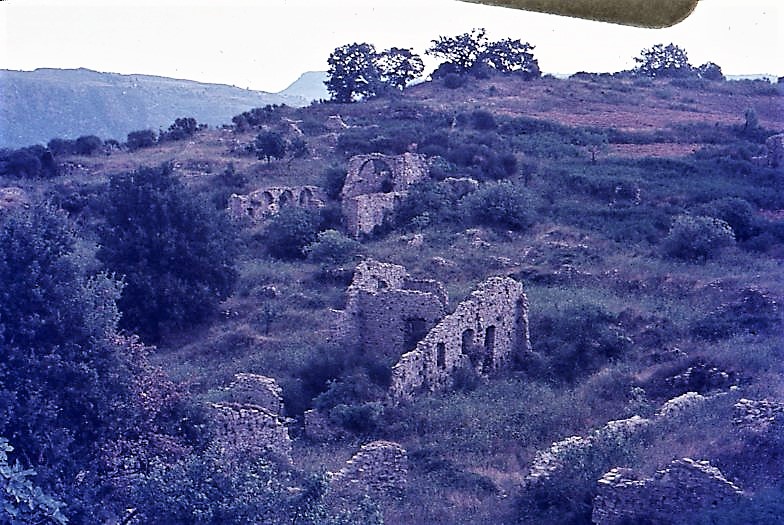![]()
Petilia Policastro (KR), da www.funghiitaliani.it.
Allungato tra il massiccio del monte Gariglione e la valle del fiume Tacina, unico, tra quelli vicini, ad addentrarsi profondamente nella Sila, il territorio di Policastro conserva ancora oggi alcuni tratti caratteristici, che ci permettono di apprezzare alcune delle sue antiche peculiarità.
Una lettura che è possibile condurre anche studiando le caratteristiche dell’insediamento realizzato dai suoi abitanti che, nel periodo compreso tra alto e basso Medioevo, lo colonizzarono a più riprese,[i] attraverso una forma sparsa caratterizzata dalla residenza in “casali”,[ii] comune a tutta l’area collinare interna della Calabria centrale posta a ridosso del massiccio silano (Cosenza, Taverna), adatta e funzionale alla economia pastorale che caratterizzò la socialità di quelle antiche genti fin dalla loro originaria organizzazione politica.[iii]
![]()
Panoramica della vallata del Tacina visibile da Petilia Policastro (KR).
Un abitato antico
Anche se la documentazione disponibile a riguardo risulta particolarmente esigua e controversa, l’esistenza della diocesi di ὁ τοῦ Пαλαιοϰάστρου (“Palaeocastri”) sembra riferibile ad epoca anteriore al Mille.[iv]
In relazione agli avvenimenti che interessarono i luoghi appartenenti all’arcidiocesi di Santa Severina durante questo periodo, possiamo avanzare l’ipotesi che questo toponimo, qualificando Policastro come un abitato fortificato di antica fondazione,[v] potrebbe aver trovato la sua genesi in tempi precedenti alla fase di “Incastellamento” (sec. IX-X), e successivi all’arrivo dei Longobardi nella parte settentrionale della regione (VII-VIII sec.), quando i territori di “Calabria” appartenenti all’arcidiocesi di Santa Severina e adiacenti alla Sila, mantenuti nel dominio dei Bizantini lungo tale confine, furono oggetto di aspre lotte, che trovarono coinvolti anche gli Arabi durante la seconda metà del sec. IX.[vi]
Il luogo compare nel suo stato arroccato e munito ancora agli inizi del dominio normanno, quando il Malaterra riferisce che, durante la spedizione che portò il duca Roberto e suo fratello Ruggero ad espugnare alcuni “castra Calabriae”, nell’anno 1065 il “castrum” di Policastro fu distrutto e tutti i suoi abitanti furono condotti dal duca “apud Nicotrum, quod ipso anno fundaverat”.[vii]
La distruzione del kastron/castrum, preludio alla costituzione della χώρας (“terra”) di Policastro (Παλαιοκάστρου),[viii] come risulta documentato dalla metà del sec. XII, lascerà segni evidenti nella sua struttura urbana dove, con l’avvento dell’età feudale, si rileva l’esistenza di un abitato strutturato in due nuclei ben distinti: il castello (castellum), luogo del potere signorile, eretto dai nuovi feudatari normanni in alto, sul posto verosimilmente occupato dalla precedente fortificazione bizantina distrutta (kastron), e la “terra” sottostante o “asti” (άστεως χώρας),[ix] soggetta al loro dominio.
![]()
Petilia Policastro (KR), topografia della località (particolare della sez. 1:10000 del F. 237 della Carta d’Italia dell’IGM).
La forma urbis medievale
I due nuclei, che riassumono l’assetto urbano del luogo a seguito dell’introduzione del Feudalesimo, risultano evidenti all’indagine aerofotografica, che ci consente di circoscriverli con una certa precisione: il castello posto “in capite terrae praedictae versus occidentem”,[x] nel luogo più favorevole per sbarrare la via che, discendendo dalla Sila, si dirigeva verso i due principali attraversamenti del fiume Tacina, (quello presso Roccabernarda e quello presso San Pietro di Niffi), e la terra, dove era concentrato il principale popolamento del luogo, caratterizzata da un circuito murario di forma regolare ed ellittica, che racchiudeva l’area attorno all’antica chiesa di San Nicola “de Policastro”,[xi] dove convergevano e s’incrociavano le due vie principali che attraversavano il territorio.
Analogamente ad altri casi che possiamo riscontrare nel Crotonese (Crotone, Strongoli, Santa Severina, ecc.), fuori da questo circuito ed a ridosso di uno degli accessi, possiamo individuare la “Judeca”, dove risiedeva la comunità ebraica.
![]()
Assetto urbano di Policastro agli inizi del periodo basso medievale: Castello (A), Terra (B), Judeca (C).
![]()
Direttrici viarie incentrate su Policastro e principali collegamenti.
Un nuovo assetto
Rispetto a questa organizzazione dello spazio urbano durante il periodo medievale (sec. XI-XV), quando rimase una netta distinzione tra la terra ed il castello, rileviamo in seguito un riassetto che possiamo far risalire agli inizi del sec. XVI, al tempo del conte Andrea Carrafa che, analogamente ai casi di altri luoghi sottoposti con la forza al suo dominio (Cirò, Santa Severina), condusse all’accorpamento di questi due nuclei, coinvolgendo ambiti caratterizzati precedentemente, da una giurisdizione autonoma.
Conferme in questa direzione ci provengono dall’antico castello di Policastro, relativamente cui si conserva un atto del 14 agosto 1386 che testimonia l’esistenza del “cast.m” della “Terram Policastri”,[xii] e dalla vicina chiesa di Santa Maria “vulgo detta la Magna” di presentazione regia,[xiii] che risulta richiamata “in loco detto il Castello”,[xiv] e che compare per la prima volta in qualità di parrocchiale nel 1418.[xv] Al tempo di re Alfonso I d’Aragona (1442-1458), risalgono invece le prime notizie relative alla parrocchiale di San Nicola “deli Cavaleri”, che sorgeva nelle vicinanze della porta cittadina detta del Castello,[xvi] e dell’altra parrocchiale di Sant’Angelo de lo Milillo.
![]()
Petilia Policastro (KR), località Rione Castello.
Successivamente, invece, lo spazio occupato anticamente dal “castellum”, dove il potere signorile aveva costituito un insediamento autonomo e distinto rispetto a quello della “terra”, passò ad essere compreso entro il circuito murario ed i confini urbani di quest’ultima. Ciò avvenne come conseguenza della rivolta che seguì alla perdita della condizione demaniale da parte dei cittadini di Policastro che, il 14 ottobre 1496, assieme ad altre terre, re Federico vendette ad Andrea Carrafa con il titolo di conte.
In questa occasione, quale simbolo del potere feudale, il castello fu distrutto dai ribelli per non essere mai più ricostruito. Nel 1520, in occasione della reintegra dei beni feudali della “Terrae Policastri” appartenenti al conte di Santa Severina, compare infatti “In primis Castrum dirutum”, del quale sopravvivevano comunque, chiare evidenze delle antiche vestigia dei suoi edifici e dei fossi che lo avevano precedentemente limitato rispetto alla campagna ed all’abitato (“cum apparentia, et evidentia fossi dicti Castri, ac Vestigiorum, et edificiorum ipsius in capite terrae praedictae”).[xvii]
Tali resti particolarmente consistenti permarranno a lungo. La documentazione notarile precedente al terremoto del 1638, evidenzia infatti che, fino a quel tempo, i ruderi del castello rimanevano ancora a testimoniare chiaramente il luogo in cui la fortificazione era esistita nel passato. É del 12 giugno 1630 un atto rogato dal notaro G. B. Guidacciro nel “castro deruto” di Policastro.[xviii]
![]()
Resti di murature scarpate in località Rione Castello di Petilia Policastro (KR)
A quel tempo, il luogo “ubi dicitur lo castello” posto “intus praedittam Civitatem”, nelle vicinanze delle rupi dette le “ripas della difesa”, dove esisteva ancora un “muro” chiamato “lo castellum”,[xix] oltre alla presenza di alcune abitazioni con i loro orti appartenenti a privati cittadini, come ad esempio quelle dei Tuscano,[xx] era caratterizzato dalla presenza di un ampio spazio aperto chiamato “lo largo di d.tto Castello”, dove si trovava la chiesa eretta dal presbitero D. Jacobo de Aquila sotto il titolo di San Giacomo Maggiore contigua con il suo palazzo.[xxi]
Attualmente il toponimo “Castello” trova riscontro nella toponomastica cittadina, dove troviamo: “Via Salita Castello”, “Vico Castello” e “Rione Castello”.
![]()
La parte dell’abitato di Petilia Policastro identificato ancora oggi come “il Castello”, in un vecchio panorama visto da nord-ovest (foto Mimmo Rizzuti).
La “città” regia
Dopo essere appartenuto ai conti di Santa Severina, nel 1564 il feudo di Policastro fu acquistato dal barone di Sellia, Giovan Battista Sersale. A seguito di ciò l’università ricorse al vicerè, chiedendo di essere immessa in regio demanio, ed attraverso l’interessamento dell’arcivescovo di Santa Severina Giulio Antonio Santoro, la richiesta fu ottenuta nel 1568, quando Policastro comprò la condizione demaniale pagando al Sersale la cifra di 22.000 ducati, che questi aveva sborsato per l’acquisto del feudo.
Nella realtà però, non possedendo questa somma, l’università fu costretta ad indebitarsi senza rimedio vendendo le proprie entrate feudali, che furono acquistate dalla duchessa di Castrovillari pagando la somma di 16.000 ducati. Tale vendita escludeva naturalmente “la giurisdizione et dominio dei vassalli”, che rimaneva alla regia Corte.[xxii] Successivamente, dopo essere state incamerate dal re, le entrate feudali di Policastro furono vendute al policastrese Gaspare Venturi dal quale, ancora una volta, ritornarono alla regia Corte, per essere infine acquistate nel giugno del 1625, per 12.000 scudi, da Aurea Morano baronessa di Cotronei, a cui successe il duca di Belcastro.[xxiii]
![]()
Petilia Policastro (KR), veduta del versante nord-ovest.
Agli inizi del Seicento l’abitato di Policastro che si estendeva dal luogo detto “il Castello” alla “timpa dell’ogliastro”, prossima alla chiesa di Santa Maria “delli fransisi”, che sorgeva nel luogo in cui oggi esiste quella di San Francesco di Paola, era protetto da mura poste a sbarrare l’accesso all’abitato.
Nella sua parte più alta, dove esisteva la “Porta del Castello” e permanevano resti delle fortificazioni più antiche, le mura poste vicino al luogo detto “la timpa della serpe et Turretta”, sovrastavano la via pubblica che discendeva “in molendino de cerratullo”, passando “di sotto le mura della citta”,[xxiv] e seguendo “una inselciata” ricavata riempendo il vecchio fossato posto a protezione della cortina, come riferisce il Mannarino successivamente.[xxv]
Dal lato opposto, le “mura della citta” giungevano alle prossimità della chiesa di Santa Maria Magna e munivano la parte nord-orientale dell’abitato, sfruttando le rupi poste lungo lo strapiombo detto “lo ringo”, sotto cui era diffusa la coltivazione del gelso.[xxvi] Da questa parte esisteva una porta di soccorso. Le terre “dello ringo seu porticella” compaiono già verso la fine del Cinquecento, “estramenia ditte Civitatis”.[xxvii]
![]()
Resti di murature scarpate sovrastanti la via Arringa di Petilia Policastro (KR).
Le “ripas seu menia dictae Civitatis” munivano anche l’area d’accesso alla “Portam nuncupatam della Piazza”,[xxviii] fuori dalla quale si trovava la chiesa “dell’Annunziata detta di Fuora”,[xxix] giungendo fino alla “porta nova”,[xxx] posta nelle vicinanze della chiesa di Santa Maria “delli fransisi”, e del luogo extramoenia detto “Januam Nove seu timpam oleastri”, “ubi dicitur fore la porta nova de detta Citta”,[xxxi] dove esisteva la “ripam oleastri”,[xxxii] ovvero la “rupam oleastri”[xxxiii] o “timpa dell’ogliastro”.[xxxiv]
Da questa parte, le mura erano protette da un fossato che giungeva fino al luogo in cui, prima del terremoto del 1638, era esistita la chiesa di Santa Caterina ed in cui si trovava la porta omonima. La presenza delle mura nelle vicinanze della chiesa di Santa Caterina, comincia ad essere documentata già nei primi anni del Seicento,[xxxv] quando quest’ultima risulta richiamata nel luogo detto “la vasilea” o “la basilea”.
![]()
Petilia Policastro (KR), la parte dell’abitato prossima alla chiesa di San Francesco.
Un atto del 9 agosto 1613, testimonia infatti, che le case di Francisco Commeriati, poste dentro la terra di Policastro, confinavano con la chiesa di Santa Caterina, l’orto di Fran.co Paudari ed i “sicomos” di Petro Paulo Serra “ubi dicitur la vasilea”,[xxxvi] toponimo correlato all’esistenza in questo luogo del vallone “dittus la vasilea”,[xxxvii] ed alle “mura della Citta ditte similm.te la vasilea”,[xxxviii] come ricorda anche il Mannarino agli inizi del Settecento.[xxxix] Tale prossimità è testimoniata anche da altri documenti degli inizi del Seicento,[xl] che evidenziano qui l’esistenza dell’orto della chiesa, costituito dai “Celsi della vasilea”, ovvero “li celsi” detti “la vasilea”,[xli] posti nelle vicinanze delle rupi, dei valloni e dei fossi che proteggevano questo settore della cinta muraria.[xlii]
Le rupi proteggevano anche la vicina porta “della Judeca”,[xliii] accesso sovrastante la località detta “cimicicchio”,[xliv] realizzato in maniera tale da includere entro le mura, l’area dell’antica “Judeca”.
![]()
Petilia Policastro (KR), via Giudaica (dalla pagina fb I Ricordi dei “Petilini Emigranti”).
Valloni e fossati
Importanti informazioni sull’assetto urbano medievale di Policastro, ci provengono dalla documentazione notarile seicentesca, attraverso cui è stato possibile ricostruire il percorso dei valloni adibiti alla canalizzazione principale delle acque meteoriche e di quelle correnti, che attraversavano l’abitato, sfruttando la presenza dei fossati realizzati anticamente per la protezione delle mura. Caratteristica questa, che ci permette di trovare preziose conferme alle indicazioni forniteci dalla fotografia aerea, circa il percorso della cinta muraria medievale.
Il sistema di raccolta e smaltimento delle acque bianche, in cui confluiva, comunque, anche lo scolo delle “bucerie” della piazza, era costituito dal “vallone” chiamato “la vasilea”, detto anche “della Turana” in quella porzione più prossima alle case appartenute alla quondam Lucretia Turana,[xlv] che si univa con il vallone “della Città” sotto le rupi dette “le catarrata”, precipitando così a valle.
Questo “vallonem Civitatis” che incanalava l’acqua (“vallonem Correntem”), originandosi “à Fumerello”,[xlvi] confinava con la domus palaziata di Minico Cavarretta,[xlvii] passando nelle vicinanze della casa di Gio: Paulo Jannici,[xlviii] e di quella di Fabio Amerato.[xlix] Discendendo verso valle, esso rimaneva sotteso alla piazza, passando nelle vicinanze della chiesa di “santi dimitri”,[l] delle case di Alfontio Caccuri,[li] e di quelle di Joannes Caccuri e di Francesco Comberiati.[lii]
![]()
Petila Policastro (KR), il luogo detto Fumarello (da www.diasporapetilina.it).
Detto anche “de Pantisano”,[liii] nella porzione prossima alla casa di Vespasiano Pantisano, posta in convicino della chiesa di Santo Dimitri e confinante con la domus di Alfonso Caccuri,[liv] questo vallone si univa con il “vallonum dittum della piazza seu bucerie” nell’area sottostante la “publicam Plateam”, dove esistevano la casa di Joannes Thoma Lamanno e quella degli eredi di Vincenso Coco e, dal territorio parrocchiale di San Nicola “de platea”, si passava a quello della parrocchia di San Pietro, in convicino della chiesa di Santa Maria delle Grazie.[lv]
Qui “lo Vallone della Città”,[lvi] passando nel luogo in cui era esistita la “Judeca”, dove assumeva l’appellativo di “valonnem magnum dittum la iudeca”,[lvii] giungeva alle “ripas dittas le catarrata”, per cui era anche comunemente detto “Le Catarrata”.[lviii] In questo luogo esistevano la casa di Caterina Popaianni e quella di Blasio Ritia detta del “Vallone”, che confinava, vinella mediante, con la chiesa di Santa Maria delle Grazie e si trovava in prossimità delle rupi dette “delle Catarrate”,[lix] dove erano convogliate tutte le acque e gli scoli che discendevano dall’abitato.
![]()
I valloni che attraversavano l’abitato di Policastro agli inizi del Seicento, in rapporto all’impianto urbano medievale della terra (A): il “vallonem Civitatis” (1), il vallone “della piazza seu bucerie” (2), il “valonnem magnum dittum la iudeca” detto anche “Le Catarrata” (3) ed il vallone detto “la vasilea” (4).
La viabilità seicentesca
Agli inizi del Seicento, nel luogo detto “fora la Porta del Castello”, passava la “via publica che si va a santa lucia”, o “santo martino”, ovvero la via pubblica “quod vaditur in montanea”, per la quale giungeva a Policastro la processione della Santa Spina,[lx] proveniente dal monastero degli Osservanti.
Da questa via che transitava per la porta “del Castello”, “per cui si esce in piano”,[lxi] si diramava quella che “discinditur in molendino de cerratullo” che, a differenza della precedente, procedeva invece un poco in pendenza.[lxii]
Entro le mura, invece, vicino alla porta della terra detta “del Castello”, dove si trovavano la chiesa ormai diruta di “Santo Nicola delli Cavaleri”, e quella di Santa Maria degli Angeli,[lxiii] la via detta “la via publica del Castello”[lxiv] discendeva lungo l’abitato, passando nelle vicinanze della chiesa di Santa Maria La Magna, che si trovava “in loco detto il Castello”,[lxv] e giungeva nelle prossimità della chiesa di Santa Maria dell’Olivella, luogo affacciante verso “lo ringo”,[lxvi] dove si diramava in due.
Un primo tratto si dirigeva alla porta detta “della Judeca”, per la quale transitava la via che conduceva a Mesoraca, dove giungevano anche “la istrada che scende dalla santiss.a nuntiata”[lxvii] e quella che proveniva dalle vicinanze della chiesa di Santa Maria delle Grazie.[lxviii]
Nel “loco ubi dicitur la Crocevia di S.to Nicolò delli Greci” (1641),[lxix] presso la detta chiesa parrocchiale, questa via incrociava la “viam publicam dittam delurmo”,[lxx] che percorreva la piazza, dirigendosi alla “porta della piazza”,[lxxi] posta sulle rupi vicino a luogo detto “la ruga delli Vitilli”,[lxxii] per la quale transitava la via che portava all’attraversamento del Tacina presso Roccabernarda. A questa via si congiungeva la “Strata nova”, ovvero la “viam quod escitur foris dittam terram”,[lxxiii] dopo essere transitata per “la porta nova”.[lxxiv]
![]()
Petilia Policastro (KR), la vecchia via che giungeva alla porta della piazza (dalla pagina fb I Ricordi dei “Petilini Emigranti”).
L’altro tratto, costituito dalla via pubblica “ditta delo ringo”,[lxxv] similmente al tracciato dell’attuale corso Roma, raggiungeva la porta della piazza percorrendo le timpe sovrastanti il “ringo”, che con i loro precipizi, munivano la parte settentrionale dell’abitato. Superata la piazza e continuando a seguire il tracciato dell’attuale corso Roma, questa via giungeva alla porta detta “di Santa Caterina”, da cui principiava la via che si dirigeva a Cutro, passando il fiume Tacina all’attraversamento posto presso l’abbazia e l’abitato di San Pietro di Niffi.
![]()
Petilia Policastro (KR), vista di corso Roma dalla piazza (dalla pagina fb I Ricordi dei “Petilini Emigranti”).
![]()
La viabilità urbana di Policastro agli inizi del Seicento afferente alle sue cinque porte: la “Porta del Castello” (A), la porta “della Piazza” (B), la “porta nova” (C), la porta “di Santa Caterina” (D), e la porta “della Judeca” (E). 1) San Nicola della Piazza (chiesa Matrice, arcipresbiterato), 2) SS.ma Annunziata detta “de Fora”, 3) Santa Maria delli Francesi, 4) Santa Caterina (esistente fino al terremoto del 1638), 5) San Pietro Apostolo (dopo il terremoto del 1638 detta di Santa Caterina), 6) Santa Maria delle Grazie, 7) Santa Maria la Nova, poi detta la SS.ma Annunziata Nova, 8) Santo Dimitri, 9) San Nicola dei Greci, 10) Sant’Angelo della Piazza, 11) Santa Maria dell’Olivella, 12) Santa Maria Magna, 13) Santa Maria degli Angeli, 14) San Nicola deli Cavaleri, 15) San’Angelo de lo Milillo.
La piazza
L’esistenza di un “akroterio pubblico” (άκρωτήριον τώ διμωσιακών), luogo sommitale della “terra” di Policastro esistente presso la chiesa “Matrice” di San Nicola,[lxxvi] dove convergevano e s’incrociavano le due vie principali che attraversavano il territorio, risulta documentata già verso la fine del sec. XII,[lxxvii] continuando ad evidenziarsi verso la fine del periodo medievale, quando questa parrocchiale compare con il titolo di “S. Nicolai de Plateis”.[lxxviii]
I documenti della seconda metà del Cinquecento, c’informano che nel luogo detto la “piazza”, posto nelle vicinanze della “porta della piazza”, dove era stato fabricato “lo mezarulo”[lxxix] per misurare la quantità di cereali, legumi ed altre granaglie vendute in quest’area mercantile, si trovavano le botteghe,[lxxx] come continuano a documentare gli atti della prima metà del secolo successivo, riguardanti il convicino della chiesa Matrice,[lxxxi] che menzionano la “spetiariam” di Hijeronimo Poerio confinante con la “potecam” della confraternita del SS.mo Sacramento,[lxxxii] e le due “potighe” di Sansone Salerno, che confinavano con quella di Salvatore Traijna.[lxxxiii]
![]()
Il “Mercato della Domenica” nella piazza di Petilia Policastro (da www.diasporapetilina.it).
Una di queste botteghe di Sansone Salerno, ossia quella confinante con la “potica” appartenente al monastero di Santa Maria della Spina, passò in seguito a Jacinto Misiano.[lxxxiv]
La bottega di Jacinto Misiano, quella di Gio: Dom.co Campana, e quella di Petro Ant.o Scandale che andò a suo genero Gio: Petro Levato,[lxxxv] assieme a quelle di Scipione Romano e Giulio Berricello, si trovavano nel luogo detto più precisamente, “l’astrachello della piazza”, posto in convicino della chiesa Matrice e nelle vicinanze della chiesa di Sant’Angelo della Piazza e della “ruga delli vitilli”, che confinava con una domus “Cum Camera” che Mutio Campana vendette a Joannes Paulo e Laurentio Caruso.[lxxxvi]
![]()
Petilia Policastro (KR), la piazza (dalla pagina fb I Ricordi dei “Petilini Emigranti”).
Il detto luogo confinava anche con il “palazzettum” di Jacinto de Cola che, nella parte inferiore, era costituito dalle “potiche” di Petro Ant.o Scandale, Gio: Dom.co Campana, Scipione Romano e Giulio Berricello mentre, nella parte superiore, vi era un “Cammarozzum” che, assieme a “l’aria di sopra di dette potiche”, il detto Jacinto vendette al clerico Joannes Fran.co Cepale.[lxxxvii] Agli inizi del Seicento “l’astrachello”, ovvero la “platea publica quod dicitur dell’astrachello”, era uno dei luoghi pubblici consueti di Policastro, dove avvenivano i bandi pubblici e gl’incanti dei beni dei debitori che erano posti all’asta per ordine della Curia.[lxxxviii]
![]()
Petilia Policastro (KR). In evidenza l’area in cui sorgeva la piazza pubblica detta “dell’astrachello”.
Lo spazio ed il tempo
Oltre a rappresentare il luogo in cui avveniva l’attività di scambio, la “platea publica” o “Piazza publica”, era il luogo solito e consueto dove, per tre giorni continui, il servente della Corte di Policastro, “Conforme il Costume della Città p(rede)tta”, provvedeva a bandire pubblicamente la compilazione degl’inventari e la vendita dei beni dei debitori, e dove si accendeva la candela in occasione degl’incanti.[lxxxix]
Più in generale, la piazza pubblica era il luogo destinato a tutte le pubbliche congregazioni, come avveniva in occasione delle elezioni e delle altre deliberazioni assunte comunitariamente dall’università dei cittadini quando, preceduti da “bannis, et pulsata Campana more solito pro conmitiis generalibus”, il sindaco, il mastrogiurato, gli eletti ed i cittadini, si congregavano nelle case o “sala” della Corte di Policastro[xc] posta nella piazza, alla presenza del capitano o governatore regio.[xci]
![]()
Petilia Policastro (KR), la piazza (dalla pagina fb I Ricordi dei “Petilini Emigranti”).
Dovendo assolvere a queste funzioni pubbliche nei confronti della cittadinanza, fornendo a tutti la misura del tempo legalmente riconosciuta, questa campana o orologio pubblico, doveva essere mantenuta a spese dell’università, che doveva contribuire anche alla riparazione del suo campanile, come ribadiva l’arcivescovo di Santa Severina già alla metà del Cinquecento,[xcii] avendo comunque l’onere di provvedere alle spese relative al suo funzionamento, come riferiscono i conti universali del 1647, attraverso i quali sappiamo che l’università di Policastro, spendeva annualmente 7 ducati per la “manutenzione dell’orologio”,[xciii] anche se, qualche anno dopo, risultava che questo si trovava fermo e non suonava.[xciv]
Esso era stato realizzato nelle immediate vicinanze della chiesa Matrice di San Nicola che, dalla parte delle “Rupes dictae Civitatis”, confinava, via mediante, con le case di Ippolita Zurlo che, a sua volta, confinavano anche con la casa degli eredi del quondam Marco Antonio Fanele ed i casaleni dell’olim Agostino Cavarretta.[xcv] Dalla parte opposta, “la detta chiesa” confinava con una “continentia di case con orto contiguo” appartenenti alla dote di Julia Rizza, che si trovava “circondata di quattro parti di vie publiche” e confinava con la casa di Gregorio Bruno e la casa del chierico Gio: Gregorio Rizza.[xcvi]
Da questa parte si trovava la “Campanacciam publicam”. Sappiamo infatti che la casa di Gregorio Bruno, posta in parrocchia della chiesa matrice, confinava con la casa degli eredi del quondam Joseph Caputo, vinella mediante,[xcvii] e quest’ultima confinava con la casa di Ferdinando Cappa e la casa di Fragostina Campana[xcviii] o Fragostina Ferraro “alias Campanacciam publicam”.[xcix]
![]()
Petilia Policastro (KR), campanile della chiesa Matrice.
L’ulmo vecchio e l’ulmo novo
Rispetto a questa situazione che traeva origine dall’assetto dato al luogo fin dall’età medievale, a seguito della ricomposizione urbana dell’abitato, l’estensione della “plateam” definita dal Mannarino “la Piazza Maggiore”,[c] fu mutata, come ci segnala l’apparire dei toponimi “l’ulmo vecchio” nella seconda metà del Cinquecento,[ci] e “l’ulmo novo”, documentato durante la prima metà del Seicento,[cii] periodo in cui compare anche il toponimo la “sala nova”.[ciii]
La presenza di un olmo nella piazza degli antichi abitati, dove gli affari e le adunanze pubbliche potevano svogersi al riparo del rigoglioso fogliame della sua chioma, risulta documentato in genere già nel Medioevo,[civ] come risulta anche nel Crotonese attraverso documenti posteriori.[cv]
![]()
Olmo campestre, Ulmus minor Mill.
Agli inizi del Seicento, il luogo di Policastro destinato all’ufficialità contraddistinto dalla presenza di quest’albero, dall’area antistante la chiesa Matrice e la chiesa di Sant’Angelo della Piazza, era stato traferito in un luogo più centrale, dove sorgevano le chiese di San Nicola dei Greci e di Santo Dimitri, e dove giungevano i confini della parrocchia di San Pietro.[cvi]
Qui, dove passava la “viam publicam dell’ulmo”,[cvii] si trovavano la domus palaziata posta “accanto l’ulmo”, che Ottavio de Pace donò a suo figlio Santo,[cviii] e la “sala” o “palatium”,[cix] dove risiedeva il capitano o governatore di Policastro.[cx] In relazione a ciò, il luogo era anche detto “dell’ulmo della Sala”,[cxi] e la via pubblica era anche chiamata la “viam publicam dittam la sala seu piazza”.[cxii]
In ragione della formazione di questo nuovo baricentro urbano, troviamo qui un’altra parte della struttura commerciale di Policastro che, integrandosi a quella esistente nelle prossimità della Matrice, aveva diramazione lungo l’asse stradale principale che discendeva dalla porta del castello.
In convicino di San Nicola dei Greci vi erano “la potica” di Betta Mazzuca[cxiii] e quella di Dominico Amannato,[cxiv] mentre, la “Potecam” del “publico mercante” Francesco Curto, esistente nelle case di Pietro Curto, era posta verso il confine parrocchiale con la chiesa Matrice.[cxv]
In quest’area centrale dell’abitato, altre botteghe si trovavano in convicino della SS.ma Annunziata nova,[cxvi] chiesa posta entro i limiti parrocchiali di San Nicola dei Greci, tra cui quella di Joannes Thoma Richetta posta “in loco ubi dicitur lo fumarello”[cxvii] che, successivamente passò a Joannes Carvello[cxviii] mentre, nelle vicinanze della chiesa di Santo Dimitri, esistevano “la potica” di Gio: Baptista Natale,[cxix] e quella di Vespesiano Pantisano.[cxx]
![]()
Petilia Policastro (KR), panoramica della piazza.
Le forge
Nei pressi esistevano anche le forge. La forgia del magister Francesco Conmeriati era posta in una casa terranea sita nelle vicinanze della chiesa di Santo Dimitri,[cxxi] e di quella di San Nicola dei Greci,[cxxii] nei pressi della piazza, nel luogo dove giungevano i limiti convicinali della Matrice,[cxxiii] e dell’altra parrocchiale di San Pietro. Dopo la morte del detto mastro, quando sappiamo che Joannes Dom.co Cavarretta de Nardo cercava di avviarsi a questa attività,[cxxiv] la sua vedova Andriana Rizza e suo figlio chierico Joannes Conmeriati, vendettero questa forgia al magister Petro Ercole della terra di Giffoni ma abitante in Policastro, avendo sposato Rosa Ceraldo.[cxxv] Quest’ultimo però, dopo averla migliorata sopraelevandola, in seguito dovette lasciarla, quando il detto chierico Joannes e sua madre, trovarono un nuovo accordo con il notaro Gio: Leonardo de Pace.[cxxvi] Successivamente, quest’ultimo la cedette a Stefano Apa.[cxxvii]
Nel frattempo aveva già avviato la sua attività di mastro forgiaro, Francesco Conmeriati de Silvestro, che possedeva una “forgia” in parrocchia di San Nicola dei Greci.[cxxviii] Dopo la sua morte l’attività della sua forgia fu dismessa.[cxxix]
In questo periodo ed in quest’area, abbiamo notizia di un’altra “forggia” esistente nelle vicinanze della chiesa di S.to Nicola “Grecorum”, appartenuta al quondam Baptista Mazzuca,[cxxx] (il quale esercitava quest’arte, come si dimostra nell’occasione in cui compare come apprezzatore dei miglioramenti fatti dal “mastro” Petro Ercole nella sua forgia),[cxxxi] e di un’altra in convicino della SS.ma Annunziata, posta nel basso della casa palaziata di Nardo Spinello.[cxxxii]
Un’altra forgia si trovava nella parte alta dell’abitato, in convicino della chiesa di Santa Maria degli Angeli,[cxxxiii] mentre, in convicino di Santa Maria la Grande, esisteva la bottega di Petro Carvello che passò a Santo Misiano,[cxxxiv] il quale la diede in dote a sua figlia Joannella.[cxxxv] Nelle vicinanze della chiesa di Santa Maria dell’Olivella, risulta documentata l’esistenza della bottega di Joannes Vittorio Caccurio che passò a suo figlio Joannes Fran.co,[cxxxvi] e quella di Joannes Vincenzo Rizza.[cxxxvii]
![]()
Petilia Policastro (KR), la ferratura di un mulo (dalla pagina fb I Ricordi dei “Petilini Emigranti”).
Una struttura antropomorfa
Conferma la situazione che possiamo ricavare dalla documentazione seicentesca, la descrizione fornitaci dal padre Mannarino agli inizi del Settecento, il quale assimilava la Policastro di quel tempo alla figura umana, le cui “membra” gli sembrava facessero capo alle cinque porte esistenti nelle mura della sua “Città”:
“La Città poi tiene cinque Porte, quasi che in altretante membra principali si divida il suo Corpo, e par che faccia Capo dalla prima Porta detta del Castello ad occidente per cui scendendo giù, viene primieramente à far quasi due braccia. Il destro si stende pendendo sino al Ghetto, ch’era anticamente delli Giudei; ov’è la Porta chiamata apposta della Giudea nella parte Australe, e nell’Aquilone risponde l’altro braccio alla terza Porta di rimpetto la Piazza maggiore. Altretanto poi come in due Piedi termina il resto dell’Aquilone nella nuova Porta de’ Francesi, ov’era il Quartiero di quella Nazione, dall’Austro nella quinta Porta di Santa Caterina, che più ferisce all’oriente, lungo le Mura di quel vecchio Tempio ad’essa Santa Vergine, e Martire consagrato; in cui dal misero avanzo dell’archi, latitudine, longitudine, sepolcri, sito, è di tutta la circonferenza, s’argomenta la di lui grandezza”.[cxxxviii]
Note
[i] Rende P., Vicende Feudali della “terra” di Policastro (sec. XI-XV), in www.archiviostoricocrotone.it
[ii] Il presente lavoro confuta le principali conclusioni di un mio scritto precedente (La Provincia KR, 25/2003) riguardante l’urbanistica di Petilia Policastro basato, analogamente ad altri riguardanti diversi centri del Crotonese che ho pubblicato in quel periodo, sull’interpretazione della fotografia aerea. In quella occasione, al fine di testare la metodologia adottata basata sulla fotointerpretazione, non mi sono avvalso di documenti storici, ma solo di qualche notizia già edita.
[iii] Rende P., La formazione del territorio Crotonese: dalla “chora” dei Brettii ribelli fino alle “terre” del “Marchesato” (sec. I-XIV), in wwwarchiviostoricocrotone.it
[iv] Parthey G., Hieroclis Synecdemus et Notitiae Graecae Episcopatuum, 1866, p. 126. Russo F., La Metropolia di S. Severina, in Scritti Storici Calabresi, C.A.M., Napoli 1957, pp. 43 e sgg.
[v] Russo F., La Metropolia di S. Severina, in Scritti Storici Calabresi, C.A.M., Napoli 1957, pp. 52-54.
[vi] Rende P., La formazione del territorio Crotonese: dalla “chora” dei Brettii ribelli fino alle “terre” del “Marchesato” (sec. I-XIV), in www.archiviostoricocrotone.it
[vii] Goffredo Malaterra, De Rebus Gestis Rogerii Comitis, in Muratori L. A., Rerum Italicarum Scriptores, Zanichelli N. Bologna s.d., tomo V parte I, p. 47.
[viii] Guillou A., Les Actes Grecs des Fonds Aldobrandini et Miraglia XI-XIII s., Biblioteca Apostolica Vaticana 2009, pp. 51-53; 60-62; 63-65; 66-70. Pratesi A., Carte Latine di Abbazie Calabresi provenienti dall’Archivio Aldobrandini, Biblioteca Apostolica Vaticana 1958, pp. 348-350; 354-356. De Leo P. (a cura di), Documenti Florensi 2001, pp. 146-147; 152-154.
[ix] Guillou A., Les Actes Grecs des Fonds Aldobrandini et Miraglia XI-XIII s., Biblioteca Apostolica Vaticana 2009, p. 66-70.
[x] “Che di quel gran Castello si à sicura memoria, ò ch’egli dilatato si fosse in Città, ò che la Città ristretta in lui, egli è ben vero dà due cento anni trecento anni avanti, di trovarsi menzione di lui e del suo Castellano, specialmente nell’Istrumento del Posesso, che dona la Città alli Padri osservanti del loro Convento oggi detto della SS.ma Spina, dove sono firmati oltre a dodici Parochi della Città, il Magistrato, e più particolari Patrizii, come oltresi Il Capellano, e Castellano del d.o Castello, qual Istrumento si conserva nel Archivio registrato da me, ed è in Carta Pergamena col Sigillo pendente di mano quasi Gotica. Ed ultimamente in un Inventario fatto sub l’anno mille cinquecento venti d’ordine di Carlo Quinto Imperadore à pro del Conte di Santa Severina Andrea Caraffa; sta posto il Castello per Capo, non sò se unito, o diviso dà tutto il Corpo cossi: Ista sunt bona Demanialia Curiae, et feudi, Terrae Policastri inventa, et reperta in dicto Castro, et eius pertinentiis videlicet In primis Castrum dirutum cum pertinentiis suis, cum apparentia, et evidentia fossi dicti Castri, ac Vestigiorum, et edificiorum ipsius in capite terrae praedictae versus occidentem.” “La forma della Città è due parti lunga e una larga, quasi in figura di Cilindro, ma distorto alquanto e fuorche nella parte occidentale, ove era già il famoso e superbo Castello, …” (Mannarino F. A., Cronica della Celebre ed Antica Petilia detta oggi Policastro, 1721-1723).
[xi] Rende P., La chiesa “Matrice” di San Nicola “de Policastro” nel luogo detto “la Piazza”, in www.archiviostoricocrotone.it
[xii] www.archiviodistato.firenze.it
[xiii] Rende P., La parrocchiale di Policastro intitolata a Santa Maria “Magnae”, poi detta “Maggiore”, nel luogo detto “il Castello”, in www.archiviostoricocrotone.it
[xiv] 27.07.1649. Giovanni Carvello vendeva al D.r Lutio Venturi, l’annuo censo di carlini 30 per un capitale di ducati 30 sopra i frutti dei suoi beni, tra cui una “Casa Palatiata cum Camera terranea contiqua”, posta dentro la terra di Policastro nel convicino della chiesa parrocchiale di “S.ta Maria la grande nel loco dove si dice lo Castello”, confine le case degli eredi di Antonino Polla, le case di Gio: Dom.co Grano, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio F. Cerantonio, Busta 196 prot. 876, ff. 048v-050). 05.10.1660. In occasione della sua visita ai luoghi pii di Policastro, l’arcivescovo Francesco Falabella visitò la chiesa parrocchiale “vulgo detta la Magna” posta “in loco detto il Castello” (AASS, 37 A).
[xv] 21 aprile 1418. “Abbati monasterii S. Angeli de Frigillo, S. Severinae dioc., mandat ut Spiritui Brunecto, presbytero S. Severinae dioc., provideat de parochiali ecclesia S. Mariae Magnae de Policastro, eiusdem dioc., vac. per ob. Antonii Veca rectoris.” (Russo F., Regesto II, 9420).
[xvi] Rende P., Alcune chiese scomparse di Policastro poste entro le mura, in www.archiviostoricocrotone.it
[xvii] Mannarino F. A., Cronica cit., 1721-1723.
[xviii] 12.06.1630. Atto rogato in Policastro “et prop.e in castro deruto ditte Ci”. Il notaro si porta “in castro sup(radi)tto” per la stipula del testamento di Marco Antonio Guarano U.J.D. (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 297, ff. 115-116).
[xix] 23.09.1636. Isabella e Berardina Faraco, figlie del quondam Lutio Faraco, assieme a Faustina Coria, vendevano a Martino Vecchio, un ortale arborato con due “pedis sicomorum” e tre “pedis ficis”, posto “intus praedittam Civitatem ubi dicitur lo castello”, confine il “trappitum” del presbitero Joannes Andrea Alemanno, le “ripas della difesa muro Coniuntum dittum lo castellum”, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 303, ff. 126v-127v). 06.08.1643. Nel suo testamento, Martino Vecchio lasciava a suo figlio Fausto Vecchio, l’orto posto nel loco “dove si dice il castello”, confine “lo tappito” del R. D. Gio: Andrea Alemanno, “le ripe della difesa”, la via pubblica, ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 307, ff. 036-037v). 17.03.1645. Martino Vecchio prendeva in prestito dal pio Monte dei Morti eretto dentro la chiesa parrocchiale di San Nicola “Grecorum”, 50 ducati di liquidità provenienti dalle elemosine, impegnandosi a pagare un censo del 10 % con potestà affrancandi e redimendi. Il detto Martino garantiva il prestito ricevuto con tutti i suoi beni, tra cui l’ortale “arboratum sicomorum” posto dentro la terra di Policastro loco detto “lo Castello”, confine il “Tapetum” del Rev.s D. Jo: Andrea Alemanno, le “Rupas dictas Civitatis” ed altri fini (ASCZ, Notaio G. M. Guidacciro, Busta 182 prot. 804, ff. 038v-043v).
[xx] 29.10.1617. Joannes, Gerolimo e Vittorio Tuscano, quali eredi testamentari di Nardo Tuscano loro padre, si accordavano tra loro per spartirsi l’eredità paterna. Appartenevano a questa eredità: “lo casalino novamente fabricato inansi la morte di detto q.m loro padre”, posto dentro la terra di Policastro, nel convicino di S.to Nicola “delli Cavaleri”, confine l’altra casa ereditaria contigua, “et la via publica del Castello”, “muro coniunto alla Cammera di Vittorio”; “la casa dove al presente habita detto gerolimo contigua in detto loco della parte di sotto con la scala fabricatizza per la quale hanno l’intrata detti Giovanni, et Vittorio”; “l’ortali posti inansi detta casa sotto parte la via publica” con il peso annuo che si pagava al dottor Horatio Venturij, confine la casa di Fran.co Spinello, la casa che era appartenuta al quondam Gio: Laurenzo Venuto e che, al presente, possedeva Petro Frontera, confine la casa di Gianni Poerio ed altri fini; “lo casalino” che era appartenuto al quondam Mattio Vecchio che era stato acquistato dal detto Gianni con denaro comune (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 291, ff. 060-061v). 25.08.1620. Vittorio Tuscano vendeva a Joannes Battista Cavarretta, la domus palaziata con casalino contiguo, posta dentro la terra di Policastro nel convicino della chiesa di S.to Nicola “delli Cavaleri”, confine la domus di Joannes Tuscano, la domus di Hijeronimo Tuscano, il “largum dittum delo Castello”, ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 292, ff. 057-057v).
[xxi] 04.06.1653. Nel proprio testamento, il presbitero D. Jacobo de Aquila disponeva che “nella sua Chiesia” eretta sotto il titolo di “S. Jacomo”, posta dentro la terra di Policastro e “pp.o nel loco dove si dice il Castello”, potessero servire li RR. del Clero di Policastro tra cui il D.re Fran.co Rizzuto della terra di Mesoraca (ASCZ, Notaio F. Cerantonio, Busta 196 prot. 878, ff. 038v-039v). 02.08.1653. Il R. D. Gio: Jacomo Aquila asseriva di aver edificato, mediante licenza ottenuta dalla Corte arcivescovile di Santa Severina, una “Chiesia” sotto il titolo di “S. Giacomo Maggiore” posta dentro la terra di Policastro nel loco dove si dice “il Castello”, ovvero “nel Castello”, “contiqua” alle case di detto D. Gio: Jacomo, confine “lo largo di d.tto Castello” ed altri fini (ASCZ, Notaio F. Cerantonio, Busta 196 prot. 878, ff. 043-047v).
“Hor in questa Chiesa della SS.ma Annunziata, ch’è così ammirabile per lavoro, riguardevole per ricchezza, ed’inarrabile per designo, vi è a lato sinistro la Capella dell’apostolo San Giacomo assai ricca lavorata in oro, assai ricca, perché D. Giacomo Aquila che la fondò con Chiesa a parte innanti il largo del diruto Castello, contigua al suo nobil Palazzo, da dove fù qui poi trasportata;” Mannarino F. A., Cronica cit., 1721-1723.
[xxii] Pesavento A., Il feudo di Rivioti, in www.archiviostoricocrotone.it
[xxiii] Pellicano Castagna M., Storia dei feudi e dei titoli nobiliari della Calabria, IV, p. 147.
[xxiv] 19.02.1620. Nella “platea pub.ca” di Policastro. Joannes Dom.co Cappa, servente ordinario della regia curia di Policastro, dietro l’istanza dell’università ed in base agli ordini del duca di Nocera, poneva all’incanto i seguenti beni di Gio: Alfonso Cerasaro: “lo Vignale di detto Cerasaro posto loco ditto fora la Porta del Castello fù del q.m Gratiano Golia la timpa della serpe et Turretta et la possessione di paternise fù di Fran.co Ant.o fanele” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 292, ff. 032-032v). 31.05.1620. Tra i beni che erano stati incantati nella pubblica piazza a Gio: Alfonso Cerasaro, in relazione ai suoi debiti nei confronti dell’università di Policastro, troviamo un vignale” detto il “vignale del Castello” della capacità di una tomolata circa, con un “pede di fico”, sito nel territorio di Policastro, loco detto “fora la porta del Castello”, confine “la timpa della serpe, et la via publica che si va a santa lucia” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 292 ff. 028v-039v; foto 549-559). 22.09.1620. In ragione del decreto del 18.09.1620 della Curia di Policastro, che dichiarava nulle le esecuzioni e le vendite di alcuni possedimenti di Joannes Alfonso Cerasari, perché effettuate “ultra Creditum” vantato nei confronti di detto debitore, alla data odierna, quest’ultimo era reimmesso nel pieno dei beni che erano stati oggetto dell’esecuzione, tra cui il “vinealis estramenia, et porta del Castello” di 1 tomolata e mezza alberato “cum uno pede ficis” posto nel territorio di Policastro, loco detto “fora la porta del Castello” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 292, ff. 062v-063). 20.12.1620. Fran.co Ant.o Fanele, nel passato, essendo venuto in accordo con Fabritio Scoraci, aveva acquistato all’incanto, con denaro comune, un vignale posto nel territorio di Policastro “fora la porta del Castello di detta Citta”, alberato con “un pede di fico”, confine “la via publica che si va a santa lucia confine la difisa esecuta contra Gio: Alfonso Cerasaro” dall’università di Policastro. Successivamente il bene, era stato venduto a D. Gegnacovo de Aquila ed il ricavato era andato in beneficio comune della “sotieta” costituita tra il detto Fran.co Ant.o ed il detto Fabritio. All’attualità il detto Fran.co Antonio cedeva la sua metà al detto Fabritio (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 292, ff. 086v-087). 22.06.1622. Antonio Fanelis è immesso nel possesso dei beni già appartenuti a Joannes Alfonso Cerasari, tra cui il vignale posto nel territorio di Policastro, loco detto “fora la porta del Castello”, confine la “timpam della serpe”, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 294, ff. 031-032). 16.07.1622. Le terre dette “petra dello trono timpa della serpe, et santo martino seu santa lucia fora la porta del Castello” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 294, ff. 032v-033v). 16.07.1622. Loco detto “la timpa della serpe terre dello trono, et santa lucia”. I pezzi di terra detti “la serpe, petra dello trono, et Sansanta lucia”, confine la via pubblica “quod vaditur in montanea”, la via che “dicinditur in molendino de cerratullo”, la “difensam” di Joannes Alfonso Cerasari, il vignale del presbitero Joannes Jacobo de Aquila ed altri fini. Le terre dette “petra dello trono timpa della serpe, et santo martino seu santa lucia fora la porta del Castello” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 294, ff. 033v-035). 17.01.1624. Le terre dette di “Santo Martino, Petra dello trono, et timpa della Serpe tutto in uno medesimo loco”, confine “santa lucia”, Gori Mazzuca, “le terre della difisa” di detto Alfonso Cerasaro ed altri confini. Il “cugnale fora la porta del Castello di detta Citta”, confine “la timpa della Serpe”, “la via publica che si va in santa lucia et la via di sotto le mura della citta”. (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 295, ff. 007-007v). 02.05.1624. Dietro la richiesta di Fran.co Antonio Fanelis, Laurentio Ceraldo, ordinario servente della regia Curia di Policastro, in vigore delle provvisioni contro Joannes Alfonso Cerasaro, alla presenza del notaro, provvede ad immettere il richiedente nel possesso dei beni del detto Joannes Alfonso, tra cui il vignale posto nel territorio di Policastro “in loco ubi dicitur fora la porta del Castello”, confine “la timpa della difisa et la via publica che si va verso santa lucia” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 295, ff. 027-027v). 05.09.1639. Dietro l’istanza dei Cl.ci Scipione e Marcello Tronga, figli ed eredi del quondam Gio: Thomaso Tronga, il notaro si porta nel loco detto “fora la porta del Castello di detta Città di Policastro” dove, i detti de Tronga, dando seguito alla volontà testamentarie del loro padre, consegnano al reverendo fra Bartolo “di longo vucco”, “guardiano” del venerabile “monasterio di nostra donna delle manche” dei Riformati, 28 “Jovenchi” di anni 3 in 4, ed altri 8 di anni 2 in 3 (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 306, ff. 094-094v). 30.11.1653. Il presbitero Joannes Jacobo de Aquila vendeva ad Aloisio Vicinanso, il “Vineale” della capacità di circa 1 tomolata e ½ posto nel territorio di Policastro loco detto “fora la porta del Castello”, confine le terre degli eredi del quondam Jo: Alfonso Cerasaro, le terre dette “la difesa”, le terre di Romolo Ettore, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio F. Cerantonio, Busta 196 prot. 878 ff. 081v-083).
[xxv] “La forma della Città è due parti lunga e una larga, quasi in figura di Cilindro, ma distorto alquanto e fuorche nella parte occidentale, ove era già il famoso e superbo Castello, per cui si esce in piano, pendendo un poco per una inselciata, come che pieni i fossi delle dirupate muraglie, ci si trova immediatamente il Fiume con due Case di molino;” In relazione all’orto posseduto dalla corte di Policastro, il Mannarino afferma: “Tra tutti si singolarizza quello dell’Eccellentissima Corte ch’è il Capo nel più vicino e meglior immediato luogo alla Città, per detta Porta per cui come dissi s’esce in piano.” Mannarino F. A., Cronica della Celebre ed Antica Petilia detta oggi Policastro, 1721-1723.
[xxvi] 29.02.1613. Nel proprio testamento, Joannes Faraco lasciava erede il proprio figlio D. Gio: Thomaso, dei gelsi posti nel loco detto “lo ringo”, confine i gelsi di Pagano, il gelso di S.ta Dominica, le “porghe di sotto le mura di s.ta Maria della grande”, i gelsi del quondam Fran.co Ant.o Leusi, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio Ignoto di Policastro, Busta 81 ff. 37-40). 15.11.1616. Davanti al notaro comparivano Vespesiano Blasco, tutore ed “avus Maternus” di Andriana Leusi, figlia del quondam Fran.co Antonio Leusi, e Joannes Dominico Pantisano della città di Crotone, padre di Peleo Pantisano, per la stipula dei capitoli relativi al matrimonio tra il detto Peleo e la detta Andriana. Apparteneva alla dote la “continentia di celsi” posta nel territorio di Policastro loco detto “lo ringo”, “iusta le mura della citta”, i gelsi del notaro Fran.co Accetta, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 290, ff. 146v-155v). 15.08.1643. Nell’elenco dei beni appartenenti alla dote di Laura Blasco che, nei mesi passati, aveva sposato Horatio Ferrari della città di Catanzaro, figurava una “continentia di Celsi” loco detto “lo ringo”, “posta à canto le mura di detta Città” (ASCZ, Notaio G. M. Guidacciro, Busta 182 prot. 802, ff. 070-071). 24.07.1644. Francisco Greco che ne possiede una metà, ed i coniugi C. Juliano Zagaria ed Elisabeth Greco, che ne possiedono l’altra metà come “robba dotale”, vendevano a Bernardino Lomoijo di Policastro, la “continentia di Celsi” posta nel loco detto “lo ringo”, confine i gelsi di Masi Ammerato, i gelsi di Gio: Berardino Accetta, “le mura di questa Città” ed altri fini (ASCZ, Notaio G. M. Guidacciro, Busta 182 prot. 803, ff. 072v-074v).
[xxvii] 13.07.1606. Si riportano i capitoli matrimoniali relativi al matrimonio tra Hijeronimo Carise e Livia Zupo stipulati il 05.01.1596 per atto del notaro Joannes Berardino Campana. Nella dote della sposa risultavano le terre “dello ringo seu porticella”, alberate con gelsi ed olive, confine i beni di messer Ant.no Cepale e del quondam Laurenzo Bruna, i beni di S.ta Dominica ed altri confini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78, prot. 286, ff. 173-176). 25.09.1632. Davanti al notaro comparivano Andrea Jerardo e Joannes Thoma Scandale, marito di Portia Blasco, assieme ad Antonino Gatto. Nei giorni passati, detto Antonino aveva venduto a detto Andrea, “la possessione della porticella” posta nel territorio di Policastro, confine i beni di Alfonso Campitello, “la via publica che si va in santa dominica” ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 299, ff. 079-080). 18.06.1635. Negli anni passati, Anna Cavarretta e suo marito Antonino Gatto, oppressi dai creditori e per potersi alimentare, avevano venduto ad Andria Jerardo, previo regio assenso, la loro possessione arborata con più e diversi alberi, posta nel territorio di Policastro dove si dice “la porticella”, confine i beni di Horatio Rocca, i beni di Alfonso Campitello, le terre di Santa Dominica, i beni di Pauli de Albo e la via per la quale “itur ad fontem ditte sante dominice” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 302, ff. 054-056v). 18.06.1635. Ratifica della vendita fatta nei confronti di Andria Jerardo, della possessione appartenuta ad Antonino Gatto, posta “estramenia ditte Civitatis” loco detto “la porticella” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 302, ff. 056v-058).
[xxviii] ASCZ, Notaio G. M. Guidacciro, Busta 182 prot. 806, ff. 011v-016.
[xxix] “È questa chiesa appunto situata dentro il Circulo della stessa Parocchia immediatamente Posta à mezzo giorno, à differenza dell’altra chiesa dell’Annunziata detta di Fuora, che diroccatasi l’anni passati proprio nel fine del caduto secolo con tutte le sue pertinenze per ordini di Monsig.r Berlingieri è stata mutata di sito, e dà sotto le mura della Città in bocca alla Porta della Città è stata trasportata nell’antica di Santa Maria delli Francesi, che smantellata tutta la vecchia, con nuovo è più bel modello refabricatasi da fondamenti, apparisce più vasta.” Mannarino F. A., Cronica della Celebre ed Antica Petilia detta oggi Policastro, 1721-1723.
[xxx] La porta compare in alcuni atti notarili della prima metà del Seicento. 16.09.1613. Il chierico Joannes Fran.co Arcomanno e Joannes Vincenso Callea, in qualità di eredi del quondam Michele Arcomanno, possedevano in comune ed indiviso alcuni beni, tra cui: il “petium terrae arboratum sicomorum situm, et positum ante Januam Nove seu timpa oleastri viam publicam ex duobus lateribus et vinealem quod fuit q.m laure coco”, ovvero “lo vignalicchio arborato di Celsi posto loco ditto porta nova” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 288, ff. 098-099v). 13.09.1633. Davanti al notaro comparivano il Cl.o Micaele Callea ed il presbitero D. Joannes Andrea Romano. Il quondam Joanness Vincenso Callea, padre del detto Cl.o Micaele, aveva pignorato al detto D. Joannes Andrea un “ortalem arboribus sicomorum arboratum”, posto nel tenimento di Policastro, “ubi dicitur fora la porta nova di detta Citta”, confine i beni di Joannes Matteo Guidacciro, la “ripam oleastri”, le vie pubbliche da due lati ed altri fini. Al presente detto Micaele, venuto ad un accordo, lo vendeva a detto D. Joannes Andrea (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 300, ff. 063v-064v). 16.03.1638. Joannes Dom.co Campana vendeva al Cl.co Hyeronimo Mendolara, il “Casalino scoverto” posto dentro la terra di Policastro, nel convicno della chiesa di S.ta Maria “delli fransisi”, confine la domus di detto Hyeronimo, un altro casaleno di detto Joannes Dom.co, dalla parte superiore, e la via pubblica, “et pp.o lo casalino che vie la porta al p(rese)nte” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 305, ff. 031-031v). 20.08.1646. In occasione della stipula del proprio testamento, il R. presbitero Jo: And.a Romano disponeva che, maritandosi Maria Guidacciaro, sua nipote e figlia di detta erede, le toccasse il vignale arborato di “Celsi” posto dove si dice “Porta nova, seu la Conicella”, sito nel distretto di Policastro. Lasciava il frutto del vignale di “Porta nova”, che era appartenuto a Gio: Vincenso Callea, a Veronica e Ber.na Grandinetto per due anni continui ciascuna (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 307, ff. 096v-098v).
[xxxi] ASCZ, Notaio G. B. Guidacciaro, Busta 78 prot. 288 ff. 098-099v.
[xxxii] ASCZ, Notaio G. B. Guidacciaro, Busta 79 prot. 300 ff. 063v-064v.
[xxxiii] ASCZ, Notaio G. B. Guidacciaro, Busta 78, prot. 286 ff. 161v-162v e ff. 208-208v.
[xxxiv] ASCZ, Notaio G. B. Guidacciaro, Busta 80 prot. 305 ff. 031v-033; Busta 78 prot. 290 ff. 010-010v.
[xxxv] 04.08.1604. Testamento di Minica o Minicella Scavino, abitante nella casa di Laura Scavino “intus p(raedi)ttam terram in Convicino s.tae Catarinae iusta domum fran.ci paudari viam publicam et alios fines” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78, prot. 286, ff. 26-27). 12.08.1604. Testamento di Vittoria Palatio, abitante “intus p(raedi)ttam terram in Convicino s.tae Caterinae iusta domum D. Dom.cii Palatii justa domum Lupii pecori et alios fines” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78, prot. 286, ff. 40-41). 12.11.1604. Testamento di Andriana de Conte, abitante “in convicino Ecclesie sante Caterine”, confine la domus di Vergilio Catanzaro, via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78, prot. 286 ff. 220-220v). 27.11.1604. Testamento di Diana Caccurio della terra di Mesoraca, moglie di And.a Caruso, abitante in Policastro “in Convicino sante Caterine”, confine la domus della venerabile chiesa di S.ta Caterina, il casaleno del presbitero Joannes Dom.co Catanzaro, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78, prot. 286 ff. 223v-224). 21.02.1605. Joannes Palatio dona al Cl.o Joannes Francesco Palatio suo figlio, alcuni beni, tra cui una casa palaziata posta nella terra di Policastro “in Convicino ecclesie s.te Caterine iusta domum Pr. Donni Dom.ci palatii cioè la casa de fora” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78, prot. 286, ff. 91-92). 21.03.1605. Testamento di Gregorio Ammerato, abitante dentro la terra di Policastro “in Convicino Ecclesie sante Caterini”, confine la domus di Marco Inbriaco, il casaleno di D. Joannes Dom.co Catanzaro, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78, prot. 286 ff. 232-232v). 25.09.1605. Davanti al notaro si costituiscono Hijeronimo de Maijda “alias lo mantuto” e Marco Imbriaco, per il matrimonio tra il detto Marco e Lucretia de Maijda, figlia del detto Hijeronimo. Gioanna de Maijda “alias la mantuta”, zia della sposa, le donava una “casa terrana” posta nella terra di Policastro nel convicino della chiesa di S.ta Caterina confine la casa di Gioallupo Pecoro e Masi Luchetta, la via pubblica ed altri confini. Nel medesimo loco della casa promessa, si trovava anche la casa di detta Giovanna, cioè la casa di S.ta Caterina (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78, prot. 286, ff. 136-137v). 30.10.1605. Joannes Fran.co Corigliano vende a Cesare Truscia, un “casalenum” posto dentro la terra di Policastro “in convicino ecclesie venerabilis s.te Caterine justa ortum Franci Paudari, et Jo(ann)is petri bonacci, et viam publicam et alios fines” (ASCZ, Notaio G.B. Guidacciro Policastro, Busta 78, prot. 286 ff. 143-143v; parte seconda foto 144-145). 23.04.1606. Caterina Ardano vedova del quondam Matteo Fortini, vende a Vergilio Catanzaro un “Casalenum” posto nella terra di Policastro “in Convicino Ecclesie s.te Caterine iusta ortum ipsius Vergilii, et ortum Jo(ann)is Marie prantedi, et domum ditte Caterine venditricis, viam publicam et alios fines (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro Policastro, Busta 78, prot. 286, ff. 164v-165v). 25.08.1606. Salvatore Levati vende al presbitero D. Dominico Palatio, il casaleno posto nella terra di Policastro “in convicinio Ecclesie s.te Caterine”, confine la domus di detto Salvatore, la domus del detto presbitero D. Domenico, il casaleno di Hijeronimo de Maijda “alias lo mantuto”, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78, prot. 286, ff. 191v). 10.09.1606. Hijeronimo de Maijda “alias lo mantuto”, Gioanna de Maijda sua sorella e Marco Inbriaco suo genero, in solidum, vendono a D. Dom.co Palatio un “casalenum” posto dentro la terra di Policastro “in Convicinio ecclesie s.te Caterine”, confine il casaleno e la casa del detto D. Domenico, la domus di Masi Luchetta, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78, prot. 286, ff. 199v-200v). 17.07.1607. Hijeronimo Lamanno vende a Vergilio Catanzaro, la “domum palatiatam” posta dentro la terra di Policastro, “in Convicinio Ecc.e sante Caterine”, confine un’altra domus del detto Vergilio, il casalenum di Joannes Palatio, l’orto di Fran.co Paudari ed altri fini, insieme al “casalenum” posto nel loco predetto “ante ianua domus p(raedi)tta” e la via pubblica (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 287, ff. 028-029). 10.09.1608. Relativamente alla vendita effettuata da Hijeronimo Lamanno nei confronti di Vergilio Catanzario di una “domum palatiatam” posta dentro la terra di Policastro, in convicino della chiesa di S.ta Caterina, confine la domus di detto Vergilio, l’orto di Fran.co Paudari, ed altri confini, il detto Vergilio completa il pagamento del prezzo di vendita (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 287, ff. 101-102). 10.09.1608. Joannes Fran.co Russo vende a Hijeronimo Lamanno, la “domum terraneam” posta dentro la terra di Policastro, in convicino della chiesa di S.ta Caterina, confine la domus di detta chiesa, la domus di Agostino Romani “vinella mediante”, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 287, ff. 102-103). 04.01.1609. Testamento di Cornelia Pecoro, abitante nella “domum terraneam” posta nella terra di Policastro, nel convicino della chiesa di S.ta Caterina, confine la domus del presbitero Dom.co Palatio, la domus di Joanna Mantuta, la via pubblica ed altri fini. Lascia a Gio: Lamantuta, carlini venticinque sopra l’orto contiguo alla sua casa (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 287, ff. 159-159v). 11.01.1609. Testamento di Laura Taranto, abitante nella domus posta nella terra di Policastro, nel convicino della chiesa di S.ta Caterina, confine la domus di Caterine Dardano, ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 287, ff. 159v-160). 03.01.1618. Prospero Carrozza vende a Hijeronimo Lamanno, la domus palaziata con un “catoijo” dove si teneva paglia, posta dentro la terra di Policastro nel convicino della chiesa di S.ta Caterina, confine l’orto di Petro Paulo Serra “vallone mediante”, le domos della quondam Lucretia Turana, la via pubblica ed altri fini. La detta domus era stata acquistata dal detto Prospero dal quondam Joannes Battista Favari (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 291, ff. 076v-077v). 04.02.1618. Davanti al notaro si costituiscono i coniugi Salvatore Levato e Laura Cancello, assieme a Fran.co de Miglio, per la stipula dei capitoli relativi al matrimonio tra il detto Fran.co e Caterina Levato figlia dei detti coniugi. Appartenevano alla dote i beni lasciati dalla quondam Minichella Scavino, zia della futura sposa, tra cui una casa terranea posta dentro la terra di Policastro, nel convicino della chiesa di S.ta Caterina, confine la casa di Fran.co Paudari e la via pubblica da due parti (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 291, ff. 078v-081v). 04.05.1618. Il presbiter D. Dominico Palatio vende al servente Paulo Luchetta, la “domum terraneam” posta nella terra di Policastro nel convicino della chiesa di S.ta Caterina, confine la domus di detto Paolo “a parte inferiore”, il casalenum appartenuto al quondam Andrea Grispini, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 291, ff. 093v-094v). 15.09.1625. Il presbitero D. Joannes Baptista Favari, circa 12 anni prima, aveva venduto a Prospero Carrozza, una casa palaziata posta dentro la terra di Policastro nel convicino di S.ta Caterina. Il detto Prospero però non aveva pagato né era in condizione di farlo. Al presente, il detto presbitero vendeva detta casa a Fiore Palmeri, insieme con la metà dell’orto contiguo incluso “lo celso” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 295, ff. 142v-144). 18.09.1630. Il notaro si porta nella domus palaziata di Fiore Palmeri, posta dentro la terra di Policastro nel convicino di S.ta Caterina, confine la domus del presbitero Joannes Baptista Favari “dittam la turana”, l’orto di Petro Paulo Serra, la via convicinale ed altri fini, per stipulare il suo testamento (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 297, ff. 162v-163). 21.01.1631. Leonardo Caccurio vende a Paulo Venturo, la domus palaziata con orto contiguo dove era un “pede magno sicomi”, posta dentro la terra di Policastro nel convicino di S.ta Caterina, confine la domus che era appartenuta alla quondam Lucretia Turana, confine l’orto di Petro Paulo Serra “vallone mediante”, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 298, ff. 004-005). 13.07.1637. Claritia Paudari figlia del quondam Fran.co Paudari, vende a Joannes Laurentio de Pace, il casaleno posto dentro la terra di Policastro nel convicino della chiesa di Santa Catherina, confine la “domum seu ortum” del presbitero D. Parise Ganguzza, il casaleno di detto Joannes Laurentio, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 304, ff. 050-050v). 03.11.1637. Nei mesi passati, i coniugi Nicolao Grosso ed Elisabetta Palazzo, avevano venduto a Laurentio de Pace, il casaleno posto dentro la terra di Policastro nel convicino di S.ta Caterina, confine la domus di detto Laurentio, la via pubblica ed altri fini. Al presente i detti coniugi ricevevano il denaro pattuito (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 304, ff. 101-101v). 21.02.1638. Hyeronimo Salerno vende ad Andrea Cavarretta, la “Continentiam domorum” costituita da 3 camere, con “Cortilem inferioribus, et superioribus”, cui andava incluso un “orticellum Contiguum”, posta dento la terra di Policastro nel convicino della chiesa di “Sante Caterine”, confine la domus di Laurentio de Pace, i “sicomos” di Petro Paulo Serra “vallone mediante”, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 305, ff. 023-024). 21.02.1638. Davanti al notaro si costituiscono Isabella Marrazzo, vedova del quondam Valentio Jordano, e Hyeronimo Salerno. Negli anni passati, detto Gerolimo aveva venduto a detto Valente, due case poste dentro la terra di Policastro nel convicino della chiesa di “santa Caterina”, confine “li Celsi” di Petro Paulo Serra, “vallone mediante”, e le case di Laurenzo de Pace che erano appartenute al quondam Virgilio Catanzaro, “della parte di sotto il Cortiglio”, per il prezzo di ducati 18, relativamente al quale si era impegnato a pagare l’annuo censo di carlini 12. All’attualità la detta Isabella, non avendo il denaro per continuare a pagare il censo, retrocedeva le case a detto Gerolimo per il medesimo prezzo (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 305, ff. 024-025). 28.02.1638. Davanti al notaro compaiono D. Aloisia de Angelis, vedova ed erede del quondam Justuliano Cirisani, e Hyeronimo Poerio. La detta Aloisia asseriva che suo marito aveva comprato dal Cl.co Lutio Venturi, procuratore del monastero di S.ta Maria della Spina, un “ortale” arborato di “Celsi” posto dentro la terra di Policastro nel convicino di “Santa Caterina”, confine l’orto di detta chiesa, l’orto e casalino di Gio: Thomaso Scandale, la via pubblica ed altri fini, impegnadosi a pagare l’annuo censo di carlini 15. All’attualità la detta Aloisia retocedeva il bene al detto Gerolimo che s’impegnava a pagare lo stesso censo al monastero (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 305 ff. 025-025v).
[xxxvi] ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 288, ff. 091v-092v. 20.08.1607. Davanti al notaro comparivano Julia Niele, vedova del quondam Joannes Petro Bonanni, e Thomaso Autimari del casale di Cellara, pertinenza di Cosenza, per la stipula dei capitoli relativi al loro matrimonio. Tra i beni della dote figurava anche “la vasilea harborata di celsi confine le mura della terra, et l’orto di Fran.co paudari, et Geronimo et Filippo carise” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 287 ff. 032v-033v). 28.05.1617. Joannes Laurenzo Corigliano dichiarava che Joannes Fran.co Corigliano suo padre, aveva venduto a Cesare Truscia il “casalenum” posto dentro la terra di Policastro loco detto “la vasilea”, confine l’orto di Fran.co Paudari, “et murii ditte Civitatis”, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 291, ff. 025v-026).
[xxxvii] 02.11.1634. Petro de Mauro vende a Hijeronimo Salerno, la “Continentiam domorum cum Cortiles, et orto” consistente in 6 membri palaziati posta dentro la terra di Policastro nel convicino di S.ta Caterina, confine l’orto di D. Parise Ganguzza, il casaleno di Nicolao Grosso, i “sicomos” di Petro Paulo Serra “vallone mediante dittus la vasilea”, le vie pubbliche ed altri confini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 301, ff. 152-153v).
[xxxviii] 27.08.1631. Davanti al notaro comparivano Ippolita Catanzaro, vedova del quondam Joannes Dom.co Vonazzi e Petro de Mauro, per la stipula dei capitoli relativi al matrimonio tra detto Petro e Catherina Bonaccio, figlia del detto quondam Joannes Dom.co e di detta Ippolita. La detta Ippolita, assieme al presbitero D. Lucas Bonaccio del castro di San Mauro, tutore di dette Catherina, le promettevano una continenza di case poste dentro la terra di Policastro, nel convicino di Santa Caterina, dove si dice “la vasilea”, confine l’orto che era appartenuto al quondam Fran.co Paudari, “le mura della Citta ditte similm.te la vasilea”, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 298, ff. 061-062v).
[xxxix] “Nell’anno 1520 si ritrovò sotto la muraglia a canto il tempio antico di S.ta Caterina un Idoletto Piccolo d’Ercole alto un buon Palmo, qual’era di Bronzo con in mano la Clava …”. Mannarino F. A., Cronica della Celebre ed Antica Petilia detta oggi Policastro, 1721-1723.
[xl] 20.08.1607. Nella dote di Julia Niele che andava sposa a Thomaso Autimari del casale di Cellare, pertinenza di Cosenza, figura “la vasilea harborata di celsi confine le mura della terra, et l’orto di Fran.co paudari” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 287, ff. 032v-033v). 28.05.1617. Joannes Laurenzo Corigliano dichiarava che suo padre Joannes Fran.co, aveva venduto a Cesare Truscia il “casalenum” posto dentro la terra di Policastro loco detto “la vasilea”, confine l’orto di Fran.ci Paudari “et murii ditte Civitatis”, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 291, ff. 025v-026). 25.11.1623. Alla dote di Beatrice Bonanno che andava sposa a Joannes Baptista Lanzo, apparteneva “la vasilea” che era stata del quondam Fran.co Bonanno suo padre, confine l’orto di Fran.co Paudari, l’orto di Filippo Carise, “li celsi” di Petro Paulo Serra ed altri fini. (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 294, ff. 115v-119). 27.08.1631. Alla dote di Catherina Bonaccio che andava sposa a Petro de Mauro, apparteneva una continenza di case poste dentro la terra di Policastro, nel convicino di Santa Caterina dove si dice “la vasilea”, confine l’orto che era appartenuto al quondam Fran.co Paudari e “le mura della Citta ditte similm.te la vasilea”, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 298, ff. 061-062v).
[xli] ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 297, ff. 170-172v.
[xlii] 24.10.1620. Il chierico Scipione Popaianni vendeva ad Andrea de Pace, la “Continentiam domorum palatiatorum”, posta dentro la terra di Policastro nel convicino della chiesa di “Santi petri”, confine la “logettam domorum” del quondam Marco Antonio Coco, l’orto e il “palazzettum” di quest’ultimo ed altri fini; nonché l’orto “arboratum sicomorum” posto nello stesso loco, confine la detta continenza di case palaziate, l’orto della venerabile chiesa di Santa Caterina, l’orto del detto quondam Marco Antonio ed altri fini; nonché un altro “orticellum”, confine il detto orto, “et ripas dittas le catarrata et vallone ditto le Catarrata”, confine i “sicomium et Casalenos” del quondam Julio Jannino ed altri fini, con il patto che rimanesse al detto Scipione, la “Camera” confinante con la via pubblica ed i detti orti, dove al presente abitava Isabella Spolvera (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 292, ff. 068-069). 16 agosto 1621. Per consentirgli di ascendere all’ordine sacerdotale, Andrea de Pace donava al clerico Joannes Thoma suo figlio, i seguenti beni: la “continentia domorum” con orto contiguo arborato “sicomis”, posta dentro la terra di Policastro nel convicino di “Santi Petri”, confine la domus degli eredi del quondam Marco Antonio Coco, il “vallonem dittum le catarrata”, l’orto di Santa Caterina ed altri fini, che detto Andrea aveva comprato dal Cl.o Scipione Popaianni (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 293, ff. 049-049v). L’ultimo di febbraio 1638, Donna Aluise o Aloisia de Angelis, vedova ed erede del quondam Justuliano Cirisano, asseriva che suo marito aveva comprato dal Cl.co Lutio Venturi, procuratore del monastero di S.ta Maria della Spina, un “ortale” arborato di “Celsi” posto dentro la terra di Policastro “nel Convicinio di santa Caterina”, confine “l’orto di detta chiesa”, l’orto e casalino di Gio: Thomaso Scandale, la via pubblica ed altri fini, impegnadosi a pagare l’annuo censo di carlini 15. All’attualità la detta Aloisia retocedeva il bene a Hyeronimo Poerio che s’impegnava a pagare lo stesso censo al monastero (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 305, ff. 025-025v). 22.02.1643. I coniugi Lupo de Florio e Laura Faraco vendevano a Joseph Giordano un “Ortale sicomorum” dotale posto dentro la terra di Policastro loco detto “la basilea”, confine la domus e l’orto del quondam Hijeronimo Poeri, un altro ortale ed il casaleno del quondam Tiberio Grigoraci, le “Rupas dictae Civitatis” ed altri fini (ASCZ, Notaio G. M. Guidacciro, Busta 182 prot. 802, ff. 040v-042). 15.08.1655. Alla dote di Vittoria Ritia che andava sposa a Petro de Franco, apparteneva “un pede di Celso” posto dentro la terra di Policastro nel loco detto “la Vasilea”, confine l’orto del quondam Petro Paulo Serra, “vallone” mediante (ASCZ, Notaio F. Cerantonio, Busta 196 prot. 880, ff. 111v-113).
[xliii] La porta della Judeca risulta anche dopo il terremoto del 1638. Nell’ambito della visita agli “Oppidis, et Locis Suae Dioecesis”, l’arcivescovo di Santa Severina Francesco Falabella giunse a Policastro la domenica del tre ottobre 1660. Annunciato otto giorni prima per iscritto, proveniente da Mesoraca, egli giunse “extra oppidi Portam” accompagnato dal suo seguito dove, al suono delle campane, fu accolto dal popolo e dal clero con la croce. AASS, 37A. Se ne fa menzione ancora agli inizi del Novecento, in occasione della descrizione dei confini della chiesa Martice. “Dalla parte di nord-est a partir dalla porta Giudaica, la parte di sinistra scendendo su la rotabile che va Cutro fino al ponte di Tacina. Anche comprende la parte di sinistra seguendo la strada rotabile che mena a Mesoraca, fino a contrada Santo Francesco inclusive. Dal ponte di Tacina della strada rotabile (estremo limite) risalendo verso Nord, giunge all’altro ponte del detto fiume Tacina presso Cotronei. Di là, ritornando verso il paese, comprende tutte le contrade chiuse nei su detti limiti avvertendo che appartengono alla Chiesa matrice tutte quelle che si trovano dalla parte sinistra della rotabile fino al Ponte Gallina dove l’una e l’altra parte appartiene alla Chiesa Matrice.” AASS, 034B.
[xliv] 25.02.1620. La località “cimicicchio” risultava individuata “sotto la rupe di s.ta Caterina, et porta della Judeca” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 292, ff. 011-013v). 01.06.1646. “il luoco, et possessione detto Cimicicchio”, esistente nel “distretto” di Policastro “et pp.o sotto le timpe della porta della Giudeca la via publica che si cala nelle molina dell’acquaro” ed altri fini (ASCZ, Notaio G. M. Guidacciro, Busta 182 prot. 805, ff. 046-053).
[xlv] 23.04.1605. Capitoli matrimoniali relativi al matrimonio tra Polisena Carcello e Giallupo Pecuro. Il futuro sposo prometteva alla sposa una casa e la metà di un piede di “celso”, che deteneva in comune con Minicella Azzarito, beni posti dentro la terra di Policastro loco detto “lo vallone della turana”, confine “l’orto di Gio: maria prantedi ingresso med.e” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 286, ff. 98v-99v). 03.01.1618. Prospero Carrozza vendeva a Hijeronimo Lamanno, la domus palaziata con un “catoijo” dove teneva la paglia, posta dentro la terra di Policastro nel convicino della chiesa di S.ta Caterina, confine l’orto di Petro Paulo Serra, “vallone mediante”, le domus della quondam Lucretia Turana, la via pubblica ed altri fini. La detta domus era stata acquistata da Prospero Carrozza dal quondam Joannes Battista Favari (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 291, ff. 076v-077v). 18.09.1630. Il notaro si porta nella domus palaziata di Fiore Palmeri, posta dentro la terra di Policastro nel convicino di S.ta Caterina, confine la domus del presbitero Joannes Baptista Favari “dittam la turana”, l’orto di Petro Paulo Serra, la via convicinale ed altri fini, per stipulare il suo testamento (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 297, ff. 162v-163). 21.01.1631. Leonardo Caccurio vende a Paulo Venturo, la domus palaziata con orto contiguo dove era un “pede magno sicomi”, posta dentro la terra di Policastro nel convicino di S.ta Caterina, confine la domus che era appartenuta alla quondam Lucretia Turana, confine l’orto di Petro Paulo Serra “vallone mediante”, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 298, ff. 004-005).
[xlvi] 01.04.1634. Davanti al notaro comparivano Innocentia Mannarino, vedova del quondam Joannes Thoma Curto, ed il Cl.o Fran.co Curto suo figlio, assieme a Scipione Spinello, per la stipula dei capitoli relativi al matrimonio tra detto Scipione e Lisabetta Curto, figlia di detta Innocentia e sorella del detto Cl.o Fran.co. Apparteneva alla dote la casa palaziata posta dentro la terra di Policastro nel convicino della SS.ma Annunziata “nova”, confine la casa di detta Innocentia, la casa di D. Gio: Battista Favari “vallone mediante” ed altri confini, cioè si prometteva “la casa nova di abascio con il trappito” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 301, ff. 052v-054). 09.08.1636. Innocentia Mannarino vedova del quondam Joannes Thoma Curto, vendeva al R.do D. Joannes Baptista Favaro, la domus terranea posta dentro la terra di Policastro nel convicino della SS.ma Annunziata “nova”, confine la domus di Scipione Spinello, la domus degli eredi del quondam Marcello Lice, la domus di Hijeronimo Santella, il “vallonem Civitatis quod discendit à Fumerello” ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 303, ff. 087v-092v).
[xlvii] 04.10.1608. Pompeo Tabernense, ordinario servente, su istanza di Joannes Furesta, procuratore di Fabritio Oliverio di Cutro, incanta a Scipione Misiano la “domum palatiatam” “in pluribus et diversis membris Consistentibus” di Minico Cavarretta, posta dentro la terra di Policastro confine il “vallonem Correntem” e la via pubblica (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 287, ff. 107-107v).
[xlviii] 27.12.1608. Davanti al notaro comparivano Francischina Maurello “virgine in capillo” e Laurentio Pipino, per la stipula dei capitoli relativi al loro matrimonio. Nella dote della sposa compare una casa palaziata posta dentro la terra di Policastro, confine la casa di Gio: Paulo Jannici, la casa di Minico Cavarretta, vinella mediante, la via pubblica ed altri confini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 287, ff. 123v-124v). 22.03.1609. Scipio Misiano, che aveva incantato nella “platea publica” la domus o “continentiam domorum” di Minico Cavarretta, “in pluribus et diversis membris consistentem”, posta nella terra di Policastro, le vende e retrocede al detto Minico (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 287, ff. 137v-138). 22.07.1620. Marco Ant.o Cavarretta, giunto ad un accordo con Joannes Battista Cavarretta suo fratello, in merito ai lasciti del quondam Minico Cavarretta loro padre, legati nel suo ultimo testamento, acquistava dal detto Joannes Battista la “domum palatiatam cum Camera contigua”, posta dentro la terra di Policastro, nel convicino della chiesa di S.to Nicola “de grecis”, confine la domus di Rentio Pipino “vinella mediante”, il casaleno di Minico de Pace de Santo “a parte superiore”, la via convicinale ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 292, ff. 052-052v). 25.07.1621. Davanti al notaro comparivano Marco Antonio Cavarretta, figlio del quondam Minico Cavarretta, ed i coniugi Matteo Cavarretta e Cornelia Cavarretta. Alla dote promessa dal detto Marco Ant.o alla detta Cornelia sua figlia, apparteneva una casa palaziata con camera contigua posta dentro la terra di Policastro nel convicino della “paroccia” di S.to Nicola “delli greci”, confine la casa di Renzo Pipino vinella mediante, la casa di Minico de Pace “alias panfutio” e la via pubblica da due parti, gravata dal peso di annui grana tre al “feudo di paparone” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 293, ff. 046-047v). 06.01.1654. Didaco, Anastasia e Andrea Cavarretta “in solidum”, vendevano al presbitero Joannes Baptista Pollaci, la casa palaziata con “Camera contiqua” che possedevano in comune ed indiviso con Cornelia Cavarretta, loro madre e zia rispettivamente, posta dentro la terra di Policastro nel convicino della chiesa parrocchiale di S.to Nicola “Grecorum”, confine la domus di Berardino Pipino, la domus di Anello Fontana Rosa, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio F. Cerantonio, Busta 196 prot. 879, ff. 001v-003).
[xlix] 06.05.1626. Julia de Pace, vedova del quondam Joannes Paulo Jannici, cedeva ai coniugi Joseffo Pollaci e Caterina Jannici, in conto della dote loro promessa, una “Casa scoverta” posta dentro la terra di Policastro, nel convicino della SS.ma Annunziata “nova”, confine l’orto di Nardo Caccurio di Cella, la casa di Vittorio Tronga, la casa di Fabio Amerato, e Gio: Dom.co Rizza de Mundo, vinella mediante, la casa del quondam Laurenzo Russo, via mediante, e “lo vallone”, assieme “con lo casalino di sopra unito con detta Casa con tutta la ligname, et ciaramidi che vi sono hoggi di dentro”. Si pattuiva che se Alfonso Campitello avesse comprato la casa di Fabio Amerato, quella di Gio: Dom.co Rizza o quella di Vittorio Tronga, avrebbe avuto la possibilità di “arribare tanto le mura come la ligname”, nel muro di detta casa scoverta e casalino, “et possa levare la vinella” alzando le mura di detta “Casa facienda”, “di paro” con il muro di detti coniugi (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 296, ff. 036v-037).
[l] 26.09.1604. Testamento di Lucretia Rocca, abitante “intus p(raedi)ttam terram in convicino santi dimitri justa domum Fran.ci Cervini iusta domum Laurensi tavernise vallone mediante viam publicam et alios fines” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78, prot. 286, ff. 55-56). 13.07.1618. Feliciana Cavarretta vendeva a Santoro Sagace due “Casalenos” che il quondam Nicolao Joannes La Medaglia, suo marito, aveva acquistato da Ottavio de Pace. I due casaleni confinavano con il casaleno di Joannes Battista de Albo de Cola, con la “viam publicam dell’ulmo”, la domus di Polinitia Costantino, “vallone mediante” ed altri fini. Attraverso i miglioramenti apportati dal detto quondam Nicolao, i due casaleni erano stati uniti, ed all’attualità erano divenuti un casaleno coperto, ovvero una “domum coverta cum casaleno” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 291, ff. 098v-099v). 31.08.1625. Ottavio de Pace vendeva a Fran.co Turtorella ed alla sua consorte Berardina Spano, la domus palaziata con camera contigua similmente palaziata, con “gisterna”, “et largo di essa ferente della Cantonera di detta Casa al vallone preter lo largo q.m Santori Sagaci”, posta dentro la terra di Policastro nel convicino di S.to Nicola “de grecis”, “justa salam Contiguam dittae domus derutam”, confine il casaleno di Joannes Baptista de Albo de Cola, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 295, ff. 135v-137). 06.05.1607. Joannes Laurentio Cimino “alias fegatale”, vendeva a Jacobo Recitano la “domum palatiatam” posta dentro la terra di Policastro “iusta Ecclesie santi dimitri iusta domum d. Polinitia, et vallonem ab alia parte” ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 287, ff. 018v-019v). 06.10.1624. Davanti al notaro comparivano Joannes Laurentio Cimino “alias fegatale” e Joannes Thoma Madeo, per la stipula dei capitoli relativi al matrimonio tra detto Joannes Thoma e Lucretia Cimino, figlia di detto Laurentio. Apparteneva alla dote una casa palaziata posta dentro la terra di Policastro “confine et muro Coniunta di santo dimitri”, e confine la casa di Marco Valente, “quale Casa se intenda verso vascio cioe verso lo vallone” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 295, ff. 081-081v). 30.10.1633. Davanti al notaro comparivano Spetio Vivacqua della terra di Mesoraca, ma “habitante” in Policastro, e Fran.co de Stilo, per la stipula dei capitoli relativi al matrimonio tra detto Fran.co e Caterina Vivacqua, figlia di detto Spetio. Apparteneva alla dote una casa palaziata posta dentro la terra di Policastro, nella parrocchia di “Santo Petro”, confine la casa di Gianni Grano, “la chiesa deruta di Santo dimitri”, la via pubblica ed altri fini, unitamente con il casalino contiguo a detta casa, confine “lo vallone” ed altri fini. Detti beni erano precedentemente appartenuti al quondam Gio: Laurenzo Fegatale (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 300, ff. 094v-096).
[li] 21.09.1614. Davanti al notaro comparivano Alfontio Caccurio e Petro Piluso della “serra santi stefani Boschi”, ma al presente abitante in Policastro da più anni, per la stipula dei capitoli relativi al matrimonio tra il detto Petro ed Auleria Caccurio, figlia del detto Alfontio. Alla dote apparteneva una casa terranea, confine la casa di Vespesiano Pantisano “muro Coniunto”, la casa di Gianni Polla “della parte di sopra”, “la via publica seu vallone” ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 289, ff. 024v-025v; foto 282-284). 29.04.1615. Davanti al notaro ed al parroco, si costituivano Alfontio Caccurio e Matteo de Dattolo del casale di Pedace, pertinenza di Cosenza, per la stipula dei capitoli relativi al matrimonio tra il detto Matteo e Berardina Caccurio, figlia del detto Alfontio. Alla dote apparteneva una casa palaziata “con alto, et abascio”, che detto Alfontio aveva comprato dal notaro Horatio Scandale, posta dentro la terra di Policastro, nel convicino di “santo demitri”, confine la casa di Gio: Fran.co Callea, “della parte di sopra et di sotto confine l’altra Casa terrana di detto Alfonso”, l’orto che era appartenuto al quondam Andria Campitello, la via pubblica ed altri fini. Alla dote apparteneva anche un “orto arborato di Celsi” che era appartenuto al quondam Andria Campitello, posto dentro la terra di Policastro, confine la sopradetta casa promessa, la casa di Gio: Fran.co Callea, l’altra casa palaziata di detto Alfonso, il “vallone affacciante verso la casa de fabio ammerato” ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 290, ff. 020-021). 18.03.1634. Davanti al notaro comparivano Angilella Caccuri, vedova del quondam Paulo Mazzuca, e Diegho o Didaco Ventorino, figlio di Joannes Ventorino, per la stipula dei capitoli relativi al loro matrimonio. Apparteneva alla dote una casa terranea posta dentro la terra di Policastro nel convicino di “Santo dimitri”, confine la casa di Berardina Caccuri, la casa di Alfonso Cappa, la via pubblica ed altri confini. Apparteneva alla dote anche un ortale “di celsi”, posto dentro la terra di Policastro, confine la casa degli eredi del quondam Vitaliano Pullaci, la casa di detta Berardina, la “stalla” di Alfonso Campitello “et lo vallone vallone” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 301, ff. 034-035).
[lii] 25.03.1613. Fran.co Commeriati vendeva a Joannes Dom.co de Strongulo, le “domos terraneas” che gli aveva promesso in dote Joannes Thoma Richetta, a cui erano state vendute da Caterina Scandale e da suo figlio, poste dentro la terra di Policastro, nel convicino della venerabile chiesa della “santiss.me Nuntiate dittae terre”, confine la domus di Joannes Caccuri “a parte superiori” e vinella mediante, confine l’orto che era appartenuto al quondam Joannes Andria Briatico che al presente possedeva Alfontio Caccurio, il “Vallonem” ed altri confini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 288, ff. 074-075). 05.05.1622. Davanti al notaro comparivano il magister Fran.co Commeriati e Antonio Faraco, per la stipula dei capitoli relativi al matrimonio tra detto Antonio e Julia Conmeriati, figlia del detto Fran.co. Apparteneva alla dote la casa palaziata posta dentro la terra di Policastro nel convicino di “Santo dimitri”, confine la casa di Santoro Sagaci, muro congiunto, l’altra casa di detto m.o Fran.co, “lo vallone della terra” ed altri fini. Rimaneva stabilito che l’entrata della detta casa era “per la scala di detto m.o fran.co lo ponte ponte seu vignano”, mentre “l’intrata dello Catoijo” era “per l’orto di detto fran.co” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 294, ff. 019v-021). 07.07.1635. Joannes Conmeriati, figlio ed erede del quondam Fran.co Conmeriati, vendeva a Fran.co Lamanno la “domum palatiatam sive palazzettum” “cum introito, et exito per partem gisterna ditta lo barone, et cum ditta domo vadit largum con lo largo spettante a detta Casa”, posta dentro la terra di Policastro nel convicino della chiesa di “santi dimitri diruta”, confine la domus di Berardino Lomoijo, la “domum magnam” di detto Joannes, l’orto del quondam Joannes Jacobo Torres, “vallone mediante”, ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 302, ff. 064v-065v). 06.04.1643. Salvatore Punteri di Carpansano ma, al presente, “habbitante cun Domo, et familia” in Policastro, vendeva a Joannes Caccurio la metà di un casalino che il detto Salvatore aveva comprato da Jo: Domenico Schipano, posto dentro la terra di Policastro nel convicino della SS.ma Annunziata “nova”, confine la casa di detto Giovanni via mediante, la casa di detto Salvatore “via, et vallone mediante” ed altri fini. La casa di Antonio Curto si trovava dirimpetto alle case di detto Giovanni, (ASCZ, Notaio G. M. Guidacciro, Busta 182 prot. 802, ff. 052-053).
[liii] 26.05.1645. Il notaro Joannes Leonardo de Pace possedeva la domus palaziata posta dentro la terra di Policastro in parrocchia di “Sancti Petri iuxta publicam Plateam à parte superiori”, la domus di Joannes Thoma de Pace, il “vallonem dictum de Pantisano”, la domus di Thoma Lamanno, la domus di Joannes Hyeronimo Blasco ed altri fini (ASCZ, Notaio G. M. Guidacciro, Busta 182 prot. 804, ff. 077v-081). 17.03.1647. Stefano Apa di Policastro vende a Dianora de Torres di Policastro una casa terranea posta dentro la terra di Policastro nel convicino della chiesa parrocchiale di “S.to Pietro”, confine le case del quondam notaro Leonardo de Pace, “lo Vallone” ed altri fini (ASCZ, Notaio F. Cerantonio, Busta 196 prot. 874, ff. 027-028).
[liv] 06.12.1605. Hijeronimo Cavarretta vendeva ad Alfonso Caccurio, una “domum terraneam” posta dentro la terra di Policastro “in Convicino ecclesie s.ti diMitri”, confine la domus della quondam Betta de Guarino “et Vespasiani Pantisani”, la domus di detto Alfonso, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78, prot. 286, ff. 150v-151v). 19.09.1607. La domus “terraneam” venduta da Hijeronimo Cavarretta ad Alfonso Caccurio era posta dentro la terra di Policastro “in convicinio Ecclesie santi dimitri”, confine la domus di Vespesiani Pantisani, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 287, ff. 040v-041). 21.09.1614. Alla dote di Auleria Caccurio, figlia di Alfontio Caccurio, apparteneva una casa terranea, confine la casa di Vespesiano Pantisano “muro Coniunto”, la casa di Gianni Polla “della parte di sopra”, “la via publica seu vallone” ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 289, ff. 024v-025v). 28.09.1621. Vespesiano Pantisano possedeva una domus palaziata in diversi membri “et pergula”, posta dentro la terra di Policastro nel convicino di S.to Nicola “de grecis”, confine la domus di Joannes Dom.co Cappa, vinella mediante, la domus di Alfonso Caccuri, la via pubblica ed altri fini. Posedeva anche una “poteca” confinante con la domus predetta, vinella mediante (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 293, ff. 061v-069). 14.03.1623. Hijeronimo Salerno della terra di Mesoraca ma, al presente “habitator” in Policastro da molti anni, donava a Petro Paulo Serra suo cognato, alcuni beni, tra cui una casa palaziata posta dentro la terra di Policastro loco detto “la piazza” nella parrocchia di S.to Nicola “delli greci”, confine la casa di Gio: Dom.co Cappa e la casa di Gio: Alfonso Caccuri (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 294, ff. 082v-083v).
[lv] 28.02.1632. Il presbitero D. Santo de Pace vendeva a Joannes Thoma Lamanno, 2 “Casalenos” di cui uno terraneo e l’altro palaziato senza catoio, “et per sotto passa lo vallone ditto delle bucceria”, posti dentro la terra di Policastro in parrocchia di S.to Nicola “de platea”, confine la domus degli eredi di Vincenso Coco, la casa di esso Gio: Thomaso, la via convicinale ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 299, ff. 031v-032v). 22.09.1641. Francisco Giannino vendeva a Joannes Thoma Lamanno, il “Casalenum” posto dentro la terra di Policastro nel convicino della chiesa di “Santae Mariae Gratiae”, confine la domus di detto Thoma, la domus di Leonardo Crocco, via mediante, “iuxta vallonem” ed altri fini (ASCZ, Notaio G. M. Guidacciro, Busta 182 prot. 801, ff. 036-036v). 25.02.1631. Auleria Cavarretta vedova del quondam Joannes Vincenso Coco, garantiva una permuta sopra la domus che era appartenuta a suo marito defunto, confine la domus del notaro Jacinto Richetta, “et vallonum dittum della piazza seu bucerie” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 298, ff. 023-024v). 24.11.1638. Davanti al notaro compaiono Auleria Cavarretta vedova del quondam Vincenso Coco e Jacobo de Vona, per la stipula dei capitoli relativi al loro matrimonio. Apparteneva alla dote, la casa palaziata posta dentro la terra di Policastro nel convicino della chiesa di S.ta Maria “la gratia”, confine le case del quondam notaro Jacinto Richetta ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 305, ff. 105v-106v). 27.09.1639. Su richiesta del Cl.o Carolo Leonardo Richetta, il notaro si porta nella sua domus palaziata posta dentro la terra di Policastro nel “Convicinio seu Cappella santi petri”, confine la domus di Auleria Cavarretta, la via pubblica ed altri fini, per la compilazione dell’inventario dei beni del quondam notaro Jacinto Richetta suo padre. Tra questi figurava una continenza di case che, secondo detto Carlo, gli appartenevano per donazione del quondam Gio: Thomaso Richetta suo “avo” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 306, ff. 107v-108v).
[lvi] 08.10.1630. Per procedere alla stipula del suo testamento, il notaro si porta nella domus palaziata di Cornelia Rotella moglie di Antonio Ligname, posta dentro la terra di Policastro nel convicino di S.ta Maria “Gratiarum”, confine la domus di Marcello Cocciolo, la domus degli eredi del quondam Joseffo Ligname, la via pubblica “seu vallonem” ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 297, ff. 175-175v). 24.04.1635. Per consentirgli di accedere agli ordini sacerdotali, Joannes Gregorio Cerasaro, “proCuratoris mundualdi” di sua sorella Laura Cerasaro, assieme a detta sua sorella, donavano al Cl.co Joannes Battista Cerasaro, loro fratello, la casa palaziata con 2 camere e “cortiglio” posta dentro la terra di Policastro nel convicino di S.ta Maria “la gr(ati)a”, confine le case di Santo Faraco, la casa di Caterina Popaijanni, “Vallone mediante”, la via pubblica ed altri fini, mentre la camera “di abascio” dentro il “cortiglio”, rimaneva ad essi donatori per poterci abitare in vita (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 302, ff. 034v-036). 08.06.1652. Santo Misiano vendeva al Cl.co Gio: Battista Cerasari, la casa terranea che aveva comprato da Santo Faraco l’anno passato, posta dentro la terra di Policastro nel convicino della chiesa parrocchiale di “S.to Pietro”, confine le case di detto Cl.co Gio: Battista, “lo Vallone della Città” ed altri fini (ASCZ, Notaio F. Cerantonio, Busta 196 prot. 877, ff. 033v-034v).
[lvii] 11.08.1624. Agostino Curia vendeva al presbitero D. Horatio Piccolo, la domus palaziata posta dentro la terra di Policastro nel convicino di “Santi Petri”, confine la domus di Julia Ferraro “via mediante vallonem dittum della Judeca”, la via pubblica dalla parte superiore ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 295, ff. 059-060). 15.09.1630. Antonino Gatto vendeva a Francisco Marchise la “Cameram palatiatam” muro congiunto con un’altra domus “magna” di detto Antonino, posta dentro la terra di Policastro nel convicino di S.ta Maria “gratiarum”, confine i “Casalenos” appartenuti al quondam Joannes Dom.co Sacco “et valonnem magnum dittum la iudeca” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 297, ff. 160-161). 25.05.1634. Antonino Gatto vendeva a Joannes Cepale, “lo largo seu ortale”, ovvero “lo largo de sopra la timpa”, vicino la casa di Renzo Jerardo e la casa di Giulio Doratio che era appartenuta al quondam Gio: Dom.co Sacco, confine “lo vallone vallone et la istrada che scende dalla santiss.a nuntiata alla porta della terra detta la Judeca” ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 301, ff. 098v-099v).
[lviii] 24.10.1620. Il chierico Scipione Popaianni vendeva ad Andrea de Pace, la “Continentiam domorum palatiatorum”, posta dentro la terra di Policastro nel convicino della chiesa di “Santi petri”, confine la “logettam domorum”, l’orto ed il “palazzettum” del quondam Marco Antonio Coco, ed altri suoi fini, nonché l’orto “arboratum sicomorum” posto nello stesso loco, confine la detta continenza di case palaziate, l’orto della venerabile chiesa di S.ta Caterina, l’orto di detto quondam Marco Antonio ed altri fini; nonché un altro “orticellum”, confine il detto orto, “et ripas dittas le catarrata et vallone ditto le Catarrata”, confine “sicomium et Casalenos” del quondam Julio Jannino ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 292, ff. 068-069). 16.08.1621. Per consentirgli di ascendere all’ordine sacerdotale, Andrea de Pace donava al clerico Joannes Thoma de Pace suo figlio, i seguenti beni: la “continentia domorum” con orto contiguo arborato “sicomis” posta dentro la terra di Policastro nel convicino di “Santi Petri”, confine la domus degli eredi del quondam Marco Antonio Coco, il “vallonem dittum le catarrata”, l’orto di S.ta Caterina ed altri fini, che detto Andrea aveva comprato dal Cl.o Scipione Popaianni (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 293, ff. 049-049v).
[lix] 14.11.1604. Alla presenza del notaro e del parroco, si costituivano Fabio de Mauro, tutore istituito dalla Curia di Policastro per parte di Caterinha Popaianni, figlia del quondam Franceschello Popaianni, e Joannes Thomas Cavarretta, figlio del quondam Gregorio Cavarretta, per il matrimonio tra i detti Joannes Thomas e Caterinha. Apparteneva alla dote della sposa la metà di una casa con “trappito”, confinante con Fran.co de Albo (ASCZ, Notaio Guidacciro G. B., Busta 78, prot. 286, f. 67bis). 08.10.1623. Davanti al notaro comparivano Caterina Popaianni, vedova del quondam Vespesiano Pantisano, assieme a Joannes Fran.co Callea, per la stipula dei capitoli relativi al loro matrimonio. Appartenevano alla dote una casa palaziata con casalino contiguo, posta dentro la terra di Policastro nella parrocchia di “santo Petro”, confine i casalini del quondam Ferrante Cerasaro, la via pubblica ed altri fini, assieme alla metà del “trapito” che essa deteneva in comune con suo fratello Vespesiano Popaianni, posto dentro la terra di Policastro confine Blasio Rizza ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 294, ff. 110-111). 26.05.1634. Davanti al notaro comparivano Caterina Popaijanni vedova del quondam Fran.co Callea, e Nardo Arenda, figlio di Joannes Simone Arenda, per la stipula dei capitoli relativi al matrimonio tra detto Leonardo e Joannella Callea, figlia di detta Caterina. Appartenevano alla dote: la casa palaziata con casalino contiguo dalla parte di sopra, posta dentro la terra di Policastro, confine la casa di Pordentia Federico, via mediante, “lo vallone ditto le catarrata” ed altri confini. La meta della “Casa, et trappito” posta dentro la terra di Policastro nel convicino di “santo petro”, confine la casa di Blasio Rizza, Gerolimo Amannito ed altri fini, mentre l’altra metà di detto “trappito” rimaneva ai figli del quondam Vespesiano Popaijanni (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 301, ff. 078v-080v). 02.01.1637. Davanti al notaro comparivano il Cl.co Leonardo Arenda, marito di Joannella Callea, assieme a Caterina Popaijanni. Negli anni passati, detta Caterina, madre di detta Joannella, aveva promesso in dote ai detti coniugi diversi beni. All’attualità, adempiando alla sua promessa, consegnava loro, tra l’altro, la metà di una casa terranea “con trappito”, di cui l’altra metà rimaneva ai figli ed eredi del quondam Vespesiano Popaijanni, posta dentro la terra di Policastro nel convicino di “santo Petro”, confine la casa di Blasio Rizza, le “[rip]e ditte delle Catarrate” e la via convicinale (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 304, ff. 001-002). 06.03.1646. Su richiesta di Blasio Ritia, il notaro si porta nella sua casa posta dentro la terra di Policastro, nel convicino della chiesa parrocchiale di “S.ti Petri”, “iusta Ecc.am S.tae Mariae de gratiae”, vinella mediante, la via pubblica ed altri fini, per stipulare il suo testamento. ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 307, ff. 084v-087. 25.11.1647. Davanti al notaro comparivano Gio: Dom.co Lomoio, con il consenso di suo padre Andrea Lomoio, assieme a Paulo e Laura de Maijda, padre e figlia, anche per parte di Gio: Dom.co Scandale, marito di detta Laura. I detti Paulo e Laura asserivano che, negli anni passati, Santo Lomoio, fratello di detto Gio: Dom.co e figlio di detto Andrea, aveva donato a detta Laura la metà di una casa posta dentro la terra di Policastro, nella parrocchia di “S.to Pietro”, confine la casa di Blasio Rizza, “muro coniuncto”, la casa di Antonio Caputo, via pubblica mediante, la casa di S.ta Maria “la gratia”, “dalla parte di sop.a”, vinella mediante, la via pubblica, “dalla parte di sop.a” ed altri fini, assieme ad altri beni. Tali beni spettavano a Santo Faraco, come figlio ed erede della quondam Dianora de Maijda, mentre il detto Andrea Lomoio ne aveva l’usufrutto vita natural durante. La situazione aveva generato lite tra le parti che, all’attualità erano giunte ad un accordo. La detta Laura ed il detto Paulo, cedevano in feneficio di detto Gio: Dom.co la detta donazione dei detti beni, mentre il detto Gio: Dom.co s’impegnava a pagare ducati 13 e ½ al detto Paulo (ASCZ, Notaio F. Cerantonio, Busta 196 prot. 874, ff. 103-106v). 06.09.1655. Testamento di Agostina Jerardo, moglie di Blasio Ritia, rogato nella sua domus posta dentro la terra di Policastro, nel convicino della chiesa parrocchiale di “S.ti Petri” (ASCZ, Notaio F. Cerantonio, Busta 196 prot. 880, ff. 131v-132v).
[lx] In merito all’obbligo riguardante l’università di Policastro, circa la processione della Santa Spina che giungeva dal monastero per attraversare le vie dell’abitato di Policastro, il Mannarino afferma: “La quale in tal caso sta in obligo di corrispondere sopra l’altre spese à quella della luminiera; che primieramente non era men che di cinquecento libre di Cera lavorata, e la riceve convenuta innanza con tre solenni, e giurati Istrumenti. Il primo nella soglia di quella sua Chiesa. Il secondo nel Ponte, ed’il terzo nella Porta del Castello, o sia l’istesso strumento, che si legge in questi tre luoghi; e si stipulano tre atti consinentino di renderla il secondo giorno à Frati.” Mannarino F. A., Cronica della Celebre ed Antica Petilia detta oggi Policastro, 1721-1723.
[lxi] “La forma della Città è due parti lunga e una larga, quasi in figura di Cilindro, ma distorto alquanto e fuorche nella parte occidentale, ove era già il famoso e superbo Castello, per cui si esce in piano, pendendo un poco per una inselciata, come che pieni i fossi delle dirupate muraglie, ci si trova immediatamente il Fiume con due Case di molino;” In relazione all’orto posseduto dalla corte di Policastro, il Mannarino afferma: “Tra tutti si singolarizza quello dell’Eccellentissima Corte ch’è il Capo nel più vicino e meglior immediato luogo alla Città, per detta Porta per cui come dissi s’esce in piano.” Mannarino F. A., Cronica della Celebre ed Antica Petilia detta oggi Policastro, 1721-1723.
[lxii] Mannarino F. A., Cronica della Celebre ed Antica Petilia detta oggi Policastro, 1721-1723.
[lxiii] 23.09.1633. Il presbitero D. Joannes Jacobo de Aquila, permutava una casa palaziata “con una parte di muro un poco scarropata seu Cascata dalla parte di sotto”, posta nel convicino di S.to Nicola “delli greci”, con un casalino di Martino Vecchio, “con parte delle mura un poco alti”, assieme allo largo “sotto parte detto Casalino per derittura della chiesa di santa Maria dell’angeli per derittura della Cantonera” della casa di Gio: Vincenzo Riccio, appartenuta al quondam Fran.co de Jacobo, “ferente all’istrata publica verso lo cortiglio” di Fran.co Grosso, “una con lo casalino accanto di detto Casalino grande ferente verso la porta del Castello, confine la chiesa di Santo Nicola delli Cavaleri”, via pubblica mediante, che detto Martino aveva comprato da Fran.co Venturo de Oratio. ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 300, ff. 076v-078.
[lxiv] 29.10.1617. Il “casalino novamente fabricato” appartenente all’eredità di Nardo Tuscano, era posto dentro la terra di Policastro, nel convicino di S.to Nicola “delli Cavaleri”, confine l’altra casa ereditaria contigua, “et la via publica del Castello” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 291, ff. 060-061v).
[lxv] AASS, 37A.
[lxvi] ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 294, ff. 087-088v.
[lxvii] 25.05.1634. Antonino Gatto vendeva a Joannes Cepale, “lo largo seu ortale” posto “de sopra la timpa”, vicino la casa di Renzo Jerardo e la casa di Giulio Doratio appartenuta al quondam Gio: Dom.co Sacco, confine “lo vallone vallone et la istrada che scende dalla santiss.a nuntiata alla porta della terra detta la Judeca” ed altri fini. (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 301, ff. 098v-099v).
[lxviii] 21.07.1631. Anna Cavarretta asseriva che, l’anno passato, suo marito Antonino Gatto, aveva venduto a Fran.co Marchese, una “Camera” palaziata posta dentro la terra di Policastro, nel convicino di S.ta Maria “la gratia”, confine la casa “grande” di detto Antonino, “le casalina” appartenute al quondam Gio: Dom.co Sacco, “la istrata che si scende alla porta della terra ditta la giodeca”, ed altri fini. La detta camera era stata comprata dal detto Fran.co, in maniera che servisse a Caterina Marchese, sua sorella, ed al marito di questa Fran.co Popaianni. Il detto Fran.co però non aveva pagato, ed il detto Antonino si era dovuto indebitare anche per “la malannata, che questo inverno e stata”, finendo in carcere per debiti. (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 298, ff. 052-053). 01.12.1653. Gio: Andrea Sacco di Policastro, ma al presente “habitante” nella terra di Mesuraca, vendeva a Gianne Jerardo, padre di Lucretia e nipote del detto Gio: Andrea, “due Casalena dirute cum uno horticello”, posti dentro la terra di Policastro nel convicino della chiesa di S.ta Maria “la gratia”, confine le case di detta chiesa, le case di Fran.co Papaianni, “la via che si và alla Porta della Giudeca” ed altri fini, mentre l’orto confinava con la casa di Andrea Rocciolillo, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio F. Cerantonio, Busta 196 prot. 878, ff. 084v-085).
[lxix] 10.10.1641: Dietro la richiesta di Antonio de Strongolo, il notaro si portava in “loco ubi dicitur la Crocevia di S.to Nicolò delli Greci, iusta predictam Ecc.am viam bublicam et alios fines”, per stipulare il suo testamento. ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 307, ff. 017-018v.
[lxx] ASCZ, Notaio G.B. Guidacciro, Busta 78 prot. 287, ff. 077v-079.
[lxxi] L’esistenza di questa porta è documentata da una platea del 1576, dove risulta che la Mensa Arcivescovile di Santa Severina, possedeva in Policastro “una bottega dentro detta Terra alla piazza, iuxta le case di m.co Matteo Campana, e la porta della piazza, la via pubblica, et altri confini della quale paga annuatim ut s.a grana dieci d. 0.0.10” AASS, 1A.
[lxxii] 07.05.1645. Il chierico Joannes Andrea de Cola e suo fratello Joanne Thoma, figli ed eredi dell’olim Jacintho de Cola, possedevano in comune ed indiviso, la “Casa Nova, et Casalino” posto nella terra di Policastro “vicino la Porta della Piazza” (ASCZ, Notaio G. M. Guidacciro, Busta 182 prot. 804, ff. 066-069v). 20.01.1647. La vedova Delia Callea, Laura Guarano e Joannes Bernardino Accetta, in solido, prendevano a censo dal R.do D. Jo: Jacobo Aquila, la somma di ducati 80 impegnandosi a pagare l’annuo censo di ducati 8. Tra i beni stabili posti a garanzia dal detto Joannes Bernardino in questa occasione, troviamo la “Continentiam Domorum” “cum Orto Conticuo”, costituita in più membri e posta dentro la terra di Policastro nella parrocchia di S.to Nicola “de Platea”, confine la via pubbblica, “et propem Portam nuncupatam della Piazza”, la domus del R.do D. Salvatore Maijda “à parte superiori, et pp.o ubi dicitur la ruga delli Vitilli, et ripas seù menia dictae Civitatis” (ASCZ, Notaio G. M. Guidacciro, Busta 182 prot. 806, ff. 011v-016).
[lxxiii] 27.03.1606. Isabella Misiano, vedova del quondam Joannes Dom.co Prioli, insieme con i figli Horatio e Joannes Baptista Priolo, vendeva ad Angilo Cropanese, una “domum terraneam” posta “intus p(raedi)ttam terram in Convicinio Ecclesie s.te Marie de Fragisi iusta rupas oleastri, et viam quod escitur foris dittam terram iusta domum ipsorum de priolo, et viam publicam” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 286, ff. 161v-162v).
[lxxiv] Agli inizi del Seicento, una “platea veteri” dell’abbazia di Sant’Angelo de Frigillo, documenta che Gio: Vittorio Monaco possedeva un ortale “in loco d.o Strata nova, iuxta la porta nova di d.a Terra”, per il quale pagava il censo alla detta abbazia. AASS, 124B.
[lxxv] 10.07.1606. Fran.co Antonio Scandale permutava la “camera unam sive domum palatiatam”, posta nella terra di Policastro “in convicinio ecclesie santi nicola de grecis”, nonché un “casalenum” con una “gisterna”, confine la domus del notaro Horatio Scandale, suo fratello, la via pubblica “ditta delo ringo”, la domus “frantam” di Thoma Ceraudo, appartenuta ad Antonina Scandale, con il “casalenum” del detto notaro Horatio posto nello stesso loco, confine il casaleno di detto Fran.co Antonio, l’entrata della sua domus, la domus di Minico Faraco e “vinella seu introitum” del detto Francesco Antonio (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 286, ff. 168v-169v).
[lxxvi] Rende P., La chiesa “Matrice” di San Nicola “de Policastro” nel luogo detto “la Piazza”, in www.archiviostoricocrotone.it
[lxxvii] Guillou A., Les Actes Grecs des Fonds Aldobrandini et Miraglia XI-XIII s., Biblioteca Apostolica Vaticana 2009, pp. 66-70.
[lxxviii] Russo F., Regesto II, 11377, 11380.
[lxxix] 22.02.1608. La “platea publica ubi dicitur lo mezarulo” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 287, ff. 061v-062).
[lxxx] AASS, 1A.
[lxxxi] 25.10.1611. Nell’inventario delle robbe appartenute al quondam Gio: Baptista Larosa, figurava “uno palazzotto loco ditto la piazza confine le casalina di Mutio Campana posto nel convicino di s.to nicola della piazza quale casa fu fabricata per il q.m Gio: Bapt(ist)a larosa” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 287, ff. 209-212v). 20.09.1621. Scipio Misiano acquistava da Gio: Battista de Laratta, la casa palaziata posta dentro la terra di Policastro, nel convicino di S.to Nicola “de platea”, confine l’altra casa di detto Scipione posta nella “piazza” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 293, ff. 053-056).
[lxxxii] 15.10.1604. Testamento di Vespesiano Zupo che si trovava infermo nella “spetiariam Hijeronimi Poeri sitam in Convicino santiss.mi sacram.ti justa domum Agostini Cavarretta justa potecam s.mi sacram.ti viam publicam et alios fines” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro Busta 78, prot. 286 ff. 59v-60v). 19.10.1610. Testamento di Horatio Cavarretta, figlio di Joannes Agostino Cavarretta, abitante nella “domum palatiatam” appartenuta a suo padre, posta nella terra di Policastro, nel convicino della chiesa matrice di S.to Nicola “de platea”, confine l’orto di Carolo Spinelli, l’ “apotecas S.mi Corporis Cristi”, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 287, ff. 167v-168).
[lxxxiii] 18.08.1606. Isabella Rocca donava al chierico Joannes Fran.co Rocca, figlio di Joannes Baptista Rocca suo “avunculum”, la “forge” promessa dal quondam Ant.o Rocca suo “avunculo”, al quondam Sebastiano Rocca suo figlio, padre di detta Isabella (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78, prot. 286, ff. 190v-191). 03.10.1610. Joannes Baptista Rocca vendeva a Sansone Salerno la “domum palatiatam cum Camera Contigua”, posta dentro la terra di Policastro nel convicino della chiesa di S.to Nicola “de platea”, “iusta potegam et alias domos circondatas ipsius Jo(ann)is Bapt(ist)e” (ASCZ, Notaio G.B. Guidacciro, Busta 78 prot. 287, ff. 201-201v). 17.09.1614 Sanzone Salerno, erede e possessore dei beni del notaro Serafino Rizza e di Isabella Rizza, possedeva due “potighe poste nella piazza di ditta terra” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 289, ff. 023v-024v). 23.09.1618. Ferdinando Coco che, negli anni passati aveva acquistato dalla quondam Sabella Rizza la “poticam” posta dentro la terra di Policastro e proprio “in platea publica”, confine la “poticam” di Salvatore Traijna, la domus di Joannes Fran.co Rocca, “aliam poticam” del detto Sanzone, la via pubblica ed altri fini, considerato che la detta bottega “de die in die vadit deteriorando” e non avendo i mezzi per intervenire, la retrocede a Sanzone Salerno erede della detta Isabella “eius avuncule” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 291, ff. 119-119v). 27.07.1620. Il diacono Joannes Fran.co Rocca possedeva l’annuo censo infisso sopra la casa palaziata composta da due membri di Sanzone Salerno, posta dentro la terra di Policastro nel convicino della chiesa matrice di S.to Nicola “della piazza”, confine le altre case di detto Rocca, la “potiga” di detto Sanzone e la via pubblica. Tale censo era stato ceduto al quondam Gio: Battista Rocca, padre di detto diacono, da Scipione Oliverio, primo compratore dell’annuo censo enfiteuitico. Alla data odierna, il detto diacono cedeva al detto Sansone il detto censo che, a sua volta, rinunciava in favore del primo, all’entrata della detta casa dalla parte del “Cortiglio”, come era stato nel passato. Per tale privazione il detto diacono cedeva al detto Sanzone la “potica della parte di sopra” dove al presente abitavano Micco Santella e Laura Lamanno, confine la “camera dello furno” del detto diacono, in maniera tale che, in “detta parte di potica et largo de inansi” spettante a detta bottega, potesse essere fatta una nuova entrata (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 292, ff. 053v-054).
[lxxxiv] 07.01.1633. Nel passato, Sansone Salerno aveva venduto a Jacinto Misiano il “Casalino seu potica deruta”, ovvero “una sua potica deruta loco ditto la piazza di questa Città”, confine la “potica deruta di Santa Maria la spina” e la casa del vicario D. Gio: Fran.co Rocca (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 300, ff. 002-002v). 13.07.1637. Il Cl.o Lutio Venturi, procuratore del monastero della “divae mariae spinis”, vende a Jacinto Misiano, il casaleno posto dentro la terra di Policastro “in platea publica” nel convicino della chiesa di S.to Nicola “de platea”, confine la “potecam” del detto Jacinto, la domus e l’orto di Joannes Antonio Costantio, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 304 ff. 050v-052). 11.05.1638. Davanti al notaro compaiono Caterina Rocca, con il consenso di Joannes Vittorio Fanele suo marito, e Anastasia Rocca, con il consenso del marito Joannes Antonio Costantio, assieme a Jacinto Salerno che, essendo eredi del quondam D. Gio: Fran.co Rocca loro fratello, nonchè zio di detto Jacinto, detenevano in comune ed indiviso la continenza di case palaziate con “gisterna, Cortiglio et orto”, posta dentro la terra di Policastro nel convicino della chiesa matrice di S.to Nicola “della piazza”, confine le case di detta Anastasia, le case di Gio: Vittorio Fanele, “la potica” di Jacinto Misiano, il casalino di Stefano Capozza, la via pubblica da due parti ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 305, ff. 043v-045v). 06.12.1639. Considerato che per alcuni suoi “negoti”, Jacinto Misiano si apprestava a conferire nella città di Napoli, dove riteneva di “far lunga dimora”, lasciava a Rosa Romano i suoi beni tra cui la sua “potega” posta dentro la terra di Policastro “loco ditto la piazza” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 306, ff. 135-135v). 27.07.1642. I coniugi Joannes Antonio Costantio e Anastasia Rocca, quali successori dell’eredità del quondam D. Gio: Fran.co Rocca, vendevano ai coniugi Dieco Cepale e Claritia Paudari, la casa palaziata consistente in tre membri di cui, uno “coverto” ed altri due “scoverti, et diruti per Causa di terrimoti”, posta dentro la terra di Policastro nel convicino di S.to Nicola “della Piazza”, confine la “potegha” di Jacinto Misiano, il casalino di Stefano Capozza appartenuto al quondam Salvatore Traijna, le case di Caterina Rocca sorella di detta Anastasia, “muro coniunto” e le case di detti venditori “della parte di sop.a”, “muro coniunto” (ASCZ, Notaio G. M. Guidacciro, Busta 182 prot. 801, ff. 100-101v).
[lxxxv] 07.08.1618. Petro Ant.o Scandale, a titolo di dote, dona ai coniugi Andrea Campana e Lucretia Scandale, la “poticam” posta “intus plateam p(raedi)ttae Civitatis”, confine la “potecam” di Scipione Romano “a parte superiore”, “et apocam aliam ipsius Petri antoni, et domum a parte superiori Mutii Campane”, la via pubblica ed altri fini, con il patto che il detto Andrea avrebbe potuto fare a sue spese un muro “in mezo luna, et l’altra potica” (ASCZ, Notaio G.B. Guidacciro, Busta 78 prot. 291 secondo ff. 101-102; foto 016-017). 18.02.1623. Antonella Campana vedova del quondam Fran.co de Cola, vendeva al Cl.o Joannes Ber.no Accetta suo nipote, il “palazzettum cum Camera super potecas Petri Antoni Scandalis Joannis Dom.ci Campana et Scipionis Romano”, posto dentro la terra di Policastro nel convicino della chiesa matrice di S.to Nicola “de platea” confine la via pubblica da tre lati, l’orto del notaro Fran.co Accetta, via mediante, ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 294, ff. 071-072). 31.07.1626. In ragione della dote promessa, Petro Ant.o Scandale cedeva a sua figlia Vittoria Scandale ed a Gio: Petro Levato suo genero, “la potica della piazza di detta Citta sotto parte le case di Jacinto de cola”, che erano appartenute a D. Gerolimo Campana, confine “la via publica che si va alla ruga delli vitilli”, “la potica” di Gio : Dom.co Campana, “la via publica della piazza” ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 296, ff. 055v-056v). 13.07.1637. Il Cl.o Lutio Venturi, procuratore del monastero della “dive marie spinis”, vendeva a Jacinto Misiano, il casaleno posto dentro la terra di Policastro “in platea publica”, nel convicino della chiesa di S.to Nicola “de platea”, confine la “potecam” di detto Jacinto, la domus e l’orto di Joannes Antonio Costantio, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 304, ff. 050v-052). 29.01.1638. Giunte le parti ad un accordo, il Cl.co Joannes Dom.co de Cola e la “sorore” Caterina de Cola, cedevano ai loro fratelli minori: Carolo, Bartolo, Leonardo, Joseff e Maria de Cola, ossia al loro curatore Marcello Leusi, alcuni beni appartenuti al quondam Fran.co Antonio de Cola loro padre, ed alla quondam Isabella Consiglio loro madre, tra cui la casa palaziata con “gisterna” consistente in 3 membri, posta dentro la terra di Policastro, nel convicino della chiesa “matrice” di S.to Nicola “della piazza”, confine le case di Jacinto de Cola, “la piazza publica” ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 305, ff. 009-011). 15.02.1638. Dietro istanza di Anastasia e Caterina Rocca, sorelle del quondam D. Gio: Fran.co Rocca, e di Jacinto Salerno, eredi del detto quondam D. Gio: Fran.co, il notaro con il giudice ed i testimoni, ed alla presenza del sig.r D. Dieco de Castelli, reg.o cap.o di Policastro, si portava nella casa dell’ “Alfiero” Gio: Antonio Costantio, tutore testamentario di detto quondam D. Gio: Fran.co, posta dentro la terra di Policastro, nel convicino di S.to Nicola “della piazza”, confine le case di detto quondam D. Gio: Fran.co Rocca, “la piazza publica”, la via pubblica ed altri fini. Come tutore testamentario, il detto alfiere aveva provveduto ad inventariare le robbe del detto quondam D. Gio: Fran.co, tra cui risultava “uno Casalino di fabrica novo nella piazza di detta terra” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 305, ff. 017v-020). 11.05.1638. Davanti al notaro comparivano Caterina Rocca, con il consenso di Joannes Vittorio Fanelis suo marito, assieme ad Anastasia Rocca, con il consenso di suo marito Joannes Antonio Costantio ed a Jacinto Salerno che, in qualità di eredi del quondam D. Gio: Fran.co Rocca, loro fratello, nonchè zio di detto Jacinto, detenevano in comune ed indiviso, la continenza di case palaziate con “gisterna, Cortiglio et orto”, posta dentro la terra di Policastro, nel convicino della chiesa matrice di S.to Nicola “della piazza”, confine le case di detta Anastasia, le case di Gio: Vittorio Fanele, “la potica” di Jacinto Misiano, il casalino di Stefano Capozza, la via pubblica da due parti ed altri fini. Nella divisione dei beni appartenuti al quondam D. Gio: Fran.co Rocca, al detto Jacinto spettarono la casa, o camera, affacciante verso la casa di C. Gio: Dom.co de Cola. Apparteneva invece alla detta Anastasia il “palazzo di finire”, posto dentro la terra di Policastro loco detto “la piazza”, confine l’orto di Giangerolimo Blasco e la via pubblica da due parti, con il quale andava incluso il casalino “di sotto seu largo”, sotto parte di detto palazzo, confine il “muro” di detto di Blasco, Fran.co Giannino e la via pubblica. Apparteneva alla detta Anastasia anche il “largo” posto avanti detto palazzo, sopra parte delle case di detta Anastasia, confine la “potica” di Jacinto Misiano, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 305, ff. 043v-045v). 12.02.1647. Catharina Cavarretta comprava da Bartholo de Cola suo cognato, la “portione” posseduta da quest’ultimo di 3 “Camere, una potegha di sotto con gisterna intrada et scala”, che il detto Bartholo deteneva in comune ed indiviso con i suoi fratelli Carlo, Leonardo e Giuseppe di Cola. Il bene era posto dentro la terra di Policastro nella parrocchia di S.to Nicola della Piazza, confine “muro cogniunto”, l’altra casa dotale di detta Catherina appartenuta alla quondam “soro” Catherina de Cola, le case degli eredi dell’olim Gio: Vittorio Fanele via mediante, “la via publica che si và nella Piazza” ed altri fini (ASCZ, Notaio G. M. Guidacciro, Busta 182 prot. 806, ff. 021-023). 18.01.1654. Carulo de Cola vendeva al presbytero Joannes Antonio Leuci, la “continentia de Case consistentino in cinque Camere coverte, et una scoverta cum gisterna di dentro et poctega, ch’esce nella strada publica cum l’airi d’adalto, et abasso”, posta dentro la terra di Policastro nel convicino della chiesa parrocchiale di S.to Nicola “della Piazza”, confine le case di Fran.co de Cola, la via pubblica ed altri fini, gravata del peso di annui carlini 10 sopra la detta “Pottega” alla chiesa di “S.to Pietro” (ASCZ, Notaio F. Cerantonio, Busta 196 prot. 879, ff. 003-005).
[lxxxvi] 21.09.1616. Mutio Campana vendeva a Joannes Paulo e Laurentio Caruso, padre e figlio, la domus palaziata “Cum Camera” posta dentro la terra di Policastro nel convicino della chiesa di S.to Nicola “de platea”, “iusta Ecc.m santi angeli ditti la ruga delli vitilli vinella mediante iusta plateam publicam detta de l’astrachello” la via pubblica ed altri fini. Il detto Mutio asseriva di possedere “aiurum tantum a parte superiori ditte domus, et Camara”. (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 290, ff. 132-133).
[lxxxvii] 09.08.1626. Jacinto de Cola vendeva al clerico Joannes Fran.co Cepale, il “palazzettum” con il “Cammarozzum a parte superiore”, posto dentro la terra di Policastro, nel convicino della Matrice di S.to Nicola, confine l’orto del notaro Joannes Fran.co Accetta, via pubblica mediante, “l’astrachello della piazza” ed altri fini. Considerato che, dalla parte di sotto di detto palazzetto, vi erano “le potiche” di Petro Ant.o Scandale, Gio: Dom.co Campana, Scipione Romano e Giulio Berricello, la vendita “se intenda l’aria di sopra di dette potiche con lo cammarozzo” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 296, ff. 058-059). 11.02.1635. Elena Scandale, vedova del quondam Fran.co Cepalis, madre e tutrice dei figli di detto quondam Fran.co, vendeva a Renzo Schipano, la domus palaziata con camera “Cioè l’ario di sopra tantum et non altro”, con la quale andava inclusa “la potica di vascio vicino la scala di detta Casa”, posta dentro la terra di Policastro, nel convicino di San Nicola “de platea”, confine la “Ecclesiam Santi Angeli deruta”, vinella mediante, la via pubblica ed altri fini. Si pattuiva che detto Renzo potesse fare la porta della detta casa “affacciante alla ruga delli vitilli” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 302, ff. 020-020v).
[lxxxviii] 10.12.1617. “Acensito nel luco dove se dice l’astrachello loco publico, et solito ad incantarsi robbe eseq.te contra debitori” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 291, ff. 068-073). 20.09.1618. Si procede all’incanto nella “platea publica quod dicitur dell’astrachello ubi alia buona fieri solent” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 291 ff. 108v-114v). 15.02.1621. Si procede all’incanto nella “publica platea”, “ad locum ubi dicitur l’astrachello in quo solitum est subastari bona quae vendantur de ordine Curie” (ASCZ, Notaio G.B. Guidacciro, Busta 79 prot. 293 ff. 001v-004).
[lxxxix] ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro Policastro, Busta 78 prot. 286, ff. 117v-119v, 119v-120v, 144v-145v, 155v-156, 158-158v, 189-190v; Busta 78 prot. 287, ff. 019v-020, 027-028, 031v-032v, 034v-035, 063-063v, 085-086v, 093-094v, 104v-105, 106-107, 107-107v, 108-108v, 176-178; Busta 78 prot. 288, ff. 009-011v, 087v-088, 097v-098, 103v-104, 104-105; Busta 78 prot. 289, ff. 002v-002(bis)v, sciolti s.n., ff. 027v-028; Busta 78 prot. 290, ff. 023-025v, 029-030, 102v-103, 120v-121v, 135v-136v; Busta 78 prot. 291, ff. 064-065, 068-073, 092-093, 093-093v, 097v-098; Busta 78 prot. 292, ff. 032-032v, 063-064, 064-064v; Busta 79 prot. 293, ff. 004-006v, 021v-022v; Busta 79 prot. 294, ff. 017v-018, 019-019v; Busta 79 prot. 295, ff. 013v-014v, 040v-054, 058v-059, 167v-168; Busta 79 prot. 296, ff. 017v-018v; Busta 79 prot. 297, ff. 012v-013v, 029-032; Busta 79 prot. 299, ff. 010-011, 011-011v, 044v-045v; Busta 79 prot. 300, ff. 010v-011, 048-049; Busta 80 prot. 302, ff. 041v-043, 044-045; Busta 80 prot. 303, ff. 037v-042, 042v-048; Busta 80 prot. 305, ff. 077-078, 107v-108v; Busta 80 prot. 306, ff. 084-085, 119v-124v. ASCZ, Notaio G. M. Guidacciro, Busta 182 prot. 801, ff. 023-032v, 044-045, 052-053v, 125v-128v; Busta 182 prot. 802, ff. 029v-031; Busta 182 prot. 803, ff. 065-066v; Busta 182 prot. 804, ff. 175v-179. ASCZ, Notaio F. Cerantonio, Busta 196 prot. 874, ff. 009-011v, 046-047, 051-052, 059-060v, 085v-086v; Busta 196 prot. 875, ff. 043-045; Busta 196 prot. 876, ff. 019v-020v, 080-081.
[xc] ASN, Tesorieri e Percettori Fs. 550/4154 ff. 121-123v.
[xci] ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 295, ff. 171-17.
[xcii] AASS, 16B.
[xciii] “per manutenzione dell’orologio D.i 7.” Sisca D., Petilia Policastro, 1964, p. 137.
[xciv] Ibidem, p. 138.
[xcv] ASCZ, Notaio G. M. Guidacciro, Busta 182 prot. 802, ff. 088v-089v e 108-109v. ASCZ, Notaio F. Cerantonio, Busta 196 prot. 878, ff. 048-050.
[xcvi] ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 291, ff. 042v-043.
[xcvii] ASCZ, Notaio G. M. Guidacciro, Busta 182 prot. 802, ff. 078v-084.
[xcviii] ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 288, ff. 008-008v.
[xcix] ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 287, ff. 143v-144.
[c] Mannarino F. A., Cronica cit., 1721-1723.
[ci] 13.05.1578. Joannes Maria Calcagno, “ser. or.s” della terra di Cutro, nonché “Com.s deputatus per mag.m Cur.e Vic.e”, dietro l’istanza del m.co Horatio de Modio della terra di Simeri ed in forza di una obbligazione della detta “mag.a Cur.e”, attraverso tre bandi consecutivi effettuati nei “loca pu.ca solita et Consueta p.te t(er)rae policastrii”, ovvero “in t(er)ra policastri et prop.e in platea pu.ca dicte T(er)rae dictam l’ulmo vecchio”, incantava al m.co Nic.o Fran.co Miniardo del casale di “Rullani”, i beni di Joannes Dom.co Priolo e degli eredi del quondam Fran.llo Cortisio della terra di Policastro, relativamente ad un credito di 350 ducati vantato dal detto Horatio, quale residuo di una somma maggiore (ASCZ, Notaio Santoro M., vol. VII, ff. 68-73v). 28.10.1603. Alla presenza di Gio: Battista Oliverio, luogotenete del regio tesoriere di Monteleone, del notaro Joannes Fran.co Accetta e del regio capitano, il servente Francisco Gallo provvedeva a incantare “lo feudo di Andriuli orrico et mangiacardone”, nel luogo detto “alla piazza publica dell’ulmo vecchio” (ASN, Tesorieri e Percettori Fs. 558/4162, ff. 131). 12.10.1615. Nella “publica platea ubi dicitur lulmo vecchio dittae Civitatis loco solito et consueto”, Paulo Luchetta, ordinario servente della regia Corte di Policastro, procedeva “more solito”, mediante unico incanto, alla vendita dei beni di Stefano Capozza, moroso nei confronti del fisco per la somma di 50 once (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 290, ff. 050v-052).
[cii] 05.09.1623. Nella “platea publica, et proprio dove se dice l’ulmo novo”, dietro l’istanza di Hijeronimo e Petritia Salerno, cessionari del quondam Fran.co Ant.o Salerno, Joannes Dom.co Cappa, ordinario serviente della regia Curia di Policastro, aveva provveduto ad incantare a Joannes Thoma Tronga, la possessione di Joannes Thoma Cepale carcerato per debito (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 294, ff. 104v-106v). Il 30.06.1625. Nella piazza pubblica “et proprio dove se dice l’ulmo novo”, Laurentio Ceraldo “publicus serviens Reg.a Curia Civitatis Policastri”, dietro l’istanza del chierico Ottavio Vitetta, procuratore del monastero di S.ta Maria detta “le manche”, provvedeva all’incanto delle terre appartenute al quondam Mattio Vecchio lasciate al detto monastero (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 295, ff. 130v-133). 04.03.1626. “dove si dice l’ulmo novo” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 296, ff. 022v-025). 28.08.1627. In platea pubblica “ubi dicitur l’ulmo novo” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 296, ff. 138-142v). 18.06.1629. “in platea publica ubi dicitur l’ulmo novo” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 297, ff. 052-053v). 09.11.1632. “in platea publica ubi dicitur l’ulmo novo” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 300, ff. 102-105).
[ciii] Nell’agosto del 1599, si procedeva all’affitto delle entrate baronali, attraverso tre bandi successivi in “plateam publicam et alia loca solita et consueta” della terra di Policastro. In tale occasione, si evidenziava che gl’interessati a prendere in affitto i beni della Corte, sarebbero dovuti comparire “in anti lo palazzo dela sala nova di d(it)ta Reg.a Corte” (ASN, Tesorieri e Percettori Fs. 550/4154 ff. 121-123v).
[civ] 21.07.1240. “in Aquis sub ulmo majoris ecclesie” Huillard-Bréholles J.L.A., Historia Diplomatica Friderici Secundi, Parigi 1859, Tomo V pars II, p. 1019.
[cv] Alla fine del Seicento, nella descrizione della chiesa del SS. Salvatore di Santa Severina, si riferisce: “In detta chiesa vi sono due campane, e avanti di essa vi è un piede d’olmo e Piazza” (Apprezzo della Città di Santa Severina, in Scalise G. B. (a cura di), Siberene, cit., p. 98).
[cvi] 23.08.1636. Il not.o Joannes Leonardo de Pace vendeva a Joannes Simone Arenda, la domus palaziata “cum logetta, et orto Cortiglio cum uno pede di celso”, posta dentro la terra di Policastro nel convicino di S.to Nicola “de grecis”, confine la domus di Elisabetta Conm.ti, vedova del quondam Santori Sagaci, un’altra domus di detto notaro dalla parte superiore e l’altra “Canmera” di detto notaro “affacciante à santo dimitri”, confine la casa di Donno Santo de Pace gravata dal peso di ducati 6 da pagarsi a D. Gio: Battista Favari. Si menziona “lo largo di avanti donno santo et stefano apa”. Il detto notaro dava a detto Joannes Simone “la strata seu intrata per andare in detta Casa ut sup.a venduta per la piazza dove si ha da sbarrare l’orto per intrare in detta Casa” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 303, ff. 104v-106). 26.05.1645. Il notaro Joannes Leonardo de Pace possedeva la domus palaziata posta dentro la terra di Policastro in parrocchia di “Sancti Petri iuxta publicam Plateam à parte superiori”, la domus di Joannes Thoma de Pace, il “vallonem dictum de Pantisano”, la domus di Thoma Lamanno, la domus di Joannes Hyeronimo Blasco ed altri fini (ASCZ, Notaio G. M. Guidacciro, Busta 182 prot. 804, ff. 077v-081). 06.08.1645. Il notaro Joannes Leonardo de Pace vendeva al Rev.s D. Prospero Meo di San Mauro, la “Domum cum Camera” posta nel convicino della chiesa parrocchiale di “Sancti Petri”, confine la “publicam Plateam”, la domus di Joannes Thoma de Pace, “muro coniuncto”, un’altra domus del detto notaro, “muro coniuncto”, la domus del Rev.s D. Sancto de Pace, “muro coniuncto” ed altri fini. Si pattuiva che il detto D. Prospero avrebbe avuto l’entrata e l’uscita della detta casa “per lo Cortiglio et Vallone di esso Notario” (ASCZ, Notaio G. M. Guidacciro, Busta 182 prot. 804, ff. 096-098v). 12.10.1653. Gio: Tomaso de Pace, asseriva di possedere numerosi beni stabili e mobili, tra cui la “Continentia de Case” consitenti in più “membri”, “cum Cortiglio, e Gisterna” ed, in particolare, “due Camere d’edalto”. Il detto Gio: Tomaso de Pace, per consentirgli di studiare ed ascendere agli ordini sacerdotali, donava al Cl.co Antonino de Pace, suo figlio, le due “Camere d’adalto, che affacciano alla Piazza cum le gelusie” (ASCZ, Notaio F. Cerantonio, Busta 196 prot. 878, ff. 077-078).
[cvii] ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 287, ff. 077v-079; Busta 78 prot. 291, ff. 098v-099v.
[cviii] 08.04.1607. Davanti al notaro ed al cospetto del parroco, si costituivano Ottavio de Pace e sua moglie Isabella Apa da una parte e, dall’altra, Joannes Caccurio, per stipulare i capitoli relativi al matrimonio tra il detto Joannes e Lisabetta de Pace, figlia dei detti Ottavio e Isabella. Apparteneva alla dote un “casalino nella piazza cioè all’ulmo per far una potega” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 287, ff. 013v-015). 28.10.1612. Per permettergli di accedere all’ordine sacerdotale, Ottavio de Pace, donava al chierico Santo de Pace suo figlio, la “domum palatiatam in duobus membris consistentem cum scala vignano, et gisterna sotto di detto vignano cum solito int.o et exito”, posta dentro la terra di Policastro, in convicino della chiesa di S.to Nicola “de grecis”, confine la via pubblica dalla parte superiore “accanto l’ulmo”, confine un’altra “domum magnam” di detto Ottavio ed altri fini, gravata dall’onere annuo di dieci carlini da pagare alla baronessa di Cotronei e Corigliano (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 288, ff. 047v-048).
[cix] 11.08.1604. Testamento di Lucretia Carcello stipulato nella domus di Vergilio Caccuri, posta “intus p(raedi)ttam terram in convicino Ecclesie santi dimitri”, confine la domus di detta Lucretia la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78, prot. 286, ff. 39-39v). 09.01.1614. Al fine di permettergli di potere accedere agli ordini sacerdotali, Lucretia Carcello, ava del chierico Joannes Fran.co Caccuri suo nipote, gli donava una domus posta dentro la terra di Policastro “in Convicinio domus ditta la sala”, confine la domus di Vergilio Caccuri (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 289, ff. 002-002v). 31.08.1625. Ottavio de Pace vendeva a Fran.co Turtorella ed a sua moglie Berardina Spano, la domus palaziata con camera contigua similmente palaziata con “gisterna”, “et largo di essa ferente della Cantonera di detta Casa al vallone preter lo largo q.m Santori Sagaci”, posta dentro la terra di Policastro nel convicino di S.to Nicola “de grecis”, “justa salam Contiguam dittae domum derutam”, confine il casaleno di Joannes Baptista de Albo de Cola, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 295, ff. 135v-137). 15.11.1627. I fratelli Petro Curto e Cl.o Matteo Curto, detenevano in comune ed indiviso per successione paterna, la domus palaziata composta in più e diversi membri superiori ed inferiori, consistente in una “sala” e due “Canmare con li vasci” con orto e “gisterna” contigui, posta dentro la terra di Policastro nel convicino di S.to Nicola “de grecis”, nelle vicinanze di quello di San Nicola della Piazza, confine la domus del dottore Mutio Giordano dalla parte superiore, il “palatium dittum lasala” vinella mediante, il casaleno che era appartenuto al quondam Matteo Palazzo, la via convicinale ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 296, ff. 170-172). 20.05.1638. In forza della Bolla data in Roma il 05.01.1637, il R.do presbitero Joannes Andrea Romano, era immesso nel possesso della chiesa parrocchiale di S.to Nicola “grecorum”, posta in convicino delle case del presbitero Leonardo Marchese “et ab altero latere domum ditta la sala” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 305 ff. 051v-052v).
[cx] 02.03.1643. Nella “Platea publica ubi dicitur l’ulmo, iuxta Palatium ubi habitat dictus U.J.D.r Vitalianus, iuxta Parocchialem Ecclesiam Sancti Nicolai Grecorum” ed altri fini, Jacintho de Cola di Policastro, alla presenza dei magnifici Joannes Gregorio Cerasaro e Jacintho Misiano sindaci nel presente anno e degli eletti, si querelava contro Vitaliano Fabiano, “olim” regio capitano di Policastro, “pro admnistrat.ne officii eius Capitaneatus” (ASCZ, Notaio G. M. Guidacciro, Busta 182 prot. 802, ff. 047-049v).
[cxi] 20.02.1621. Laurentio Ceraldo, ordinario servente della regia Curia di Policastro, provvede all’incanto “in platea p(raedi)tta ubi dicitur dell’ulmo della Sala” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 293, ff. 011-012v).
[cxii] 29.06.1636. Donno Santo de Pace vendeva a Joannes Hijeronimo Blasco, un “ortalem seu Solum terrae”, posto dentro la terra di Policastro nel convicino di S.to Nicola “de grecis”, confine la domus di detto Joannes Hijeronimo, la domus di Feliciana Lansetta, i “Casalenos” di D. Joanne Fran.co Rocca, l’orto arborato “sicomorum” di detto D. Santo e la “viam publicam dittam la sala seu piazza”, ovvero la “istrata publica della piazza publica” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 303 ff. 071-072v).
[cxiii] 02.02.1636. Alla dote di Vittoria Curto figlia di Caterina Mazzuca, vedova del quondam Paulo Curto, che andava sposa ad Antonio de Vona, apparteneva una casa palaziata “con la casetta Contigua del furno”, posta dentro la terra di Policastro nella parrocchia di S.to Nicola “delli greci”, confine “la potica” di Betta Mazzuca, la casa di Polita Tavernise, l’orto di Scipione Gardo la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 303, ff. 011-012v).
[cxiv] 07.05.1639. In occasione del matrimonio di Feliciana Mazzuca con Joseffo Amannato di Mesoraca, Dominico Amannato, marito di Lucretia Lanzo, madre di detta Feliciana e “parrastro” di detta futura sposa, pattuiva che, volendo quest’ultima la “potica” confine Caterina Mazzuca ed il casalino di Narciso Rizza, doveva pagaglierli, avendoci egli investito del denaro (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 306, ff. 054-055).
[cxv] 15.02.1646. Marco Antonio Mannarino vendeva al Rev.s presbitero Jo: Paulo Mannarino i seguenti beni: la “Continentiam Domorum” posta dentro la terra di Policastro nel convicino della chiesa parrocchiale di S.to Nicola “Grecorum”, confine la domus di Stephano Capotia “muro coniuncto à parte superiore”, la via pubblica da due lati ed altri fini; due “Casalena” posti dentro la terra di Policastro, nel convicino della stessa chiesa parrocchiale, uno confinante con la “Potecam” di Francisco Curto “à parte inferiori”, ed “à parte superiori” con detta “continentiam Domorum”, l’altro confinante con la domus di Mattheo Cancelli “muro coniuncto”, la via pubblica convicinale ed altri fini. Sia la “Continentiam Domorum” che i due casaleni, erano appartenuti “olim de dominio et possessione” del Rev.s Joannes Andrea Capotia (ASCZ, Notaio G. M. Guidacciro, Busta 182 prot. 805, ff. 020-022). 01.10.1649. Fran.co Curto “publico mercante”, vendeva per il prezzo di ducati 3046 a Michele Curto, i “panni mobili di mercantia cum le sottoscritte merci” esistenti dentro la sua “Pottega sita nelle Case di Pietro Curto” e posta dentro la terra di Policastro nella parrocchia di S.to Nicola “della Piazza” (ASCZ, Notaio F. Cerantonio, Busta 196 prot. 876, ff. 071-073v). 27.08.1652. Alla presenza di Michele Curto, Gio: Dom.co Maccarrone asseriva che, tre anni prima, assieme a questi, aveva comprato dal “mercante” Fran.co Curto, una “potega di panni nobili cum mercie” per la somma di ducati 3000, come appariva per atto del notaro Gio: Matteo Guidacciaro del 17.03.1650. Il detto Gio: Dom.co dichiarava però che in quell’atto, egli era stato solo un prestanome e che il denaro pagato era stato tutto del detto Michele che quindi, era il vero padrone (ASCZ, Notaio F. Cerantonio, Busta 196 prot. 877, ff. 052v-053).
[cxvi] 02.09.1607. Joannes Petro de Aquila e suo figlio Joannes And.a de Aquila, vendevano a Joannes Alfontio Cerasaro, una “domum palatiatam” posta dentro la terra di Policastro “consistente in pluribus e diversis membris, et potica in convicinio Ecclesie santae Mariae la nova”, confine la domus del presbitero Joannes Leotta, Marco Antonio de Aquila, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 287, ff. 037v-039). 28.11.1626. Dietro richiesta di Diana Castelliti, vedova del quondam Marco Antonio de Aquila, il notaro si portava nella domus palaziata consistente in 4 membri “et vasci”, con “Cortiglio, et gisterna”, oltre un’altra “casetta palatiata” che si dice “lo magazeno”, posta dentro la terra di Policastro nel convicino della SS.ma Annunziata “nova”, “in loco ubi dicitur lo fumerello”, confine la domus del presbitero D. Joannes Jacobo de Aquila dalla parte superiore e, dalla parte inferiore, la domus di Joannes Antonio Jannici ed altri fini, per fare l’inventario dei beni del detto quondam Marco Antonio. Tra questi si menzionano due membri terranei “sotto parte la logetta di dette Case uno delli quali si domanda la potighella et l’altra la miseria dove si conserva paglia” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 296, ff. 093-100).
[cxvii] 31.05.1621. Joannes Thoma Richetta donava al Cl.o Joannes Fran.co Cerasaro, la “potecam” posta dentro la terra di Policastro nel convicino della SS.ma Annunziata “nova”, confine la domus di Minico Carvelli dalla parte superiore e Giulia Caira, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 293, ff. 032-033).
[cxviii] 28.02.1622. Minico Carvello e suo figlio Gianni Carvello, donavano a Thomaso Giordano della città di Napoli, assente, i loro diritti sulla “poteca” che, al presente, possedeva Joannes Thoma Richetta, posta dentro la terra di Policastro nel convicino della SS.ma Annunziata “nova”, confine la domus palaziata di detti Minico e Joannes e le vie pubbliche da tre lati (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 294, ff. 014-014v). 02.06.1629. Paulo Luchetta, ordinario serviente della reg.a Curia di Policastro, dietro l’istanza di Joannes Carvello, procuratore di Paulo Carvello al presente commorante in Napoli, cessionario di Thoma Jordano, contro il quondam Thoma Richetta ed i suoi eredi, immetteva il detto Paolo nel possesso della “apoteca” posta in Policastro nel convicino della SS.ma Annunziata “nova”, “in loco ubi dicitur lo fumarello”, confine la domus di suo fratello de Carvello, la domus di Julia Caria e la via pubblica da due lati (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 297, ff. 022v-024). 04.06.1630. Il notaro si portava nella “potecam Consalvi steriti dittam Joannis Carvelli ubi dicitur lo fumerello”, confine la domus di detto Joannes Carvelli, per stipulare il testamento di Alfonso Campitello (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 297, ff. 113v-115). 14.08.1631. Per consentirgli di ascendere agli ordini sacerdotali, Elisabetta Corigliano, vedova del quondam Joannes Thoma Richetta, donava al Cl.o Carolo Leonardo Richetta suo nipote, la “apotegam” posta dentro la terra di Policastro loco detto “lo fumarello et proprio subtos domus Jo(ann)is Carvello, la via pubblica ed altri fini” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 298, ff. 054v-057). 01.06.1634. Micael Parente, ordinario serviente della regia Curia di Policastro, in vigore della provvisione della Magna Curia della Vicaria, spedita da Fran.co Spinello marchese di Fuscaldo, dietro l’istanza di Paulo Carvello contro i coniugi Joannes Thoma Richetta e Lisabetta Corigliano, immetteva Joannes Carvello, procuratore del detto Paulo, nel possesso della “apotecam” posta “in loco ubi dicitur lo fumarello”, nel convicino della SS.ma Annunziata “nova”, confine la domus di Joannes Carvello, fratello del detto Paulo, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 301, ff. 102v-105).
[cxix] 10.04.1613. Alla dote di Polita Cimino, figlia di Joannes Laurentio Cimino “alias fegatale”, che andava sposa a Marcello Crocco della terra di Cutro, apparteneva una “casa seu Cammera” della casa dove al presente abitava detto Gio: Laurentio, confine “la casa di polinitia, et santo dimitri, quale Cammera sta affacciante inansi la potica di Gio: Baptista Natale” e la via pubblica (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 288, ff. 076v-077v).
[cxx] 04.07.1616. Volendo entrare come monaco nel monastero della Santa Spina, Vespesiano Pantisano, donava al detto monastero i suoi beni, tra cui: una casa palaziata consistente in “una sala con due Cammare”, posta dentro la terra di Policastro nel convicino della chiesa di “santo dimitri”, confine la casa di Alfonso Caccuri “della parte di sopra”, il casalino “seu casa” del quondam Salusto Luchetta, “et una potiga contigua”, vinella mediante, con “cortiglio, et logetta”. La detta “potiga” era gravata dal peso di annui carlini 16 che si pagavano alla baronessa di Cotronei (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 290, ff. 109-111v). 28.09.1621. Dietro l’istanza di Petro Paulo Serra, marito di Auriae Salerno, e di Fran.co Ant.o e Gerolimo Salerno contro Vespesiano Pantisano, debitore nei loro confronti, il serviente della corte provede ad incantare i beni del detto Vespesiano che rimasero aggiudicati al dottore Mutio Giordano per ducati 350. Tra questi, la domus palaziata con diversi membri “et pergula”, posta dentro la terra di Policastro nel convicno di S.to Nicola “de grecis”, confine la domus di Joannes Dom.co Cappa vinella mediante, la domus di Alfonso Caccurio la via pubblica ed altri fini, nonchè la “poteca” posta dentro la terra di Policastro, confine la domus predetta vinella mediante, gravata da un peso (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 293, ff. 061v-069).
[cxxi] 04.11.1612. Alla dote di Cornelia Rocca che andava sposa a Salvatore di Marco, apparteneva la metà della casa e casalino dove al presente abitava la futura sposa, posta dentro la terra di Policastro nel convicino di “santo dimitri”, confine la casa di Minico Carise, la casa di Tomaso Taranto, “la forgia di mastro Fran.co Comm.ti”, la via convicinale ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 288, ff. 049-050v).
[cxxii] 13.05.1604. Testamento di Laura Carise abitante “iusta Ecclesiam s.ti Nicolai de grecis justa domum Thoma Taranti iusta domum Dominici Rocce viam publicam et alios fines” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 286, ff. 6-6v).
[cxxiii] 16.02.1621. Joannes Dom.co Falcune, procuratore della cappella del SS.mo Sacramento, provvede a mettere all’incanto la domus palaziata del quondam Thomaso Taranto che l’aveva lasciata a detta cappella. La detta domus era posta dentro la terra di Policastro nel convicino di S.to Nicola “de platea”, confine la domus di Santo Ventorino, la domus degli eredi del quondam Joannes Dom.co Rocca, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 293, ff. 006v-008).
[cxxiv] 26.02.1625. Davanti al notaro comparivano Andrea Jerardo e Joannes Dom.co Cavarretta de Nardo, per la stipula dei capitoli relativi al matrimonio tra detto Joannes Dom.co e Vittoria Jerardo, figlia di detto Andrea. Si pattuiva che il futuro sposo, avrebbe dovuto investire una parte del denaro della dote sopra “la forgia”, comprando “Una casa, ò potica dove possa ponere la forgia” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 295, ff. 105-107).
[cxxv] 16.09.1625. Davanti al notaro comparivano Rinaldo Ceraldo della terra di Mesoraca, ma al presente “habitante” in Policastro, e Petro Ercole “de terra ijfonis”, per la stipula dei capitoli relativi al matrimonio tra detto Petro e Rosa Ceraldo, sorella di detto Rinaldo. Appartenevano alla dote: “una forgia” con tutti stigli che sarebbero divenuti del futuro sposo (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 295, ff. 145v-146v). 17.05.1627. Andriana Rizza vedova del quondam magister Fran.co Conm.ti, assieme al C. Joannes Conm.ti, suo figlio maggiorenne, vendevano al magister Petro Ercole della terra di “ijfune” al presente “habitante” in Policastro, la domus terranea “et scala” detta “la forgia”, posta dentro la terra di Policastro nel convicino di S.to Nicola “de platea”, confine la domus di Joannes Thoma Lamanno, la domus di Joannes Hijeronimo Blasco, vinella mediante, la via convicinale ed altri fini, assieme con “lo largo di sopra parte detta potica Cioe ferente dalla Cantonera di detto Gio: Gerolimo per derittura la cantonera di detta forgia dove sono li tannuni”, e dalla parte di “detro detta Cantonera di Tannuni”, confine il casaleno di detto Gio: Thomaso Lamanno, “nel quale muro” detto “m.o” Petro avrebbe potuto farci “la porta, et fare le scale di detto loco della petra grande verso detta Cantonera di Tannuni che sara di cinque palmi di largo per detta scala” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 296, ff. 126-127v).
[cxxvi] 22.08.1634. Davanti al notaro comparivano Joannes Conmeriati figlio ed erede del quondam magister Fran.co Conmeriati e sua madre Andriana Rizza, assieme a Petro Ercole di Policastro. Negli anni passati, la detta Andriana e detto Gianni avevano venduto a detto Petro una casa terranea detta “la forggia”, posta dentro la terra di Policastro nel convicino della matrice di S.to Nicola “della piazza”, confine la casa di Gio: Thomaso Lamanno, Giangerolimo Blasco ed altri fini per la somma di ducati 27, relativamente ai quali detto Petro si era impegnato a pagare l’annuo censo di carlini 27, come per atto dello stesso notaro del 17.05.1627. Al presente, essendo venuti di comune accordo alla decisione di vendere detta casa al notaro Gio: Leonardo de Pace per ducati 37, considerando il di più di 10 ducati relativi ai miglioramenti fatti da detto “mastro” Petro, ed apprezzati da Battista Mazzuca e dal “mastro” Fran.co Abrozzise, la casa veniva ceduta a detto notaro Gio: Leonardo che, avendo già pagato i detti 10 ducati, s’impegnava a pagare i restanti 27 attraverso lo stesso censo di carlini 27 che pagava il detto mastro Petro (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 301 ff. 129-130).
[cxxvii] 25.07.1635. Il not.o J. Leonardo de Pace vendeva a Stefano Apa, la domus palaziata “cum vascio” “dittam la forgia”, posta dentro la terra di Policastro nel convicino di S.to Nicola “de grecis” confine la domus ed il casaleno di Joannes Thoma Lamanno, ed il casaleno di detto notaro “muro Coniunto” con la detta domus palaziata. Si pattuiva che se detto notaro avesse voluto serrare la porta del “Catoijo” di detta casa, avrebbe dovuto farlo a sue spese, facendo l’entrata di detto catoio “sotto le scale di detta Casa”, mentre il “largo” che era tra detta casa e la casa di Gio: Gerolimo Blasco, restava per detto notaro. Considerato che in detta casa venduta vi era una finestra che affacciava verso il casalino di detto notaro, si pattuiva che questi avrebbe potuto serrarla a proprie spese mentre, la finestra affacciante verso il catoio, doveva essere lasciata nella maniera in cui si ritrovava. Il detto notaro avrebbe avuto la facoltà di “alzare” il casalino “quanto” ad esso sarebbe piaciuto (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 302 ff. 068v-070).
[cxxviii] 05.09.1630. Davanti al notaro comparivano Caterina Caccuri, vedova del quondam Fabritio Priamo, e Fran.co Conmeriati, per la stipula dei capitoli relativi al matrimonio tra detto Fran.co ed Angilella Priamo, figlia di detta Caterina e del detto quondam Fabritio. Il detto Fran.co prometteva di adornare la futura sposa, obligando tutte le sue robbe ed in particolare “la forggia” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 297, ff. 151v-153). 03.01.1635. Ottavio Accetta donava al Cl.o Antonino Accetta suo figlio, la casa palaziata consistente in un membro, posta dentro la terra di Policastro nella “parocchia” di S.to Nicola “delli greci”, confine “la casa della forgia che e delli heredi del q.m fabritio lo priamo”, la casa della quondam Isabella di Florio e la via pubblica da due parti (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 302, ff. 004v-005v).
[cxxix] 12.05.1647. Davanti al notaro comparivano Angila Priamo, vedova dell’olim magister Francisco Commeriati, e Petro Faragò, per la stipula dei capitoli relativi al loro matrimonio. Apparteneva alla dote: la “Potegha dove è stata la forgia” (ASCZ, Notaio G. M. Guidacciro, Busta 182 prot. 806, ff. 056-057v). 15.06.1647. Lupo Campana otteneva dalla chiesa di S.to Nicola “delli Greci” e per essa, dal R. D. Gio: Antonio Leuci, “Vice Parocho” della detta chiesa, un capitale di ducati 35 impegnandosi a pagare l’annuo censo di carlini 35. Tale denaro era quello pervenuto alla detta chiesa, dalla vendita “delli stigli della forgia” lasciati dal quondam “Mastro” Fran.co Converiati, per la celebrazione di tante messe quanto avrebbero permesso l’entrate del detto capitale (ASCZ, Notaio F. Cerantonio, Busta 196 prot. 874, ff. 052-054). 06.10.1647. Davanti al notaro comparivano Joannes Thoma Caccurio, zio di Catharina Caccurio, e Lupo Campana, per la stipula dei capitoli relativi al matrimonio tra la detta Catharina e detto Lupo. In relazione alla costituzione della dote della sposa, il detto Gio: Tomaso s’impegnava a pagare ai RR. Comuneri del clero di Policastro, l’annuo censo di carlini 35 dovuto dal detto Lupo, in relazione al denaro da questi ricevuto in prestito, a seguito della vendita della “forgia” lasciata dal quondam “Mastro” Fran.co Converiati (ASCZ, Notaio F. Cerantonio, Busta 196 prot. 874, ff. 082-084). 05.11.1647. Laura Blasco deteneva l’usufrutto lasciatogli dal quondam Vespesiano Blasco, relativo all’annuo censo di ducati 4 per un capitale di ducati 40, percepito da Ottavio Accetta, per la vendita di una casa palaziata posta dentro la terra di Policastro, nella parrocchia di S.to Nicola “delli greci”, confine “le Case della forgia” del quondam Fran.co Converiati, le case che al presente possedeva Fran.co Castagnino, le vie pubbliche ed altri fini (ASCZ, Notaio F. Cerantonio, Busta 196 prot. 874, ff. 090-091). 02.08.1652. Il R. D. Gio: Antonio Leuci vendeva a Fran.co Naturile la casa palaziata posta dentro la terra di Policastro, nel convicino della chiesa parrocchiale di S.to Nicola “delli Greci”, confine “le Case della forgia” che erano state di Fran.co Converiati de Silvestro, le case di Fran.co Castagnino, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio F. Cerantonio, Busta 196 prot. 877, ff. 046-047v).
[cxxx] 02.05.1646. Feliciana Mazzuca, figlia ed erede dell’olim Baptista Mazzuca, assieme a suo marito Joseph Ammannato, vendeva a Horatio Rocciolillo, il “largum seu locum” dove anticamente era stata edificata la domus appartenuta all’olim Castiglia de Vona, moglie del quondam Dominico Mazzuca, padre di detto quondam Baptista, dove, in una sua parte, si trovava fabbricata la domus terranea “dicta della forggia”. Tale largo era posto dentro la terra di Policastro nel convicino della chiesa parrocchiale di S.to Nicola “Grecorum”, confine la domus degli eredi dell’olim Antonio Lanzo, la domus degli eredi del quondam Benigno Rocciolillo, la domus appartenuta al dominio del R. presbitero Vincentio de Flore, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio G. M. Guidacciro, Busta 182 prot. 805, ff. 042-044).
[cxxxi] ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 301 ff. 129-130.
[cxxxii] 21.08.1625. Nardo Spinello donava alla chiesa della SS.ma Annunziata “nova”, la domus palaziata “dittam la forgia”, posta dentro la terra di Policastro nel convicino della detta chiesa, confine un’altra domus di detto Nardo, la domus di Laurentio Monteleone, la via pubblica ed altri fini, (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 295 ff. 135-135v).
[cxxxiii] 01.09.1634. Il subdiacono Fran.co Venturi e suo fratello Marcello Venturi, vendevano a Mattio Scalise, la domus terranea detta “la forgia” che possedevano in comune, posta dentro la terra di Policastro nel convicino di S.ta Maria “Angelorum”, confine un’altra domus palaziata di detti Venturi, il loro orto dalla parte superiore, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 301, ff. 135-136).
[cxxxiv] 17.09.1627. Il giorno precedente, per ordine della Gran Corte della Vicaria, Laurentio Ceraldo, ordinario serviente della reg.a Curia di Policastro, aveva incantato nella “piazza publica di detta Citta”, dietro l’istanza del dottor Horatio Venturi in qualità di creditore del quondam Petro Carvello, “le case, Casalino et potica” di quest’ultimo, poste nel convicino di S.ta Maria “la grande”, confine le case del quondam Serafino Cavarretta dalla parte di sopra, le case di Gio: Thomaso Cepale, vinella mediante, la via pubblica da due parti ed altri fini. L’incanto era stato aggiudicato a Martino Vecchio e Santo Misiano in solido (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 296, ff. 148v-150). 17.09.1627. Martino Vecchio e Santo Misiano si spartivano i beni acquistati all’incanto il giorno precedente. Detto Martino si prendeva “la casa et Camera” con i confini già descritti, mentre detto Santo si prendeva “la potica” e “lo casaleno scoverto accanto di detta potica”, confine dalla parte di sopra le case toccate a detto Martino. Il detto Martino avrebbe dovuto serrare la porta che affacciava a detto casalino, mentre detto Santo avrebbe potuto fabbricare le mura del casalino e della bottega (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 296, ff. 150-150v).
[cxxxv] 20.01.1635. Davanti al notaro compaiono Martino Vecchio ed il magister Laurenzo Caruso, per la stipula dei capitoli relativi al matrimonio tra detto Laurenzo e Joannella Vecchio, figlia del detto Martino. Appartenevano alla dote la casa palaziata con “una potica” esistente nello stesso loco, posta dentro la terra di Policastro, confine la casa di Alfonso Mazzuca e Gio: Thomaso Cepale vinella mediante (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 302, ff. 009-010v). 24.07.1654. La “Poteca de m(ast)ro Masi Cepale” (ASCZ, Notaio F. Cerantonio, Busta 196 prot. 879, ff. 068-071v).
[cxxxvi] 04.04.1623. Joannes Vittorio Caccurio cedeva al figlio Joannes Fran.co una continenza di case palaziate “Con sala” e due “Camare” dove al presente abitava il regio capitano di Policastro, “con orto, et potichella”, affacciante “nell’istrada publica”, posta dentro la terra di Policastro nel convicino di S.ta Maria dell’Olivella, confine le case del quondam Gio: Thomaso Faraco, la via pubblica da due parti e “la chiesa di santa Maria l’olivella intrada convicinale mediante” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 294, ff. 087-088v).
[cxxxvii] 17.10.1630. Il notaro si porta nella “Potecam” di Joannes Vincenzo Rizza, posta dentro la terra di Policastro nel convicino della chiesa di S.ta Maria “olivarum”, la via pubblica ed altri fini, per stipulare il testamento del magister Fran.co Caloijero del “Casalis Fossati” pertinenza di Taverna (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 297, ff. 178v-179).
[cxxxviii] Mannarino F. A., Cronica cit., 1721-1723.
The post Dalla “terra” medievale alla “città” moderna: lo sviluppo urbano di Policastro (sec. XII-XVII) appeared first on Archivio Storico Crotone.