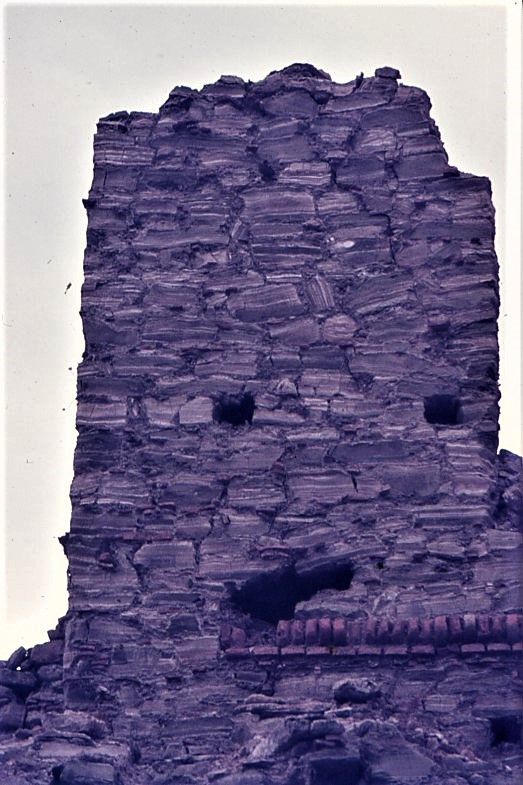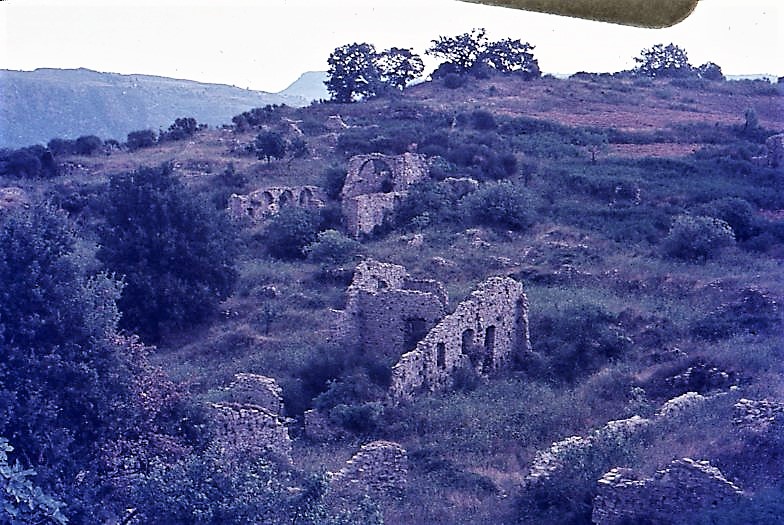La città abbandonata di Cerenzìa Vecchia
Le chiese di Santa Maria delle Grazie e di Santa Maria del Soccorso di Policastro

Statua di Santa Maria della Grazia conservata nella chiesa del monastero di Santa Maria della Spina di Petilia Policastro (KR).
Nel pomeriggio del 9 giugno 1559, il cantore della chiesa di Mileto Giovanni Tommaso Cerasia, vicario dell’arcivescovo di Santa Severina Giovanni Battista Ursini, impegnato nella visita delle chiese di Policastro, dopo essersi recato alla chiesa di Santo Dimitri, e prima di giungere alla chiesa parrocchiale sotto l’invocazione dei “s.ti Pet.i et pauli”, visitò la “ecc.ae s.tae Mariae de gr(ati)a” della quale era cappellano D. Battista Canzonerio.
Qui trovò l’altare di fabbrica ed alcuni beni custoditi in un’arca: tre tovaglie, un coperimento d’altare di tela, due candelabri di creta, una “Cona in tela” davanti l’altare, un “plumacium”, un calice di peltro con patena, un messale, un vestimento sacerdotale di tela completo, tre “amictos”, due “planetas” di tela, due “lintheamina” di tela mentre, dentro un cuscino, erano conservati diversi altri beni vecchissimi e laceri. Una “lampas” era solitamente accesa davanti l’altare, ma al momento si trovava spenta. Nella chiesa esisteva anche un altro altare di fabbrica coperto da un “lintheamen”, mentre nel campanile pendeva una campana mezzana.[i]
Il luogo
La vicinanza della chiesa di Santa Maria delle Grazie alla parrocchiale di San Pietro, che ricaviamo dalla visita del vicario dell’arcivescovo Ursini,[ii] appare evidenziata anche successivamente, mentre, dai documenti della prima metà del Seicento, apprendiamo che tra le case poste nel “convicino” della chiesa,[iii] confinavano con il suo edificio: la casa palaziata di Polita de Simmari,[iv] la domus terranea di Dianora de Maijda, figlia di Hijeronimo de Maijda, che confinava con “le mura di Santa maria la gratia”,[v] e la casa di Blasio Ritia, che confinava con la chiesa di Santa Maria della Grazia, vinella mediante, e si trovava in prossimità delle rupi dette “delle Catarrate”,[vi] dove giungeva un antico fosso, che i documenti di questo periodo chiamano il “valonnem magnum dittum la iudeca”.[vii]
In relazione a tale vicinanza, ed a seguito dei danni riportati dalla chiesa di San Pietro in occasione del terremoto del 1638, in luogo della parrocchiale diruta, le funzioni parrocchiali furono temporaneamente trasferite nella chiesa di Santa Maria delle Grazie.[viii]
A quel tempo, nel convicino della stessa chiesa, lungo “la via che si và alla Porta della Giudeca”, questa possedeva la casa che era stata di Joannes Laurentio Cervino, il quale era stato costretto a cederla a causa dei suoi debiti,[ix] durante la lunga amministrazione del procuratore Ottavio Vitetta. Periodo in cui quest’ultimo si occupò della gestione di alcuni prestiti di denaro, in relazione ai beni ricevuti dalla chiesa per la celebrazione di messe di suffragio.[x]
Oltre alla “Giudeca”, un altro luogo caratteristico posto nelle vicinanze delle chiese di “s.ta maria la gr(ati)a” e di Santa Caterina, spesso richiamato negli atti della prima metà del Seicento, era “la timpa delli Napoli”,[xi] o “rupa ditta delli napoli”.[xii] Le “timpas de Napoli, de Sancta Catharina” (1644) confinavano con la località detta di “Cimicicchio”[xiii] e con le “ripe di questa Città” (1647).[xiv]

Fotopiano di Petilia Policastro (IGM, 1953), il luogo in cui esisteva la chiesa di Santa Maria delle Grazie.
Dalla chiesa del SS.mo Salvatore a quella di Santa Maria del Soccorso
L’esistenza a Policastro di una chiesa dedicata al SS.mo Salvatore, risulta documentata già da un atto del 29 aprile 1615, che menziona un vignale appartenente alla dote di Berardina Caccurio, figlia di Alfontio Caccurio, redditizio per grana due e mezzo “alla chiesa dell’salvatore di detta terra”.[xv]
Alcuni documenti successivi, che ci forniscono notizia di un legato in favore del “santiss.mo Salvatore” di Policastro da parte di Isabella Rizza, evidenziano che questa chiesa esistente nel luogo detto “Lo Salvatore”, cominciò successivamente ad essere chiamata la chiesa di Santa Maria del Soccorso, titolo ricordato in questo periodo, anche riguardo alla fondazione del vicino monastero di Santa Maria delle Manche.[xvi]
Attraverso un atto del 3 settembre 1617, apprendiamo che Sansone Salerno, in qualità di erede del quondam Serafino e di Isabella Rizza, si trovava ad essere creditore nei confronti di Livio Zurlo, nipote ed erede del quondam Gio: Vittorio Monaco, per la somma di ducati 100 di capitale più annui ducati 10 d’interesse, e che la quondam Isabella Rizza, nel suo ultimo testamento, aveva lasciato tale censo alla chiesa del “santiss.mo Salvatore”.[xvii]
Il 20 aprile 1630, nel proprio testamento, Sanzone Salerno disponeva che fosse celebrata una ebdommada a S.ta Maria “del succorso al titolo et nome del S.mo Salvatore”. Disponeva che i ducati 15 che deteneva Stefano Capozza, pagati da Livio Zurlo, andassero in riparazione della detta chiesa “col titolo del S.mo Salvatore”. Disponeva che il censo di carlini 18 che pagavano gli eredi del quondam Juzzolino con le terze decorse, fossero convertite in beneficio di detta “chiesia del Salvatore unita nella visita p(er) n(ost)ro signore ArciV.o nella chiesa del soccorso col titolo delaltare del S.mo Salvatore”, secondo le volontà di sua zia Isabella Riccia. Disponeva ai suoi eredi che, con il denaro del credito che vantava nei confronti dell’università di Policastro sopra la “gabella della farina”, ammontante per capitale e terze decorse a ducati 8000, si edificasse “uno ospidale di poveri contico con d.a chiesia del Salvatore”.[xviii]
Troviamo in seguito che la chiesa di Santa Maria del Soccorso, posta mezzo miglio fuori l’abitato di Policastro,[xix] nel luogo detto anche “lo soccurso”,[xx] lungo la via che conduceva alla “montagna”,[xxi] possedeva un capitale di 50 ducati, che fu detenuto da Vitaliano Larosa, pagando un interesse del 10 % e successivamente, dallo stesso Stefano Capozza procuratore della detta chiesa.[xxii] A quel tempo risultano documentati altri lasciti di denaro[xxiii] e di beni.[xxiv]

Fotopiano di Petilia Policastro (IGM, 1953), il luogo in cui esisteva la chiesa di Santa Maria del Soccorso.
La visita del Falabella
Dopo aver visitato la chiesa della SS.ma Annunziata Nova nel corso della giornata precedente, e prima di dirigersi alla parrocchiale di Santa Maria li Francesi, il 7 ottobre 1660 l’arcivescovo Francesco Falabella visitò la chiesa di “S. Mariae Gratiarum” dove, dopo aver ascoltato la messa, visitò l’altare posto dalla parte occidentale dell’edificio, che trovò ornato con un “pallio laneo” di colore rosso, tre tovaglie, “Carta secretorum”, due candelabri di legno e croce.
Considerato che l’altare era troppo basso, l’arcivescovo comandò che vi fosse sistemato un “lapidem”, in maniera che l’altare raggiungesse, perlomeno, la misura di “unius pedis” “ad basem Columnarum”, ed ordinò che vi fosse infisso un “Lapis Sacratus” entro il termine di un mese. La disposizione risultava impartita nei confronti del chierico Francesco Cavarretta “Cui commendavit curam p(raedi)ctae Ecc.ae”, il cui nome però appare cancellato nel documento con una riga.
L’arcivescovo comandò, inoltre, di dorare il calice e la patena entro e non oltre il termine di 15 giorni. Sopra l’altare vi era la icona dipinta su tela “cum Imaginibus B. M. Gratiarum Sanctorum Petri, Blasii, et Atanasii”.
La chiesa aveva l’obbligo di celebrare la messa alla domenica e nei singoli giorni festivi, mentre le elemosine necessarie erano pagate usando le sue rendite, che ascendevano a circa ducati undici e mezzo annui. Di questa somma, ducati cinque si percepivano dalla locazione di una casa, altri ducati cinque da un censo che pagavano gli eredi del quondam Joannes Berardino Accetta, mentre altri quindici carlini li pagava Joannes Cervino per un censo.
Poiché la chiesa si trovava debitrice nei confronti di Joannes Guarano per la somma di ducati dieci a causa di un “censu decurso”, e di altri ducati sette “in circa” nei confronti di Joannes Dom.co Cervino per un altro “censo decurso”, l’arcivesco comandò, sotto la pena della scomunica “maioris”, che tali somme fossero pagate ai creditori entro tre giorni da parte del procuratore della detta chiesa che, per i poteri di Joannes Baptista Cerasaro, fu eletto il chierico Fran.co Cavarretta.
In un’arca di legno conservata nella chiesa furono trovati: una casula o pianeta di seta bianca, due “Albae”, un messale vetusto che l’arcivescovo ordinò di sostituire con uno nuovo entro il termine di un anno e cinque tovaglie per uso dell’altare.
Per quanto riguardava l’edificio, l’arcivescovo comandò che entro un mese, si riparasse il tetto “in medio” e nelle altre parti dove ciò si rendeva necessario, per evitare che ci piovesse, e di costruire una nuova porta sul lato sinistro “in medio d.ae Ecc.ae”.[xxv]
L’indomani, otto ottobre, l’arcivescovo passò alla visita della chiesa chiamata “S. M. del Succurso” posta fuori dalle mura di Policastro “per statium medii miliarii”, dove ascoltò la messa e visitò l’altare posto nella parte occidentale dell’edificio, che rinvenne coperto con un pallio di seta di diversi colori, corredato con tre tovaglie, “Carta Secretorum”, croce, sei candelabri di legno e “Lapide Sacrato”. L’arcivescovo ordinò di uniformare il piano dell’altare in maniera tale che non eccedesse nel mezzo ed inoltre, ordinò che vi fosse infissa una “tabula Lapidea”.
Qui, l’arcivescovo trovo la “Icona devote depicta in tela cum Imagine B. M. vulgo detta del Succurso, ac Imaginibus S. Blasii Martiris, et S. Apolloniae Virginis”, mentre sopra l’altare si trovava un baldacchino di legno dipinto.
La chiesa non aveva alcun onere di messe, ma vi si celebrava alla domenica per devozione, grazie alle elemosine dei fedeli che erano raccolte dal suo procuratore Dom.co Ammannato. Attraverso la vendita di alcune vacche che erano state ricevute in dono dalla chiesa, il detto procuratore si trovava in possesso della somma di ottanta ducati, che l’arcivescovo dispose fosse impiegata ad un annuo censo.
Le sue “Supellectile” erano costituite da un “Calicem carentem auro à parte interiore”, similmente alla sua patena, che l’arcivescovo comandò di non usare più e di dorare entro il termine di un mese, mentre dispose che fossero puliti ogni mese le “Mappas vulgo detti purificatori”.
Per quanto atteneva invece all’edificio, comandò che fosse rifatta la finestra posta sopra la porta, che fosse sistemato il pavimento “effossum” e che fosse riparato il tetto nelle parti che ne avevano bisogno.[xxvi]

Petilia Policastro (KR), il luogo in cui esisteva la chiesa di Santa Maria del Soccorso in una vecchia cartolina.
Una nuova rendita
La natura di semplice beneficio ecclesiatico su cui si fondava la chiesa di Santa Maria della Grazia, risulta evidente attorno alla metà del Seicento quando, al fine di costituire una rendita adeguata, fu unito all’altro simile su cui era fondata la chiesa di Santa Maria del Soccorso, posta fuori le mura di Policastro.
Risale al 1667, la supplica presentata dal chierico Gio. Angelo Gallotti della città di Lagonegro, diocesi di Policastro Bussentino, all’arcivescovo di Santa Severina Francesco Falabella, affinchè potesse essere promosso al quarto ordine minore, avendo servito il detto presule per tre anni come suo mastro di casa.
Dato che, in questo caso, secondo le disposizioni del Concilio di Trento, gli doveva essere subito conferito un beneficio, e siccome nella sua città non ne esisteva nessuno che gli potesse essere assegnato, chiedeva che i venti ducati di rendita senza peso alcuno, che come legati piii ed elemosine, detenevano le chiese di Santa Maria del Soccorso e Santa Maria delle Grazie di Policastro, fossero eretti in beneficio semplice e che quest’ultimo gli fosse assegnato.[xxvii]
Le notizie successive evidenziano che tale supplica fu accolta, avviando così il consueto passaggio di mano tra clerici, della nuova rendita creata in questo modo, a tutto discapito di un’aministrazione “fedele” dei beni delle due chiese.
Il 15 luglio 1675, l’arcivescovo Mutio Suriano, essendo vacante il “Simplici Beneficio, seu Cappelaniam sub invocat.nem S. Mariae de Succursu, et S. Mariae Gratiarum in Oppido Policastri”, per rassegnazione fatta in Roma il 26 giugno 1675 dal chierico Gio: Battista Martinucci Palermi, ultimo “Beneficiato sive Cappellano, et Possessore”, “Considerando che per la mia assenza da q.elle parti et per non havere in esse ministro fedele, le Chiese di d.o Beneficio vanno in collasso”, lo assegnava al crotonese Carlo Berlingieri commorante in altra città. Per rassegnare il beneficio nelle mani dell’arcivescovo, il Martinucci Palermi costituiva suo “P(at)ronem” il P. Cl. Carlo Infosino, con la clausola che tutti i frutti già maturati e non incassati o che fossero risultati già maturati al giorno della rassegnazione, sarebbero rimasti in suo favore.[xxviii]

Petilia Policastro (KR), corso Giove (dalla pagina facebook I Ricordi dei “Petilini Emigrati”).
In platea
I beni appartenenti ai due benefici uniti nel 1667, compaiono in una “Platea delli Beneficii della Grazia, e Soccorso di Policastro” compilata il primo di gennaio 1728.
“Platea, seu Inventario fatto da me D. Dom.co Rocca del Beneficio sotto
il titolo di S.a M.a delle Grazie, e Soccorso di q.a Città di Policastro oggi 1 G.aio 1728.
(…)
Prim.te la sud.a Chiesa di S. M.a delle Grazie al p(rese)nte si ritrova situata dentro q.a / Città di Policastro giusta li suoi notorii Confini per dentro la quale vi sta l’Alta / re col quadro coll’Imag.e di S.a M.a delle Grazie pittata sopra tela; il sud.o / Altare si trova al p(rese)nte guarnito coll’infra(scri)tti Suppellettili
In p(ri)mis Un Calice con patena d’argento indorati, ed il piede d’ottone, due / Corporali d’orletto, una borsa di più colori, tre veli, seu supracalici di co / lore, un missale Romano, uno Campanello, Sei candelieri di legno / indorati, due fioretti, uno Crocefisso di legno indorato, Carta di Gloria, / In principio, e lavabo, tre tovaglie d’Altare, Un innanzi Altare / di damasco bianco colla sua Cap.a di pietra di tufi lavorati, col suo / … … di tavole pittato, un Camiso di tela fina, Amitto, e / Cingolo, due pianete di damasco colorate, con una Camp.a sopra d.a Chiesa.
Item tiene l’infratte annue Rend.e
Un Capitale di d. 150 affrancandi quandocumque alla Rag.e del Sei / per Cento ipotegato sopra la Gabella d.a Cucoli sita in q.o territorio, / alborata di quercie, e d’altri alberi fruttiferi di capacità di tt.e 70 / in circa confine la terra d.a li Campanari del dominio della Chiesa / M(ad)re di Mesoraca, la foresta piana delli Mag.i Carlo Tronca, Gio: B.a, e Barto / lo Scandale, li Beni di Franc.o Cavarretta, ed altri fini.
Nec non sopra una Continenza di terre di Capacità di tt.e 5 in circa / alberate di quercie sita in q.o territ.o di Policastro nel luogo di Catrivari / confine le terre degl’eredi del q.m Paulo Giordano li Beni della q.m Auria / Mannarino, ed altri fini per come il tutto apparisce dall’Istrum.to censua / rio rogato per il Sig. Notaro Tomaso Nigro di q.a pred.a Città sotto il dì / 13 mag. 1717, cui per se ne percipe ogn’anno d. nove d. 09 : 00.
Item un altro Capitale di d. 50 alla Rag.e del Sette per Cento affrancandi quan / documque debbito dal cl. d. Vitaliano Giordano, e della annualità suddetta / se ne celebrano tante messe al n. di 35 alla Rag.e di Un carlino l’una / come app.e per istrum.to stip.o da M.r Ruggero nell’anno 1713.
Sono l’infratti pesi
Nel giorno della festa per la Celebra.e della Messa Cant.a d. 50
per il jus visitae d. 25
per il quinquennale d. 20
La sud.a Chiesa del Soccorso sta situata fuori q.a Città di Policastro, sotto li / Molini di q.a Camera Principale; vi è l’Altare coll’Imag.e di S. Maria / del Soccorso colla Capp.a di legname pittata con sei Candelieri, Croce, / Carta di Gloria. Solam.e si canta la messa nel giorno della Festa. / Possiede un Ortale vicino d.a Chiesa alborato di Celzi, ed altri alberi fruttiferi.
Pesi
Messa Cant.a nel giorno della Festa d. 50
per il Jus visitae d. 25
per il Jus quinquennale d. 20
D. Dom.o Rocca Rett.e ho fatto scriv.e la p(rese)nte Platea / per mano dell’infratto Reg. Not.o Ant.o Fanele, ed in fede p.a Policastro / la prima Gennaio 1728.”.[xxix]

Petilia Policastro (KR), edicola posta nel luogo in cui esisteva la chiesa di Santa Maria del Soccorso.
Ultimi documenti
La relazione vescovile del 1765 ribadisce che, la chiesa di “Sanctae Mariae Gratiarum”, con un solo altare, dove si trovava eretto un beneficio sotto lo stesso titolo, era retta da D. Cesare Rocca che la possedeva.[xxx] Lo stesso D. Cesare reggeva e possedeva anche la “Ecclesia Santae Mariae de Succursu” posta “Extra moenia”, dove, similmente alla precedente, si trovava eretto un beneficio sotto lo stesso titolo.[xxxi]
Ritroviamo i due benefici nella “Platea di tutti i Benefici Semplici, tanto Eccl(esiasti)ci quanto di Juspatronato laicale fondati in questa Città, e Diocesi di S.a Sev.a” (1788), dove, elencati tra quelli di “Policastro”, risultano “Il Semplice Eccl(esiasti)co Beneficio sotto il tit.o di S.a M.a delle Grazie” ed “Il Semplice Eccl(esiasti)co Beneficio sotto il tit.o di S.a M.a del Soccorso”.[xxxii] Sulla base della platea del 1728, conservata presso l’archivio arcivescovile di Santa Severina, la documentazione successiva (1794), elenca le rendite ed i pesi relativi ai due benefici.[xxxiii]
Successivamente non troviamo altre notizie, segnale che entrambe le chiese andarono dirute a seguito del sisma del 1783,[xxxiv] mentre, sempre al tempo della Cassa Sacra, un atto del 2 agosto 1790 menziona i “Luoghi e Terreni d’affittarsi del vacante Benef.o di S. M.a del Soccorso”, ovvero solo “un ortale circondato di armacero attaccato all’istessa Chiesa”.[xxxv]
Note
[i] AASS, 16B.
[ii] Tale vicinanza è evidenzia anche dal Mannarino agli inizi del Seccento: “La seconda Parocchia alla parte più infine, ed’orientale, è l’abbadia di Santo Pietro, à cui van congionte l’altre due contigue della Sinagoga, e di Santa Maria delle Grazie, situate nella Chiesa di Santa Caterina non più la vecchia diruta, ma la nuova redificata dà fondamenti …” (Mannarino F. A., Cronica della Celebre ed Antica Petilia detta oggi Policastro, 1721-1723).
[iii] ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro Policastro, Busta 78 prot. 286, ff. 53-53v, 103-104, 130-130v, 139v-140, 205v-206v, 217-217v, 227-227v; Busta 78 prot. 287, ff. 118v-119, 119v-120, 160-161, 146v-147, 168-168v, 185-185v; Busta 78 prot. 288, ff. 016-017, 050v-051v, 071v-072, 073-074, 086v-087v; Busta 78 prot. 289, ff. 020-020v; Busta 78 prot. 291, ff. 006v-007; ff. 086-086v; Busta 79 prot. 294, ff. 055v-056v; Busta 79 prot. 296, ff. 166v-168; Busta 79 prot. 297, ff. s.n., 020v-021, 042-042v, 042v-043v, 046-046v, 090v-091, 156v-157, 160-161, 161-161v, 174-175, 175-175v; Busta 80 prot. 301, ff. 003-003v, 038-039v, 140v-142; Busta 80 prot. 302, ff. 034v-036; Busta 80 prot. 304, ff. 063-064, 066v-068; Busta 80 prot. 305, ff. 007-008; 008-009, 105v-106v; ASCZ, Notaio Ignoto Policastro, Busta 81 ff. 9-10. ASCZ, Notaio G. M. Guidacciro, Busta 182 prot. 801, ff. 017-018v, 036-036v, 074-075v, 078-079v, 115-117, 121v-123; Busta 182 prot. 802, ff. 032v-034v, 072v-073v, 102-104; Busta 182 prot. 803, ff. 079v-080v; Busta 182 prot. 804, ff. 016v-018v, 155v-158; ASCZ, Notaio F. Cerantonio, Busta 196 prot. 874, ff. 058-059; Busta 196 prot. 875, ff. 080v-082; Busta 196 prot. 876, ff. 007v-009; Busta 196 prot. 878, ff. 084v-085.
[iv] 19.05.1605. Tra i beni della dote di Polita de Simmari che andava sposa a Prospero Grigoraci della terra di Stilo, ma al presente abitante in Policastro, si menziona una casa palaziata posta dentro la terra di Policastro “Confine la chiesa di santa maria della gr(azi)a” la casa di Gio: Baptista Natale e la via pubblica da due lati. ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 286, ff. 103-104. 15.01.1617. Davanti al notaro si costituivano Polita de Simmari, vedova del quondam Prospero Grigoraci, assieme a Berardo Vecchio, per la stipula dei capitoli relativi al loro matrimonio. Apparteneva alla dote una casa palaziata posta dentro la terra di Policastro, nel convicino della chiesa di “santa maria della gr(ati)a”, confine la casa di Gio: Battista Natale, la via pubblica da due parti ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 291, ff. 006v-007). 16.11.1642. Alla dote di Beatrice Juliano “Virginis in capillo”, figlia di Paulino Juliano, che andava sposa a Jo: Dominico Cavallo, apparteneva la casa palaziata posta dentro la terra di Policastro, nel convicino di “Santa Maria la gratia”, confine le case di Cola Prospero, la casa di Ippolita de Sinbari ed altri fini (ASCZ, Notaio G. M. Guidacciro, Busta 182 prot. 801, ff. 115-117). 16.01.1643. Tra i beni che erano appartenuti al quondam Jo: Baptista Natale, troviamo una casa che attualmente possedeva Gio: Domenico Natale e nella quale abitava Paulino Juliano, posta nel convicino di “Santo Pietro”, confine Polita de Simbari, Cola Prospero e Gio: Gregorio Cerasario, via mediante (ASCZ, Notaio G. M. Guidacciro, Busta 182 prot. 802, ff. 011v-021v). 14.11.1655. Davanti al notaro comparivano Andrea Juliano e la vedova Vittoria de Pace, per la stipula dei capitoli relativi al loro matrimonio. Paulino Juliano, padre del futuro sposo, gli donava la casa posta nella terra di Policastro nel convicino della chiesa parrocchiale di “S.to Pietro”, confine la casa degli eredi di Fabritio Piccolo, la casa degli eredi di Ippolita de Simbari, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio F. Cerantonio, Busta 196 prot. 880, ff. 191-193v).
[v] 13.09.1605. Hijeronimo de Maijda e sua figlia Dianora de Maijda, vendono con il patto di retrovendita a Joannes Ber.no Petralia, una “domum terranam” posta dentro la terra di Policastro “in convicino ecclesie s.te Mariae gratiae iusta Casalenum mediante ditte ecclesie viam publicam duobus lateribus” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 286, ff. 130-130v). 06.10.1605. Joannes Ber.no Petralia, avendo acquistato con il patto di retrovendita da Hijeronimo de Maijda “alias lo mantuto” e da sua figlia Dianora de Maijda, una “domum terranam” posta dentro la terra di Policastro, “in Convicino ecclesie sante Marie gratie”, confinante da due lati con la via pubblica ed altri fini, per il prezzo di ducati quindici, riceve la restituzione di detta somma e restituisce la casa ai de Maijda (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 286, ff. 139v-140). 24.06.1613. Davanti al notaro ed al cospetto del parroco, compaiono Hijeronimo de Maijda “alias lo mantuto” e Joannes Andrea delo Moijo, per la stipula dei capitoli relativi al matrimonio tra il detto Joannes Andrea e Dianora de Maijda, figlia del detto Hijeronimo. Della dote faceva parte una “casa terranea con Camera Contigua”, posta dentro la terra di Policastro nel convicino della chiesa di “santa Maria della gr(ati)a”, confine il casalino novo che al presente fabbricava il detto Gerolimo, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 288, ff. 086v-087v). 23.01.1622. Negli anni passati, in contemplazione del loro matrimonio, Hijeronimo de Maijda “alias lo mantuto”, aveva promesso ai coniugi Andria Lomoijo e Dianora di Maijda, figlia del detto Gerolimo, 12 onze in monete d’argento. Al presente, il detto Gerolimo assegnava ai detti coniugi, tra l’altro: la casa con camera terranea posta dentro la terra di Policastro nel convicino di “Santo Pietro”, confine “lo casalino novo” di detto Gerolimo “et le mura di Santa maria la gratia”, la via pubblica da due parti ed altri fini. Il detto Andrea concedeva al detto Gerolimo ed a Paulo de Maijda suo figlio, di fabbricare sopra il muro e la camera predetti, alzandoli a loro piacere cosi da fare “fundere le fusa di detto casalino novo”, “purchè non venghi corsune seu Canaletta allo muro di detta Casa, et Camera” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 294, ff. 007v-008v).
[vi] 08.10.1623. Davanti al notaro comparivano Caterina Popaianni, vedova del quondam Vespesiano Pantisano, assieme a Joannes Fran.co Callea, per la stipula dei capitoli relativi al loro matrimonio. Appartenevano alla dote una casa palaziata con casalino contiguo, posta dentro la terra di Policastro nella parrocchia di “santo Petro”, confine i casalini del quondam Ferrante Cerasaro, la via pubblica ed altri fini, assieme alla metà del “trapito” che essa deteneva in comune con suo fratello Vespesiano Popaianni, posto dentro la terra di Policastro confine Blasio Rizza ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 294, ff. 110-111). 26.05.1634 Davanti al notaro comparivano Caterina Popaijanni, vedova del quondam Fran.co Callea, assieme a Nardo Arenda, figlio di Joannes Simone Arenda, per la stipula dei capitoli relativi al matrimonio tra detto Leonardo e Joannella Callea, figlia di detta Caterina. Appartenevano alla dote la meta della “Casa, et trappito” posta dentro la terra di Policastro nel convicino di “santo petro”, confine la casa di Blasio Rizza, Gerolimo Amannito ed altri fini, mentre l’altra metà di detto “trappito” restava per i figli del quondam Vespesiano Popaijanni (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 301, ff. 078v-080v). 02.01.1637. Davanti al notaro comparivano il Cl.co Leonardo Arenda, marito di Joannella Callea, assieme a Caterina Popaijanni. Negli anni passati, detta Caterina, madre di detta Joannella, aveva promesso in dote ai detti coniugi diversi beni. All’attualità, adempiando alla sua promessa, consegnava loro, tra l’altro, la metà di una casa terranea “con trappito”, di cui l’altra metà rimaneva ai figli ed eredi del quondam Vespesiano Popaijanni, posta dentro la terra di Policastro nel convicino di “santo Petro”, confine la casa di Blasio Rizza, le “[rip]e ditte delle Catarrate” e la via convicinale (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 304, ff. 001-002). 06.03.1646. Su richiesta di Blasio Ritia, il notaro si porta nella sua casa posta dentro la terra di Policastro, nel convicino della chiesa parrocchiale di “S.ti Petri”, “iusta Ecc.am S.tae Mariae de gratiae”, vinella mediante, la via pubblica ed altri fini, per stipulare il suo testamento. ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 307, ff. 084v-087. 25.11.1647. Davanti al notaro comparivano Gio: Dom.co Lomoio, con il consenso di suo padre Andrea Lomoio, assieme a Paulo e Laura de Maijda, padre e figlia, anche per parte di Gio: Dom.co Scandale, marito di detta Laura. I detti Paulo e Laura asserivano che, negli anni passati, Santo Lomoio, fratello di detto Gio: Dom.co e figlio di detto Andrea, aveva donato a detta Laura la metà di una casa posta dentro la terra di Policastro, nella parrocchia di “S.to Pietro”, confine la casa di Blasio Rizza, “muro coniuncto”, la casa di Antonio Caputo, via pubblica mediante, la casa di S.ta Maria “la gratia”, “dalla parte di sop.a”, vinella mediante, la via pubblica, “dalla parte di sop.a” ed altri fini, assieme ad altri beni. Tali beni spettavano a Santo Faraco, come figlio ed erede della quondam Dianora de Maijda, mentre il detto Andrea Lomoio ne aveva l’usufrutto vita natural durante. La situazione aveva generato lite tra le parti che, all’attualità erano giunte ad un accordo. La detta Laura ed il detto Paulo, cedevano in feneficio di detto Gio: Dom.co la detta donazione dei detti beni, mentre il detto Gio: Dom.co s’impegnava a pagare ducati 13 e ½ al detto Paulo (ASCZ, Notaio F. Cerantonio, Busta 196 prot. 874, ff. 103-106v). 06.09.1655. Testamento di Agostina Jerardo, moglie di Blasio Ritia, rogato nella sua domus posta dentro la terra di Policastro, nel convicino della chiesa parrocchiale di “S.ti Petri” (ASCZ, Notaio F. Cerantonio, Busta 196 prot. 880, ff. 131v-132v).
[vii] 15.09.1630. Antonino Gatto vendeva a Francisco Marchise la “Cameram palatiatam” muro congiunto con un’altra domus “magna” di detto Antonino, posta dentro la terra di Policastro nel convicino di S.ta Maria “gratiarum”, confine i “Casalenos” appartenuti al quondam Joannes Dom.co Sacco “et valonnem magnum dittum la iudeca” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 297, ff. 160-161).
[viii] 09 agosto 1644. Catharina, Julia e Feliciana Caruso, vendevano a Simione Lomoio il “Casalenum” che gli era pervenuto dall’eredità di Hijeronimo Ammannito loro padre, posto nella terra di Policastro “in Convicinio Sanctae Mariae Gratiarum Ecclesiae ad p(raese)ns Parochialis in loco Sancti Petri deruti in loco ubi dicitur la timpa delli Napoli”, confine la domus di Marco Maltise “muro coniuncto”, la domus di detto Simionis via mediante ed altri fini (ASCZ, Notaio G. M. Guidacciro, Busta 182 prot. 803, ff. 079v-080v).
[ix] 10.01.1618. Joannes Laurentio Cervino, essendo debitore nei confronti della chiesa di “sante Marie gratie”, per un annuo censo di carlini 15 infisso sopra la sua vigna di “gorrufi” “ditta la fossa”, lasciato dal quondam D. Gio: Battista Cansoneri per la celebrazione di una ebdommada, mentre erano decorsi circa nove anni senza che fossero effettuati i relativi pagamenti che assommavano a ducati 13 e ½, e non avendo modo di pagare, cedeva alla detta chiesa, nelle mani del suo procuratore D. Ottavio Vitetta, “uno palazzetto” posto dentro la terra di Policastro, confine la casa di Gio: Petro Legname e le altre case di detto Gio: Laurenzo, la via pubblica ed altri fini, che si intendeva “l’airo di sopra et sotto con la scala fabricatizza”, con il patto di poterlo riscattare alla scadenza d’agosto e non in altro tempo (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 291, ff. 077v-078v).
18.10.1621. Joannes Laurentio Cervino vendeva al presbitero D. Joannes Baptista Favari, la casa palaziata consistente in due membri e un casalino dalla parte di sotto, confine le case di Gio: Thomaso Lamanno, il casalino di detto Gio: Thomaso, la casa di Gio: Petro Spinello, la via convicinale ed altri fini, esclusa la “Camera nova” che detto Joannes Laurentio aveva fabbricato dalla parte di sopra e che aveva venduto alla chiesa della Madonna della Gratia (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 293, ff. 073-074v).
13.11.1622. Oratio, il Cl.o Marcello e Jacobo Cervino, asserivano che, negli anni passati, il quondam Joannes Fran.cus Cervino, loro padre, aveva acquistato ad annuo censo da Joannes Dom.co Sacco, la “Continentiam Casalenorum cun orto” posta dentro la terra di Policastro nel convicino di S.ta Maria “la gratia”, confina la domus di detta chiesa, la via pubblica ed altri fini. Avendo rinunciato all’eredità paterna, i detti de Cervino dichiaravano di non volere pagare il detto censo. Il detto Joanne Dom.co, rientrato così in possesso del bene, lo vendeva ad annuo censo ad Antonino Gatto. (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 294, ff. 055v-056v).
04.05.1629. Thoma Lamanno “alias ucciuccarello”, vendeva al C. Ottavio Vitetta, procuratore della chiesa di S.ta Maria “gratiarum”, 2 “Casalenos” “sine signo muri”, posti dentro la terra di Policastro nel convicino della detta chiesa, confine un’altra domus della detta chiesa, i “casalenos” del quondam Joannes Dom.co Sacco che al presente possedeva Antonino Gatto, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 297, ff. 020v-021).
25.11.1647. Attraverso una donazione fatta negli anni passati, Laura de Maijda possedeva la metà di una casa posta dentro la terra di Policastro nella parrocchia di “S.to Pietro”, confine la casa di Blasio Rizza “muro coniuncto”, la casa di Antonio Caputo, via pubblica mediante, la casa di S.ta Maria “la gratia” “dalla parte di sop.a,” vinella mediante, la via pubblica “dalla parte di sop.a” ed altri fini (ASCZ, Notaio F. Cerantonio, Busta 196 prot. 874, ff. 103-106v).
01.12.1653. Gio: Andrea Sacco, al presente “habitante” nella terra di Mesuraca, vendeva a Gianne Jerardo, padre di Lucretia di Policastro nipote del detto Gio : Andrea, “due Casalena dirute cum uno horticello” posti dentro la terra di Policastro, nel convicno della chiesa di S.ta Maria “la gratia”, confine le case di detta chiesa, le case di Fran.co Papaianni, “la via che si và alla Porta della Giudeca” ed altri fini, mentre l’orto confinava con la casa di Andrea Rocciolillo, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio F. Cerantonio, Busta 196 prot. 878, ff. 084v-085).
[x] 20.12.1625. Per consentirgli di prendere gli ordini sacri, D. Joannes Baptista Favari donava al C. Joannes Baptista Pollaci, un “vignale arborato di celsi” o “ortale di celsi”, loco detto “lo ringo”, con il patto che, dopo la morte del Favari, il detto Pollaci avrebbe dovuto far celebrare una messa la settimana nella chiesa di S.ta Maria “la gratia”. Rimaneva pattuito che, dopo la morte del Pollaci, l’ortale sarebbe rimasto alla detta chiesa in ragione dei ducati 50 che gli erano stati prestati dal C. Ottavio Vitetta, procuratore di detta chiesa (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 295, ff. 186-186v).
12.10.1634. Gio: Berardino e Gio: Fran.co Accetta, pagavano annui ducati 5 per il servimento di 1 “edonmada” la settimana nella “Clesia” di “Santa Maria la gratia”, che era assegnato dal Cl.o Ottavio Vitetta, procuratore di detta chiesa (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 301, ff. 151-152).
[xi] ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 287, ff. 185-185v; prot. 289 ff. 020-020v; Busta 182 prot. 803, ff. 079v-080v.
[xii] ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 297, ff. 042v-043v.
[xiii] ASCZ, Notaio G.M. Guidacciro, Busta 182 prot. 803, ff. 117-118v.
[xiv] ASCZ, Notaio G.M. Guidacciro, Busta 182 prot. 806, ff. 051-052.
[xv] ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 290, ff. 020-021.
[xvi] Rende P., Il monastero dei Francescani Riformati di Santa Maria delle Manche di Policastro, in www.archiviostoricocrotone.it
[xvii] Nell’atto si menziona Scipione Curto, procuratore della chiesa del SS.mo Salvatore di Policastro (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 291, ff. 037v-039).
[xviii] ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 297, ff. 101-102v.
[xix] AASS, 37 A.
[xx] 15.11.1647. Negli anni passati, Gio: Thomaso Scandale aveva comprato da Vittoria Rizza, un vignale posto nel loco detto “lo soccurso” (ASCZ, Notaio F. Cerantonio, Busta 196 prot. 874, ff. 092-094). 25.09.1654. Gio: Tomas Scandale vendeva al D.r Lutio Venturi, l’annuo censo di carlini 25 per un capitale di ducati 25 sopra alcuni suoi beni, tra cui un vignale loco detto “lo soccurso”. (ASCZ, Notaio F. Cerantonio, Busta 196 prot. 879, ff. 124-126).
[xxi] 20.01.1623. Julia Campana, vedova ed erede del quondam Fabio Caccuri, rinunciava in favore di Gio: Dom.co, Gio: Vittorio e Gio: Fran.co Caccurio, alcuni beni appartenuti al quondam Horatio Caccuri, tra cui la “vignula” posta dentro il territorio di Policastro, loco “sopra santa maria dello soccorso seu chiusella”, confine la vigna di Alfonso Caccurio, “la via publica che si va alla montagna et la via del venerabile monasterio di santa maria le manche”, ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 294, ff. 067v-069). 24.07.1623. Joannes Dom.co Caccurio lasciava una ebdomada in perpetuo nell’altare maggiore della chiesa di “Santa maria della olivella”, nominando cappellano D. Gegnacovo de Aquila, fintanto che il chierico Ferrante de Vito non si fosse fatto prete. Per soddisfare tale ebdomada, assegnava la possessione della “la vignola”, confine i beni di Alfonso Caccuri, “et due vie publiche” ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 294, ff. 099-099v). 11.01.1624. Davanti al notaro comparivano Joannes Baptista Lanzo e Battista Mazzuca, per la stipula dei capitoli relativi al matrimonio tra detto Battista e Lucretia Lanzo, figlia di detto Joannes Baptista. Apparteneva alla dote un pezzo di terra loco detto “la fico di luca” “seu chiusella”, territorio di Policastro, confine i beni del quondam Minico Cavarretta, i beni degli eredi del quondam Vespesiano Zupo, “la via che si va alla montagna et la via che si va in santa maria la spina”, ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 295, ff. 005-005v). 18.05.1654. A seguito di un accordo, la vedova Vittoria Richetta, erede del quondam Gio: Dom.co Caccurio, cedeva al R. D. Oratio ed a Carlo Caccuri, la possessione arborata con diversi alberi fruttiferi, posta nel territorio di Policastro dove si dice “sop.a lo soccorso detto la Vignula”, confine i beni che erano stati del quondam Alfonso Caccuri che possedevano Dieco Venturino ed altri, e “le vie publiche l’una, che si và alle Manche, e l’altra alla montagna” (ASCZ, Notaio F. Cerantonio, Busta 196 prot. 879, ff. 052-054v).
[xxii] 19.08.1632. Trovandosi indebitato, Vitaliano Larosa, abitante in Policastro, ipotecava le sue terre già gravate di “Camino”, nei confronti di Alfonso Campitello (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 299, ff. 059v-064). 19.08.1632. Con il denaro ricevuto da Alfonso Campitello, Vitaliano Larosa provvedeva ad affrancare l’annuo censo di ducati 5 per un capitale di ducati 50 sopra la sua gabella posta nel territorio di Policastro loco “Camino”, che pagava alla chiesa di S.ta Maria “dello soccurso” in relazione alla celebrazione di 1 ebdommada (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 299, ff. 065v-066v). 20.08.1636. Stefano Capotia asseriva che, negli anni passati, al tempo in cui era e come anche al presente si trovava ad essere, procuratore della venerabile chiesa di Santa Maria “dello soccorso” di Policastro, aveva dato a censo ducati 50 a Vitaliano Larosa al 10 %, sopra le terre di quest’ultimo dette “di Camino”. Successivamente il detto Vitaliano aveva affrancato il censo con una parte del denaro ricevuto da Alfonso Campitello. Non essendosi trovati altri che volessero prendere il detto censo, lo aveva preso lo stesso Stefano, in maniera da provvedere a pagare i cappellani che celebravano le messe. Tale censo era stato infisso sopra le terre di “Santo Cesario”, che detto Stefano deteneva in comune ed indiviso con il dottor Mutio Giordano (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 303, ff. 102v-103v).
[xxiii] 01.06.1629. Nel proprio testamento, il C. Gio: Thomaso Campana lasciava alla “madonna del soccurso” ducati 5 “p(er) riparare detta chiesa” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 297, ff. 036-037v).
[xxiv] 15.05.1642. Anibal Bello donava alla “Venerabilis Ecclesiae Sanctae Mariae nuncupatae dello soccurso” di Policastro e, per essa, al suo procuratore Stefano Capotia, la “vineam” posta “in districtu” di Policastro, loco detto “le chianetta”, nonché la “Domum constructam foris dictam Civitatem in Loco ubi dicitur Lo Salvatore, et proprie secus dictam Ecclesiam”. Si pattuiva che il detto Anibal avrebbe abitato vita natural durante nella casa donata, ricevendo il vitto dal detto procuratore ed impegnadosi in servizi per la detta chiesa (ASCZ, Notaio G. M. Guidacciro, Busta 182 prot. 801, ff. 094v-096).
[xxv] AASS, 37 A.
[xxvi] AASS, 37 A.
[xxvii] AASS, 4D, fasc 3.
[xxviii] AASS, 4D, fasc 3.
[xxix] AASS, 4D fasc. 3.
[xxx] “Ecclesia Sanctae Mariae Gratiarum cum unico pariter Altari regitur per R(everen)dum D. Caesarem Rocca, qui possidet. Beneficium sub eodem titulo in ea erectum, et missas ei adnexas celebrat.” ASV, Rel. Lim. Santa Severina, 1765.
[xxxi] “Ecclesia Santae Mariae de Succursu regitur per praed.m D. Caesarem Rocca, qui possidet. Beneficium sub eodem titulo in ea erectum, et de necessariis providet.” ASV, Rel. Lim. Santa Severina, 1765.
[xxxii] AASS, 72A.
[xxxiii] “Il Semplice Eccl(esiasti)co Beneficio di S.a M.a delle Grazie possiede un capitale di d. 150 sopra la Gabella di Cucoli confine li Campanari, e Foresta, e sopra Catrivari. Item un altro capitale di d. 50 sopra il q.m D. Vito Giordano. Quale Beneficio fu fondato nell’anno 1667 e d.e Rendite si trovano annotate nella Platea dell’anno 1728. Sistente nella Scansia di Policastro situata in q.o Archivio.” “Il Semplice Eccl(esiasti)co Beneficio di S.a Maria del Soccorso fondato nell’anno stesso 1667 tiene solam.te d.a Rendita. Un Ortalizio attaccato a d.a Chiesa Campestre alborato di Celsi, et altri albori fruttiferi, che s’affitta per quanto si può affittare. Tiene il peso di 4 messe l’anno nelli giorni delli Titulari di S. Biaggio e S.a Appollonia. Come pure il peso della Visita, e Cattedratico. (AASS, 72A).
[xxxiv] Per quanto riguarda Santa Maria del Soccorso ne rimane testimonianza esplicita attraverso un atto del 5 febbraio 1791. “Rimase l’affitto dell’Orticello della Chiesa del Soccorso di Policastro inclusa la Chiesetta diruta …” (ASCZ, Cassa Sacra, Atti Vari, Policastro 272/16).
[xxxv] ASCZ, Cassa Sacra, Atti Vari 308/3.
The post Le chiese di Santa Maria delle Grazie e di Santa Maria del Soccorso di Policastro appeared first on Archivio Storico Crotone.
Alcuni aspetti della Terra di Scala al tempo del Viceregno

Scala Coeli (CS).
“Il colle murato …, cinto da rupi e grotte che offrì per secoli sicuro rifugio agli scampati dalle invasioni turche e saracene. Si entrava nel paese attraverso quattro porte che si aprivano all’alba e si chiudevano al tramonto. Portavavuza, Portafischia, Portapiano e Portello o Portello della Timparella” (Padula Vincenzo).
La Terra di Scala e le fortificazioni di Crotone
La costruzione delle nuove fortificazioni di Crotone, specie nei primi anni, fu occasione di lavoro e di salario per numerosi Scalesi, che prestarono la loro opera come manipoli. Dalla fine del 1541 per tutto il 1543, numerosi di loro lavorarono alla fabbrica delle mura e castello di Crotone. I più assidui furono Cesaro Caligiuri, Sancto Verticello, Antoni Romutato, Nardo Mendicino, Cicco Cantermo, Francesco Cosentino, Joanne Greco, Paulo Greco, Frabbitio Greco, Cola di Napoli, Taliano Ficulo, Petro Puglisi, Cola Puglisi, Carlo Rizuto, Pompeo Zamponi e Joanne Campolongo.[i]
Il rapporto della “Terra di Schala” con la fortificazione della città di Crotone continuerà anche negli anni successivi. Nel “Partimento dela portatura de canne doi milia et docento de Petra che bisognano per compimento dela fabrica del belguardo del castello et della cortina dela Città de Cutrone, fatto il 21 giugno 1578”, troviamo che tra le “Terre propinque a Cutrone taxate ad ragione de canne dieci per ogni cento fuochi” vi è la Terra di Scala, che contando 215 fuochi deve contribuire con canne 21 di pietra.[ii]

Sigillo dell’università di Scala.
Abitanti della Terra di Scala nella seconda metà del Cinquecento
Negli atti del notaio Baldo Consulo di Cirò troviamo alcuni abitanti della Terra di Scala, che avevano relazioni economiche con la terra di Cirò: Donna Ysabella Scarnata,[iii] Joannes de Falcone,[iv] Orzino Grimaldi,[v] Joannes Dom.co Rumei,[vi] Felicis Ant.o Petra Paula,[vii] Jacobo de Felice,[viii] il notaio Jo: Ber(nardi)no de Ber(nar)do,[ix] Donato Gratiano,[x] Fabio Barbuscia e Gaudiano de Avella.
Fuochi
La popolazone di Scala aumentò progressivamente per tutto il Cinquecento fino alla metà del Seicento, per poi declinare. Nel 1521 è tassata per 145 fuochi, nel 1532 per 175 fuochi, nel 1545 per 212, nel 1561 per 215, nel 1595 per 258, nel 1648 per 293, nel 1669 per 112, nel 1732 per 180.[xi]
Feudatari
Giovanbattista Spinelli, barone di Fuscaldo, conte di Cariati (1505-1522), figlio di Troiano, signore di Summonte, sposò Livia Caracciolo, nel 1505 ebbe dal re Ferdinando il Cattolico il contado di Cariati. Ferrante Spinelli, duca di Castrovillari, conte di Cariati (1523-1547), figlio di Giovanbattista, sposò in prime nozze Diana, figlia di Belisario Acquaviva d’Aragona. Giovanbattista Spinelli, duca di Castrovillari, conte di Cariati (1548-1551), figlio di Ferrante, sposò Isabella di Toledo, figlia del vicerè Pietro di Toledo e di Maria Osorio Pimentel, marchesa di Villafranca. Francesca Spinelli, duchessa di Castrovillari, contessa di Cariati (1553-1564), figlia di Giovanbattista, sposò Scipione Spinelli, figlio di Carlo, duca di Seminara. Carlo Spinelli, duca di Seminara, principe di Cariati (1565-1568), sposò Ippolita di Giovan Francesco di Capua, conte di Palena. Scipione Spinelli, principe di Cariati (1570-1603), sposò Francesca Spinelli. Carlo Spinelli, figlio ed erede di Scipione, principe di Cariati (1604-1614), sposò Giovanna di Capua. Scipione Spinelli, figlio ed erede di Carlo, principe di Cariati (1615-1659), sposò Carlotta di Paolo Savelli, vedova di Pietro Aldobrandini. Carlo Filippo Antonio Spinelli Savelli, figlio ed erede di Scipione, principe di Cariati (1662) vendette Scala a Maurizio Coscinelli per ducati 27.000 con regio assenso del 30 giugno 1678. Maurizio Coscinelli morì il 22 gennaio 1694 nella città di Cosenza dove abitava e dove fu seppellito “nella chiesa matrice di detta Città di Cosenza”, seguì nel 1694 Giuseppe Coscinelli e poi nel 1698 Donica Coscinelli. Donica Castriotto Coscinelli, signora della Scala, sposò Luigi Vitilio, marchese di Auletta, la figlia Emanuela Erberta Vitilio dei marchesi dell’Auletta sposò Niccolò Parisani – Buonanni, marchese di Caggiano.[xii]

L’abitato di Scala ed i luoghi vicini. Particolare della tavola N.° 27 (1788) della carta di G. A. Rizzi Zannoni.
La chiesa arcipretale di Santa Maria
Già all’inizio del Trecento è documentata nella “Terra Scalae”, diocesi di Rossano, la presenza di un folto gruppo di religiosi. Nelle cedole per la Santa Sede del 1325 compaiono i “dompni” Falconus de Campana, Falconus, Ioah.es Funarius, Nicolaus Schettinus, Petrus Fusillus, Ioh.es de Marco e Adam S.ti Maurelli.
La successiva cedola del 1326 annota che nella Terra di Scala vi sono nove “clerici”.[xiii] Allora era signore della terra di Scala Giordano Ruffo.[xiv]
Nel 1437 su preghiera di Covella Ruffo, contessa di Montalto, la chiesa di S. Pietro di Cariati fu eretta in cattedrale ed unita a quella di Cerenzia dal papa Eugenio IV.[xv] Con la creazione della nuova cattedrale oltre alla città di Cariati anche le due terre di Scala e di Terra Vecchia ed il casale di Santo Maurello, che erano parte della diocesi di Rossano, passarono a far parte della nuova diocesi di Cariati.
Un regesto inviato il 23 marzo 1443 dal papa Eugenio IV al vescovo di Cariati (Bernardo Faiardo) concedeva l’ufficio di tabellionato a favore del presbitero Gaspare Calochuri de Scala.[xvi] Anche la chiesa dedicata alla Beata Maria della Terra di Scala con il suo titolo di arcipretale, assieme alla parrocchiale di San Basilio, ci compare alla metà del Quattrocento in diocesi di Cariati.[xvii]
Il vescovo di Cerenzia e Cariati Filippo Gesualdo (1602-1619) all’inizio del Seicento, descrivendo i luoghi religiosi di Scala, così si esprime: “La Terra della Scala, ha una sol chiesa curata col suo arciprete il quale con altri quattro, o cinque Sacerdoti, attende comunemente alla cura dell’anime, e non hanno altre entrade che le decime, et incerti de morti, quali godeno comunemente come comunemente attendono al servitio della chiesa. Vi sono altri Preti e clerici quali servono ancora la detta chiesa. Vi sono le compagnie del Santissimo Sacramento e della Madonna Santissima del Carmine, e due luochi de Religiosi in fabrica. L’uno delli padri di S. Francesco conventuale, et l’altro delli Padri Carmelitani, quali sono di esemplarità e frutto”.[xviii]
Il successore Maurizio Ricci (1619-1626) si sofferma sulla precaria situazione economica e religiosa: “La terra della Scala, che farà 1670 anime la cui cura s’esercita solo nella Matrice dalli Preti in comune, et saranno in tutto 15 preti in circa. L’entrade loro consiste in decime come s’è detto di sopra; et col servir tutto l’anno alle messe cantate li giorni festivi, vespri, processioni, et alla cura non potrà, havere un prete ducati quindeci l’anno. E’ per l’istessa tenuita non si fanno più Preti, et quel che e peggio la maggior parte sono ignoranti, et se per il passato se ne sono fatti, e perche almeno non erano maltrattati dalli detti commissarii del Nunzio come sono stati da quindici anni in qua. Remediare con l’unione di benefici non si puo fare perche in tutta la diocese non vi sono beneficii. Il remedio sarebbe l’accrescere la decima ut supra. In detta terra vi sono due monasteri di frati uno del Carmine la cui chiesa è buona, ma senza forma di convento. Vi stanno due Sacerdoti, et dei diaconi, l’altro di S. Francesco quale sta peggio assai, et con un sacerdote solo, et l’uno et l’altro sta fuori della terra il primo havera da 130 ducati d’entrada, et il 2.o n’havera da 40”.[xix]
Sappiamo che all’inizio del Seicento, nella chiesa arcipretale della Terra di Scala vi era un altare dedicato a San Francesco di Paola. Il semplice beneficio che vi era infisso e la rendita della chiesa o cappella dedicata a Santa Maria di Costantinopoli nell’agosto del 1609 furono concessi a Io. Victorio Caligiuri.[xx]
Gli stessi con le loro rendite alla morte del Caligiuri passeranno nel gennaio 1616 a Carlo Vecchierello.[xxi] Sempre in questi anni continua la sua presenza la confraternita del SS. Sacramento.[xxii] Scossa dal terremoto del giugno 1638, che distrusse sessantanove case ed altrettante rese inabitabili e causò ventiquattro morti, a metà del Seicento era arciprete di Scala Iosepho Vizza e alla sua morte avvenuta nel luglio 1655 seguì dal dicembre di quell’anno Petro Caligiuri.[xxiii]
La crisi economica aumenta le rivalità tra le famiglie, che sfociano spesso in ferimenti ed omicidi, alle quali partecipano attivamente anche il clero locale. Il 27 luglio 1658, dopo la celebrazione della messa domenicale, scoppia una rissa nella piazza pubblica ed il presbitero Michele Angelo Verticelli nell’intento di difendere il fratello commette un omicidio.[xxiv]
In questi anni permaneva ancora la vecchia consuetudine che prevedeva che la cura delle anime era dell’arciprete ma l’onere di amministrare i sacramenti spettava a tutti i sacerdoti della chiesa matrice, poiché tutti in uguale misura ricevevano le decime dei parrocchiani per immemorabile consuetudine.[xxv]
Nei primi decenni del Settecento la cura delle anime spetta come per il passato all’arciprete che però è aiutato da un coadiutore, volgarmente detto parroco. In questi anni il vescovo di Cariati, il cutrese Marcantonio Raimondi (23.12.1726 – 22.9.1732), eleva l’importanza della chiesa, facendola divenire simile ad una chiesa collegiata, introducendovi i titoli canonicali.[xxvi]
Allora la terra di Scala era sotto il dominio temporale del marchese di Auletta della famiglia Vitilio e contava 1200 abitanti. La cura delle anime era esercitata dall’arciprete e da un coadiutore curato, e i sacramentali erano conservati solo nella chiesa parrocchiale sotto il titolo dell’Assunzione della Beatissima Maria. Vi sono 20 sacerdoti, un diacono, un suddiacono e 13 chierici. Nella chiesa sono erette due confraternite, una sotto il titolo del SS.mo Sacramento e l’altra del SS.mo Rosario. Inoltre nella chiesa della Pietà vi è anche la confraternita della Passione Domini.[xxvii]
Tra i vari arcipreti, che ressero la chiesa nel Settecento, ricordiamo Tomaso Marcello, morto nel novembre 1752, al quale seguì nel gennaio seguente Francesco Ranieri e poi per privazione del Ranieri seguì nel 1756 Antonio Gervino.[xxviii]

Scala Coeli (CS), chiesa di Santa Maria Assunta.
Chiesa di Santo Basilio
La chiesa rurale di Santo Basilio della terra di Scala in diocesi di Rossano è già presente all’inizio del Quattrocento. Il papa Bonifacio IX, essendo la chiesa vacante assieme a quella dei SS. Quaranta del casale di Cortale, il 3 maggio 1402, incaricava di provvedervi all’arcivescovo di Santa Severina ed ai vescovi di Firenze e di Umbriatico.[xxix]
Segue un regesto del papa Eugenio IV diretto ad Andrea, abate florense di Sant’Angelo Militino, col quale gli concede la chiesa di Santo Basilio della terra di Scala in diocesi di Cariati, ed una foresta con terre e mulino in territorio di “Curipolati”, che in precedenza erano state date a Ciccho e rimaste vacanti dal 20 marzo 1443 per la promozione di quest’ultimo a vescovo di Umbriatico.[xxx]
Alla metà del Quattrocento la chiesa è citata come parrocchiale. Il papa Callisto III il 24 aprile 1456 confermava la chiesa a Bernardo de Lignamine, il quale l’aveva avuta concessa dal vescovo di Cariati.[xxxi]
La chiesa è segnalata per tutta la metà del Cinquecento. Concessa assieme ad altre rendite dal papa Giulio II ad Aloysio de Gibraleon. Nel marzo 1513 il papa Leone X la concedeva assieme ad altre rendite a Nicola Iuranna.[xxxii] Poi passò al suo cubiculario Thomas de Rubeis.[xxxiii] Infine pervenne a Petruccio Iuranna e quindi a Federico Iuranna.[xxxiv]

Scala Coeli (CS), scorcio del campanile della chiesa di Santa Maria Assunta.
La chiesa di Santa Maria della Pietà
La chiesa di Santa Maria della Pietà era sede della confraternita omonima. Essa è citata per la prima volta in un Breve di Alessandro VII del 3 febbraio 1656. All’inizio del Settecento vi era la confraternita della Passione del Signore.[xxxv]
Il vescovo di Cariati Carlo Ronchi
Il napoletano Carlo Ronchi, fu consacrato vescovo di Cariati nel dicembre del 1732, ma fu più volte richiamato dalla Santa Sede, perché spesso e volentieri si intratteneva a Napoli per molto tempo, adducendo il fatto di essere malato.
Dalle sue Relazioni ad Limina sappiamo che nel 1738 era a Roma, nel 1741 a Cariati, poi nel 1745 e nel 1750 a Napoli. Nel 1750, richiamato più volte dal Nunzio di Napoli, alla fine di quell’anno fu costretto a lasciare Napoli per la sua sede di Cariati. Dal 1751 al 1759 risulta presente a Cariati, poi andò ad abitare a Scala.
Egli, infatti, ritenendo Cariati pericolosa e anche nociva per la sua salute, trascorse l’ultimo periodo della sua vita a Scala. L’ultima sua relazione è infatti datata Scala sette marzo 1762.[xxxvi] A Scala morì il 9 gennaio 1764.[xxxvii]
Già nella sua relazione in data 9 gennaio 1759 il vescovo faceva presente, accogliendo le molte istanze e richieste di aiuto, di essere riuscito a riportare la pace tra gli abitanti di Scala, ponendo fine alle molteplici liti e agli aspri conflitti di interessi che da molti anni opponevano i cittadini ai vecchi amministratori dell’università e al marchese.[xxxviii] Ma la pace durò poco, che un’altra lite oppose il dottore Iosepho Tursi della terra di Scala, al marchese per il rendiconto di sei anni della amministrazione del feudo. Dopo aver perso molto tempo e pazienza, il vescovo finalmente riuscii a comporre la lite.[xxxix]

Scala Coeli (CS), scorcio del campanile della chiesa di Santa Maria Assunta.
I conventi dei Carmelitani e dei Francescani
Il convento dei minori conventuali fu soppresso nel 1653 per Bolla di Innocenzo X. Quello dei carmelitani fu fondato nel 1579 sotto il titolo della SS. Trinità. Abitato da pochi frati fu continuamente osteggiato dai vescovi di Cariati, che cercarono continuamente di sopprimerlo per incamerarne le entrate.[xl]
La Giudecca
La Giudecca era situata dentro le mura vicino ad una porta secondaria della città detta “Portello” o “Portello della Timparella”. Ancora oggi rimane il toponimo ad indicare questa area. Un atto notarile della seconda metà del Cinquecento del notaio Baldo Console di Cirò relativo all’atto di vendita di una casa palaziata di Scala ci fornisce il nome di alcuni abitanti della Giudecca. Il 14 marzo 1574 nella terra di Psycrò davanti al notaio Baldo Console si costituiscono il magnifico Fabio Barbuscia della terra delle Scale da una parte e Gaudiano de Avella della stessa terra delle Scale dall’altra. Il Barbuscia afferma di possedere una casa palaziata dentro la terra delle Scale “in loco dicto la Judeca” confinante con la casa del De Avella e vie pubbliche da entrambi i lati. La cede al Barbuscia per ducati 48.[xli]

Scala Coeli (CS), ingresso di una abitazione del centro storico.
Notizie tratte dal “Libro dove s’annotano l’entrade di q(ue)sta Bar(onal) Corte di Scala feudali, e burgensatici” dal 1692 al 1695 dell’erario Benedetto Nocera.[xlii]
Il 15 aprile 1695 Horatio Tauro, protonotario e avvocato fiscale nella Provincia di Calabria Citra, era incaricato dal Supremo Tribunale della Regia Camera, di recarsi nella Terra di Scala e per servizio del Regio Fisco, prendere informazione della liquidazione del Relevio della Terra della Scala per morte del Dottore Maurizio Coscinelli, barone di quella Terra.
Entrate feudali
L’erbaggio della Difesa di Piscitriale, difesa di Peditorto, difesa di Sciagurata, difesa di San Martino, Mastrodattia delle prime cause civili e criminali, Bagliva e Palaggi, Doana e pagliare civili, Molino del Pantano. Censi ordinarii, musto sopra le vigne del qm Giacomo Griscionari, fida degli animali forastieri, Palazzo del castello, molino del Ruvello.
Le tre difese di Peditorto, Sciagurato e Santo Martino (beni feudali)
Sulle difese del barone si alternava il pascolo alla semina. L’erario baronale concedeva per due anni su ogni difesa il pascolo ai custodi di armenti dei casali silani e successivamente spettava all’univesità di Scala di affittarla per due anni a semina agli abitanti del luogo. Custodi di armenti e massari, pascolo e semina, si avvicendavano sulla stessa difesa.
“I terreni di Pedicorto, Sciagurato e S. Martino che tiene l’università di detta Terra detta Baronal Corte li tiene et have il ius di vendirsene per dui anni continui uno così susseguentemente dui l’altro et dui l’altro”. Nel mentre una difesa era al primo anno di affitto a pascolo, un’altra era al secondo, mentre la terza era al primo a semina. La Corte baronale possedeva l’erbaggio delle Difese di Peditorto, di Sciagurato e di Santo Martino con l’alternativa con questa Università, “cioè il Barone s’usufrutta la Difesa di Perditorto per due anni continui e poi sobentra questa Università al frutto della medesima et il Barone passa al Pascolo della Difesa di Sciagurato parimente per due annate e poi sobentra la detta Università et il Barone passa al pascolo di Santo Martino per le due annate spettanti alla Baronal Corte e così successivamente … cioè due anni per ogni Difesa si pascola dalla Baronal Corte e due anni immediate dall’Università. Le due annate che spettarno a questa Baronal Corte furono nell’anno 1693 et 1694, e che poi da settembre di detto anno 1694 passò al pascolo di S. Martino.”

Scala Coeli (CS), il paesaggio circostante l’abitato.
Difesa Peditorto (bene feudale)
L’otto settembre 1692 Angelo Caligiuri di Scala si obbliga con l’erario Benedetto Nocera di prendere in fitto per ducati 25 l’erbaggio di Peditorto per un anno e di pagare nella fiera della Ronza prossima futura 1693. Nel settembre dell’anno dopo la difesa è presa in fitto sempre per un anno, dal settembre 1693 per tutto agosto 1694, per lo stesso prezzo da Felice di Perri del casale di Firmo. Il Perri non pagherà in quanto i ducati gli furono “bonificati con li polledri della Corte che vi pascolarno”.
La difesa di San Martino (bene feudale)
Nel 1694/1695 la difesa di San Martino, dopo essere stata venduta a semina per i due anni precedenti dall’università, è venduta in erbaggio dall’erario baronale a Felice di Perri per ducati 50, pagati in fiera della Ronza.
La difesa di Piscitriale (bene feudale)
“Nella Difesa di Piscitriale che si possiede dalla Corte Baronale l’Università ogni tre anni si fa massaria da tutti li massari di questa Terra dividendosi le terre fra di loro secondo la possibilità di ciascuno cittadino che hanno bovi. Si contribuisce alla baronal Corte di questa Terra la somma di Tumula trecento cinquanta di grano che valutato a carlini sette il tumulo fanno ducati 245”.
Quando invece la difesa era affittata a pascolo vi potevano pascolare duecento bovini. Nel settembre 1692 i custodi di armenti Anselmo Curcio e Nicola Ferro si obbligano con l’erario Benedetto Nocera di pagare ducati 250 per l’erbaggio di Piscitriale “per tutto questo anno fino a tutto giugno 1693”. Essi promettono pagare i duc. 250 nella fiera prima della Ronza. Nell’annata seguente (1693/1694) essi pagano la metà (ducati 125) in quanto “in quest’anno s’è dato a massari con l’arato”.
Il 27 settembre 1695 Nicola Ferro del Casale di Casole, massaro di vacche di anni 45 circa e Francesco Maria Curcio del casale di Scalzati massaro di vacche di anni 48, dichiaravano all’agente del fisco di avere affittato dalla Corte Baronale la difesa di Piscitriale da quattro anni a questa parte in erbaggio per ducati 250 l’anno “ma quando c’è stato l’arato ne ho pagato solo ducati 125 atteso non posso pascolare in detta difesa più di quattro mesi e poi sono ferrato di andare fuora detto territorio in altre difese, mentre nella suddetta Piscitriale si fa massaria e si semina e nel seguente anno poi si raccoglie il grano et la baronal corte ne percipe poi il frutto. La difesa era stata affittata per due anni dal mese di settembre 1691 a tutto agosto 1693 per ducati 250 e poi da settembre 1693 in avanti l’ebbe in affitto per duc. 125 atteso in detta difesa vi era l’arato e vi si fè massaria e vi pascolai pochi mesi con il mio compagno”

Scala Coeli (CS), il paesaggio della vallata del Fiumenicà.
Fida (bene feudale)
La fida era una tassa che pagavano alla Camera baronale i custodi degli armenti dei casali silani per il pascolo di animali forestieri nel territorio della terra di Scala. Il pagamento della fida avveniva “in fiera di Ronza”. I custodi degli armenti provenivano quasi sempre dai casali di Cosenza (Casole, Macchia, Celico, Trenta, Scalzati, Firmo, ecc.). Essi oltre ai loro prendevano in custodia anche altri armenti di benestanti. Nell’annata 1693/1694 Giuseppe Macchia del Casale della Macchia si obbliga a pagare in fiera della Ronza ducati due per la fida delle sue vacche, che tiene in custodia in questo territorio di Scala “alli Comuni”. Per lo stesso motivo anche Ferrante Falcone di Celico il 25 aprile 1694 si obbliga e paga per le sue vacche in fiera della Ronza un ducato ed un tari. Segue Bartolo Caruso delli Trenta che il 7 maggio 1694 si obbliga per il pascolo delle “giomente che tiene in custodia del S.r Flaminio Valente”. Egli paga in fiera della Ronza un ducato, un tari e 15 grana. Anche Matteo Salatino delli Scalzati per la fida di dieci porci paga in fiera di Ronza due tari.
Mastrodattia delle prime cause civili e criminali (bene feudale)
Era data in fitto per la durata annuale per il prezzo di ducati 20, da pagarsi in tre rate, ad iniziare dal 7 settembre. Prendevano in fitto la mastrodattia benestanti del luogo che si associavano tra loro. Nell’annata 1692/1693 fu affittata a Carlo Vivacqua e compagni “per li X di prime cause”. I pagamenti ad iniziare dal 7 settembre 1692 furono effettuati da Carlo Vivacqua, Gostino Gualcuto, Diego Vizza. Nell’annata seguente 1693/1694 la mastrodattia fu affittata a Giovan d’Aggiano e compagni ed i tre pagamenti ad iniziare dal 7 settembre 1693 furono effettuati da Carlo Cariati, Gio. Porsio Celsi e Gio. Aggiano. Infine nel 1694/1695 fu affittata a Domenico Abbruzzise Horatio Gratiano e compagni.
Bagliva e Pelaggi (bene feudale)
Dalla “bagliva e pelaggi” l’erario del barone esigeva ogni anno ducati 40, in tre rate a iniziare dal 7 settembre. Il bene era preso in fitto da benestanti del luogo in società. Nel 1692/1693 era affittata ad Antonio Gratiano e compagni. Nel 1693/1694 ad Antonio Cariati e compagni. Nel 1694/1695 ad Francesco Lappano, Domenico Basile e compagni.

Scala Coeli (CS), il paesaggio della vallata del Fiumenicà.
Doana e Pigliate civili (bene feudale)
La Camera baronale incamerava ogni anno dal fitto della dogana ducati 24. Il bene feudale era preso in fitto da benestanti del luogo che si associavano tra loro. Nel 1692/1693 troviamo Gio. Battista Tadeo, Oratio Caligiuri, Michel’Angelo di Ricci, Francesco Calabrese, Colella Tringoni e Antonio Cosenza. Nel 1693/1694 Francesco Vivacqua, Michele di Trani, Gioseppe Lappano e Salvatore Vizza. Nel 1694/1695 Donato Jacovino, Antonio Scorpanisi e compagni.
Censi Ordinari (bene feudale)
Il barone esigeva numerosi censi dagli abitanti del luogo. Si trattava di solito di concessioni di piccoli terreni a vigna ad abitanti del luogo, “come per platea”, sui quali il censuario pagava un annuo onere prestabilito. Dai censi ordinari la camera baronale ricavava ogni anno 33 ducati. Sono citati Gio. Bacciliero, Gio. Mataluni, Gio. Vittorio Brancato, Salvatore di Tarsia, Gio. Trocca.to, Benedetto di Carlo.
Musto sopra le vigne del qm Giacomo Griscionari (bene feudale)
La Camera baronale esigeva da coloro che prendevano in fitto le vigne che erano state di Jacovo Griscionari salme quattro per una rendita di due ducati e due tari. L’entrata rimase inalterata per tutte le annate dal 1692 al 1695.
Vendita di animali
La compra e la vendita del bestiame avveniva soprattutto nelle fiere. I Scalesi sono presenti oltre che nella fiera della Ronza, in quelle di Sant’Antonio, di San Marco, e di San Giovanni dell’Agli.
1693/1694: “D.r Antonio Verticillo per porci n.° 80 venduti in fiera di Sant’Antonio d’ottobre 1693 – doc. 8; Rev. D. Jacovo Funaro per genchi n° 4 in fiera di S. Marco 94 e tre del Rev. D. Marco d’Aggiamo ch’à carlini quattro l’uno doc. 2 – 4.
1694/1695: “D.r Antonio Verticillo per nove giovenchi venduti nelli casali di Cosenza a marzo 1695 car.ni 3 – 3; Fran.co Lappano bovi n.° tre in fiera S. Marco car.ni 1 – 1; D.r Antonio Verticillo in fiera di S. Giov, dell’agli gencaroni n.ro diece doc. 4; D. Pape Funaro in fiera di Ronza 95 vacche figliate n.2 e un bove Doc. 1 – 3; D. Francesco D’Acri vacche figliate n.ro 2 e gencaroni n. 5 doc. 3 -1.

Campana (CS), il luogo dove si svolgeva la fiera della Ronza.
Il Castello (bene feudale)
Al tempo in cui erano feudatari di Scala gli Spinelli, il castello era dato in affitto. Andato in decadenza fu restaurato dal nuovo feudatario il cosentino Maurizio Coscinelli, che lo usò per una sua residenza. Prima di passare in potere del Coscinelli dal relevio presentato dal principe di Cariati Antonio Spinelli nel 1662 il palazzo del castello era affittato e dava una rendita annua di ducati 31. Così è descritto nel relevio del 23 ottobre 1662 presentato da Antonio Spinelli dopo la morte di Scipione Spinelli avvenuta il 22 dicembre 1659: “Li Palazzi del castello” davano una rendita annua di ducati 12, il “magazeno” del castello ducati 10 e le “Camere” ducati 9, per un totale di annui ducati 31.
Quindi alla fine del Seicento “Il Palazzo del castello con le camere di sotto, et magazeno novamente redificate dal Barone non si affitta servendoli per propria habitatione e comodo di esse”. Situazione ribadita dalla testimonianza dell’eletto Antonio Caligiuri, il quale interrogato sulla rendita che ogni anno la corte baronale percepiva dall’affitto del palazzo del castello, formato dalle camere e dai magazzini, rispondeva che “in tempo che questa terra si possedeva dall’Ill.re Principe di Cariati si solevano affittare il palazzo, camere e magazeno del Castello perché non vi habitava il Padrone ma dopo che passò questa terra in dominio del presente barone vi spese il medesimo grosse summe per redificare et accomodare il tutto e sempre è stata habitatione del Barone …”.[xliii]
I Mulini (bene feudale)
Tra i beni feudali redditizi alla Corte Baronale della Terra della Scala vi erano due mulini; quello del Russello e quello del Pantano. Il primo alla metà del Seicento non dava alcuna rendita perché era stato rovinato dalle piene del fiume. Il feudatario tuttavia aveva intenzione di ricostruirlo. Infatti nel Relevio del 1662 è descritto: “Il molino Russello che si dice portato via dal fiume, e che si sta redificando”.[xliv]
Evidentemente la ricostruzione non ebbe luogo in quanto al tempo dei baroni Coscinelli si legge che “Il Molino del Russello non si possiede dal Barone perché si perse via dal fiume assai prima del possesso di d(ett)a Terra”. Convalida l’abbandono la testimonianza del 29 settembre 1695 di Giovanni Ferraro rilasciata al protonotario Horatio Tauro: “Questo molino chiamato del Russello fu portato via dal fiume molto tempo prima che pigliò possesso di questa Terra il presente Barone ne piu mai si è redificato per causa del sudetto fiume che linverno porta piena grande a segno che anco dona fastidio al mio molino e fa dannaggio come seguì nell’anno del mio affitto che il barone fu costretto non solo conciare l’acquaro ma anche farvi una pietra nova e vi spese da circa docati sei”.
Rimaneva alla fine del Seicento il mulino del Pantano detto anche del Lauro. Più volte danneggiato dalle piene del fiume, il mulino come dal relevio nel 1659 era affittato per 35 tomoli di grano che a carlini sette il tomolo dava una rendita di ducati 24 tari 2 e grana 10,[xlv] alla fine del Seicento il suo affitto era calato a tomoli 28 di grano e dava una rendita di ducati 19 e tari 3.
L’affitto del mulino durava un anno, dal primo di settembre alla fine di agosto dell’anno successivo. Gli affittuari erano abitanti del luogo che in società prendevano in fitto per un anno il mulino, obbligandosi con l’erario del barone. Il 10 settembre 1692 in Scala Gioanne Ferraro e Pietro Vulcano si obbligano a pagare alla Corte Baronale e per essa all’erario Benedetto Nocera tomola 28 di grano per l’affitto del molino di Pantano dal primo settembre 1692 alla fine di agosto 1693 e di consegnarli in dies e per tutto agosto 1693 e che la Corte sia obbligata farli pietra e tutti gli acconci. L’anno dopo il mulino è affittato il 5 settembre 1693 in Scala da Gioanne Ferraro e Michelangelo Funaro di Scala con tutte le “pietre ferri e quanto sarà necessario”. Nell’inverno di quell’anno ci fu una piena grande “a segno che anco dono fastidio al mio molino e fe dannaggio … che il barone fu costretto non solo conciare l’acquaro ma anche farvi una pietra nova e vi spese da circa docati sei”.
L’anno seguente il 5 settembre 1694 il mulino è preso in fitto alle stesse condizioni dagli Scalesi Leonardo Pizzuto e Pietro Vulcano e poi nel 1694 “fu affittato a Gio. Ferraro e compagni di questa Terra per tumola ventiotto di grano che valutato alla solita voce di carlini sette fanno la somma di docati diecinove e t.ri tre”. Così chiamato a testimoniare si esprimerà il “bracciale” Giovanni Ferraro della terra della Scala di circa anni 40, che aveva in fitto per un anno continuo dal settembre 1694 per tutto agosto 1695 il molino di Pantano per il prezzo di tt.a 28 di grano: “la voce del grano che si puone fra cittadini di questa Terra sempre corre alla ragione di carlini sette il tumolo et all’istessa ragione si pose in detto anno 1694 per esserno grani mischi et il grano del molino anche si valuta alla med.ma ragione benche l’affitt.re del molino sempre vi perde mentre il grano del molino che si riceve viene di cento mischiglie e non si valuta alla med.ma ragione”.

Scala Coeli (CS), lapide che ricorda i caduti della Grande Guerra.
Entrate burgensatiche
Il terreno di Scandalo, Laurenza, Difese universali vendute, Olive del Pantano, Pantano, Conferma del sindaco, Ius della patente, vigne del Pantano.
Il terreno di Scandalo (bene burgensatico)
Il terreno di Scandalo nell’annata 1692/1693 fu concesso ai massari di Scala perché potessero seminarlo. Per la semina del terreno essi si obligarono a consegnare al raccolto tomola 336 di grano, che a carlini 7 il tomolo danno un’entrata alla Camera baronale di ducati 235 e tari uno. Nelle annate seguenti 1693/1694 e 1694/1695 Scandalo fu dato in affitto ad erbaggio a Nicola Ferro e Anselmo Curcio per ducati 135 annui, che pagarono “in fiera di Ronza”.
Laurenza (bene burgensatico)
Il territorio di “Laurenza” era concesso ai massari scalesi, che lo coltivavano a semina con un contratto di terraggio. Il pagamento era stabilito in maniera fissa in tomoli 12 di grano per un prezzo ducati 8 e tari 2. Presente nell’annata 1692/1693, nel 1693/1694 e nel 1694/1695 non c’è più.
Difese universali vendute (bene burgensatico)
Le entrate della Camera baronale provenienti dalle difese universali, vendute e pagate dal sindaco di Scala all’erario “in fiera della Ronza”, quasi si dimezzarono. Nel 1692/1693 il sindaco di Scala Paulo de Madara “per li terzi et assensi delle difese Universali vendute” versò ducati 108 tari 2 e grana 7 2/4. Nel 1693/1694 il sindaco Domenico Susanna pagò ducati 84 tari 3 e grana 5 2/3. Nel 1694/1695 il sindaco Domenico Susanna versò ducati 69 e grana 3 1/3.
Olive del Pantano e di Archilia (bene burgensatico)
Nell’annata 1692/1693 l’annata fu scarsissima e gli ulivi “non hanno portato frutto. L’annata seguente (1693/1694) gli ulivi nelle località “Pantano” e “Archilia” furono affittati insieme a Michelangelo Funaro e compagni per 180 “militra” di olio, che al prezzo di grana 25 il “militro” (mezza “litra”) resero alla camera baronale ducati 45. Nel 1694/1695 le “olive del Pantano” e quelle di “Archilia” furono date in affitto separatamente ed ad un prezzo più basso, invece che a grana 25 a grana 20, e diedero una rendita quasi della metà dell’annata precedente (invece che ducati 45, ducati 27 e tari 1). Le prime ad Antonio Gratiano per cento “militra” di olio che a grana 20 il “militro” resero duc. 20, le seconde a Giuseppe Ferraro per trentasei “militra” di olio, che a carlini due il militro diedero ducati 7 e tari 1.
Pantano (bene burgensatico)
Nel 1692/1693 è affittato a Felice di Perri per ducati 20 in fiera di Ronza. Nel 1693/94 Pantano con l’arato è affittato a Felice Perri e compagni per duc. 15. Nel 1694/1695 le terre del Pantano in terraggio e pervenutone tt.a 8 di grano a carlini sette il tt.o Duc. 5.3.
Vigne del Pantano (bene burgensatico)
Nel 1692/1693 sono affittate a Domenico Basile, Domenico Abruzzese, Angelo Caligiuri, Antonio Bennardo, Filippo Gratiano, Francesco Lappamo, Antonio Nascà e Marco Antonio Muscimari per 28 ducati e 2 tari. Nel 1693/1694 sono affittate a Angelo Caligiuri, Domenico Rizzuto, Filippo Graziano, Rev, Don Paulo d’Apprezzo, Francesco Lappano, Antonio Lappano, Antonio Bennardo, Domenico Matalone e Ansino Trovato per ducati 28 e tari 2. Nel 1694/1695 sono affittate a Angelo Caligiuri, Carlo Vivacqua, Filippo Gratiano, Francesco Lappano, Paulo Dottore, Domenico Matalone, Francesco Calabrese, Carlo di Carlo duc. 28 e tari 2.
Conferma del sindaco (bene burgensatico)
Ogni anno si eleggeva il sindaco ed un eletto. Il sindaco spettava ai nobili. Una volta eletto il sindaco doveva essere confermato dal feudatario, il quale nell’occasione esigeva cinque carlini. Furono sindaci Paulo de Madara, Domenico Susanna (1692/1693 e 1693/1694), Dieco Vizza (1694/1695) e Petro Vizza (1695/1696).
Ius della patente (bene burgensatico)
Lo ius della patente come mastro giurato era concessa a benestanti del luogo. Per poterla esercitare essi pagavano due ducati annui alla camera baronale. Nel periodo considerato esercitarono la carica Antonio Caligiuri di Carlo (1692-1694) e Pietro Gioanne Raniero (1694-1695).
Note
[i] ASN, Dip. Som. Fasc. 196, f.li 4-6.
[ii] ASN, Torri e castelli vol. 15, f. 19v.
[iii] 01.10.1583. Jo: Alfonso Scarnato della città di Strongoli, retrocede la domus palaziata posta nella terra di Cirò, “sine stabulo cum moeneano fabricato in convic.o portae maviliae”, confine il catogio dell’erede di Petro Malvato, la domus di Joannes Susanna, la via pubblica ed altri fini che Donna Ysabella Scarnata della terra di Scala e Michael Nino della terra di Calopezzati, suocera e genero, gli avevano venduto il 30.12.1582. ASCZ, Not. Consulo B., b. 9, ff. 070-070v.
[iv] 09.08.1579. negli anni passati, Joannes de Falcone della terra di Scala, aveva acquistato dal quondam Blasio de Marco, la domus terranea “cum antro intus ea” sita nella terra di Cirò, in loco “la placa sub castro”, confine la domus di Joannes Coluto, la vinella pubblica di sopra, la via convicinale inferiormente ed altri fini. ASCZ, Not. Consulo B., b. 8, ff. 347v-348.
[v] 19.04.1573. Jo: Maria de Falcono cede ogni diritto a Orzino Grimaldi della terra di Scala, sul casaleno posto dentro la terra di Cirò in loco detto “la rittusa”, confine la domus di Sibilia Philippelli, “menia t(er)rae p.tae”, la via pubblica ed altri fini, che il detto Orzino deteneva in buona fede, per vendita fattagli da Matteo Procaccio. ASCZ, Not. Consulo B., b. 8, f. 19v.
[vi] 31.12.1574. Donna Marg.ta de Castellis figlia del quondam Jo: Battista de Castellis, moglie di Joannes Dom.co Rumei della terra di Scala, vende al no: Petro Carusio, il casaleno sito nella terra di Cirò “in convicinio s.ti jo(ann)is”, confine il casaleno di Jo: Maria de Lalici, la domus di Scipione Philippelli, la domus palaziata di Ascanio Carusio, la domus di Jacobo Iuelis, la via pubblica ed altri fini. ASCZ, Not. Consulo B., b. 8, ff. 96-96v.
[vii] 26.01.1577. Fr.co Rizuto agente in nome del suo privigno Felicis Ant.o Petra Paula della terra di Scala, vende a Joannes Paulo Rizo la “particulam” di un casaleno di detto suo privigno relativa all’eredità di suo padre il quondam Joannes Petra Paula, sita nella terra di Cirò in “loco la valle”, confine la domus di Jo: Battista Inglisi, il casaleno di donna Justinia Curta, il casaleno di detto Joannes Paulo ed altri fini. ASCZ, Not. Consulo B., b. 8, f. 209v.
[viii] 24.02.1577. In relazione al matrimonio tra donna Cenza Poyeria e Jacobo de Felice della terra di Scala, faceva parte della dota della sposa, una casa terranea posta nella terra di Cirò “al convicinio de s.to Menna”, confine la casa di donna Nicola de Juncta, la casa dotale di Alfonso Morello, “la piaza de s.to menne”, “lo vallone seu la via publica” ed altri fini, gravata del censo di un grano alla baronal corte di detta terra. ASCZ, Not. Consulo B., b.8, ff. 215v-216v.
[ix] 04.06.1577. Il not.o Jo: Ber.no de Ber.do della terra di Scala, vende al m.s Jo: Matteo de Joanne, la domus consistente in due membri, una domus terranea “et palatiolo cum Antro intus ea” siti nella terra di Cirò in loco detto “lo celso seu in convicinio s.ti jo(ann)is”, confine la domus nova palaziata di detto m.co Jo: Matteo, la “viam pp.cam qua itur in templum s.ti jo(ann)is p.ti” ed altri fini. ASCZ, Not. Consulo B., b. 8, f. 227v.
[x] 13.10.1578. Donna Rosa de Parisio vedova del quondam Nicolao Crispi della terra di Crucoli, assieme a Jo: Dom.co, Jo: Paulo e Bettuza Crispi suoi figli, ed a Donato Gratiano della terra di Scala, loro genero e cognato, vendono al no: Marco Ant.o Carusio, la domus palaziata sita nella terra di Cirò in loco e convicino “porte cuccuviae”, confine la domus dell’erede di Nicolao de Parisio, la domus dell’erede di Jo: Maria Castrovillari, la domus del magister Fer.di Morelli, la via pubblica ed altri fini. ASCZ, Not. Consulo B., b. 8, f. 301v-302v.
[xi] Giustiniani L., Dizionario geografico – ragionato del regno di Napoli, Napoli 1804, Vol. 8 p. 355. Pedio T., Un foculario del Regno di Napoli del 1521 e la tassazione focatica dal 1447 al 1595, in Studi Meridionali n. 3/1991, p. 263. Barbagallo de Divitiis M. R., Una fonte per lo studio della popolazione del regno di Napoli, Roma 1977.
[xii] Pellicano Castagna M., La storia dei feudi e dei titoli nobiliari della Calabria, Frama Sud 1984, pp. 388-392.
[xiii] Russo F., Regesto, 5287, 5653.
[xiv] Maone P., La Contea di Cariati, ASCL 1963, p. 316.
[xv] Russo F., Regesto, 10354.
[xvi] 23. 3. 1443. “Episcopo Cariaten. Tabelilonatus officium pro Gaspare Calochuri de Scala, presbytero Cariaten. dioc.”. Russo F., Regesto 10704.
[xvii] “… archipresbytero B. Mariae Terrae Scalae, Cariaten. Dioc.. Pro Bernardo de Lignamine nova provisio parochialis ecclesiae S. Basilii in Terra Scalae, dictae dioc., eidem iam ab Episcopo Cariaten, ordinaria auctoritate, collatae. Russo F., Regesto 11448.
[xviii] ASV, Rel. Lim. di Cariati e Cerenzia, 1605.
[xix] ASV, Rel. Lim. Cariati Cerenzia, 1621.
[xx] Agosto 1609 Io Victorio Caligiuro providetur de ecclesia seu cappella S. Mariae de Constantinopoli et de perpetuo beneficio ad altare S. Francisci de Paula, in matrici ecclesia terrae Scalarum, Cariaten dioc., Russo F., Regesto, 26687.
[xxi] Gennaio 1616. De s.c. ecclesia seu cappella S. Mariae de Constantinopoli, vac. Per ob. Io. Victorii Caligiuri, a quatriennio, ac de simplici beneficio, ad altare S. Francisci de Paula, in matrici ecclesia Terrae Scalarum, Cariaten dioc., quorum fructus X duc. Vac. Per ob. Io. Victorii Caligiuri, a biennio, a primaeva erectione, providetur Carolo Vecchierello, clerico diocesano, Russo F., Regesto, 27708.
[xxii] 13.1.1615. Confraternita SS.mi Corporis Christi in ecclesia Terrae Scala Cariaten., Russo F, Regesto, 27496.
[xxiii] Dicembre 1655. De parochiali ecclesia, archipresbyteratu nuncupato, S. Mariae Assumptae, terrae Scalarum, Cariatem dioc., cuius fructus 24 duc. Per ob. Iosephi Vizza, de mense Iulii ex Ro Cu def., providetur Petro Caligiuri, pbro approbato in concursu., Russo F., Regesto, 37727.
[xxiv] 27.9.1663. (Alessandro VII) Pro Michaele Angelo Verticelli, pbro Terrae Scala, Cariaten. dioc., absolutio et dispensatio, ad exercitium ordinum, super irregulitate contracta ex homicidio, die XXVII Iulii 1658, die dominico, post celebrationem Missae in rixa commisso, ad defensionem fratris suis, in platea civ., satisfacto parti et fisco, cum clausola de non celebrando in loco commissi delicti, Russo F., Regesto, 39985.
[xxv] “In Oppidulo Scala cura animarum est penes Archipresbiterum Ecclesiae Parochialis sed onus sacramenta administrandi pertinet ad omnes Sacerdotes d.ae Ecclesiae quia omnes equaliter in Archip.ro percipiunt decimas Parochianorum ex immemorabili consuetudine.” ASV, Rel. Lim. Cariati die octava mensis Julii 1666.
[xxvi] “Continet T.ra Scalarum, quae ab eodem antecessore de Raimundi etiam facta fuit ad instar collegiatae cum tit. canonicatibus, et cura animarum exercetur ab Archipresbytero, et coadiutore, vulgo Parrocho. Incolae huius T.rae sunt 1386 cuius dominium in temporalibus de familia Vitilio cum tit. Marchioins de Auletta à sex circit. Annis translatum est ad Marchionem de Caggiano. Habet dodecim canonicos quinque sacerdotes simplices, duos Diaconos, tres subdiaconos, et duos clericos”. ASV, Rel. Lim. Cariati e Cerenzia 1769.
[xxvii] “Terra Scalarum est sub dominio temporali Marchionis de Auletta familiae Vitilio, habet mille et biscentum habitantes. Cura animarum exercetur per Archipresbyterum et Coadiutorem curatum, sacramenta vero, et sacramentalia tantum in Parochiali sub titulo Assumptionis Beatissimae Mariae Virginis asservantur, adsunt viginti Sacerdotes, unus diaconus, et subdiaconus et tresdecim clerici. Reperiuntur intus Parochialem erectae duae confraternitates sub titulo SS.mi Sacramenti et SS,mi Rosarii Beatae Virginis Mariae, nec non in ecclesia Pietatis adest altera Passione Domini.Adest parvum Monasterium ordinis Carmelitarum, in quo non habitat praefixus religiosorum numerus…. “, Rel Lim. Cariati 1/4/ 1733.
[xxviii] Gennaio 1753. De parochiali, archipresbyteratu nuncupato, terrae Scalae, Cariate. Dioc., cuius fructus 24 duc., vac. per ob. Thomae Marcello, de mense Novembris praeteriti def., providetur Francisco Ranieri, clerico (Russo F., Regesto, 63086). 14.8.1756. Antonio Gervino providetur de beneficio simplici residentiali coadiutori in parochiali Terrae Scalae cum onere coadiuvandi rectorem supradictae parochialis in cura animarum, vac. Per privationem Francisci Ranieri, cui de anno 1753 provisum fuit., (Russo F., Regesto, 63891).
[xxix] Bonifacio IX. 31.5.1402. Archiepiscopo Santae Severinae et Florentin. Ac Umbriaticen. Episcopis mandat ut provideant di S. Blasii de Terra Scalae, quae grancia S. Blasii de Terra Scalae vulgariter nuncupatur, et SS. Quadraginta de Casali Curtalis, ecclesiis ruralibus sine cura Rossanen. et Neocastren. dioc., certo modo vacantibus. Russo F., Regesto, 8861.
[xxx] Eugenio IV. 27.3.1443. Andreae, Abbati monasterii S. Angeli de Militino, Flor. Ord., Rossanen. Dioc., providet de ecclesia S. Basilii de Scala et de quadam foresta, con nonnullis terris et molendino, sito in tenimento Curipolati, in titulum perpetui beneficii ecclesistici assignari consueto, Cariaten. et Rossanen. Dioc., quas Cicchus, electus Umbriaticen., obtinebat et vac. per eiusdem promotionem ad dictam ecclesiam. Russo F, Regesto, 10708.
[xxxi] Callisto III. 24.4.1456. (Ladislao), Episcopo Lucerin. et archidiacono Cariatensi ac archipresbytero B. Mariae Terrae Scalae, Cariaten. Dioc.. Pro Bernardo de Lignamine nova provisio parochialis ecclesiae S. Basilii in Terra Scalae, dictae dioc., eidem iam ab Episcopo Cariaten, ordinaria auctoritate, collatae, Russo F., Regesto, 11448.
[xxxii] 19.3.1513. Aloysio de Gibraleon, clerico Neapolitan, qui cessit archidiaconatu ecclesiae Cariaten et ecclesiis s.c. B.M. Annuntiatae, Cariaten et S. Basilicae, oppidi de Scala, Cariaten dioc. de quibus fuit provisum eidem a Iulio II, reservatur annua pensio 7 duc. Solvendo a Nicolao Iuranna, cui de dicto archidiaconatu et ecclesiis provisum est, Russo F. Regesto, 15463.
[xxxiii] Leone X. 8.6.1513. Thomae de Rubeis, cubiculario suo, providetur de archidiaconatu ecclesiae Cariaten et de ecclesiis Annuntiationis B.M.V. Cariaten ac S. Basilii de la Scala Cariaten dioc., Russo F., Regesto, 15511.
[xxxiv] 9.9.1540. Federico Iuranna, qui nuper resignavit archidiaconatum ecclesiae Cariaten. et B. Mariae et Archipresbyteratus S. Petri Terrae Veteris ac S. Basilii de Scala ecclesias, civ. et dioc. Cariaten, de quibus providetur Petruccio Iuranna, reservatur regressus, Russo F., Regesto, 18298.
[xxxv] 3 feb. 1656. Ad perpetuam rei memoriam. Pro confraternitate S. Mariae de Pietate in ecclesia eiusdem S. Mariae de Pietate, Terrae Scalarum, Cariaten dioc., indulgentia plenaria in festo Inventionis S. Crucis, et 7 annorum in festitatibus BMV, Russo F., Regesto, 37758.
[xxxvi] “necesse duxerim à praedictis mense, et anno in hac terra meam residentiam firmari; quamvis hic locus, haec domus, hocce clima mihi multum dispendiosus sit, mihique augusta nimis, atque meis magis insalubre malis Mihi haec pauca de mea triennali villicatione exponenti nihil superest, ..”. ASV, Rel. Lim. Carlo Ronchi Datum Scalis Nonis Martii MDCCLXII.
[xxxvii] Capialbi La continuazione all’Italia Sacra dell’Ughelli, ASCL, a. 1915, p. 197.
[xxxviii] “Ex quo cives Scalarum permoti, multis literis, multisque Nunciis, ac etiam personali accessu illorum de Regimine exixis praecibus petierunt, illa tam grandia jurgia, litesque illic pluribus abhinc annis exardescente inter eos, et praeteritos Universitatis administratores, ac etiam Ill.rem Marchionem eiusdem Terrae, quae animos nimis devastarunt, et quae nemini, licet magnae authoritatis redere facultas fuit, componere. Quibus, diu à me amare fletis, volens occurrere, Deoque fervide rogato, opportunitatem amplexus, jam composui, et facta est ibi tranquillitas magna, et in pace locus eorum”. ASV, Rel. Lim. 1759.
[xxxix] “Hinc, ut confracta ligarentur, et de via unirentur, cum graves essent lites inter Doctorem Iosephum Tursi Terrae Scalarum, et Ill.rem ipsius Marchionem pro computorum redditione super administratis in hoc feudo per sexennium Agentiis, ad evitanda odia, dispendia, et quamplurima hinc inde perjuria, aliaque innumera peccata, tandem biennio consumptus in labore, et patientia, omnia, utraque parte contenta, non sine maximo mihi dispendio, jam paterne amicabiliterque composui, ita ut hodie cum haedo pardum, et lupum cum agno in sanctitate, et iustitia inhabitare video”.
[xl] “In terra Scala adest quoddam parvum Monasterium fratrum Carmelitarum poenitus quasi colapsum, itaut duo fratres inibi morentur, estque meae Jurisdictionis” ( Rel Lim. Cariati die prima Maii MDCLXXXV), “Adest parvum Monasterium ordinis Carmelitarum, in quo non habitat praefixus religiosorum numerus …” ASV, Rel Lim. Cariati 1.4.1733.
[xli] ASCz, Not. Baldo Console, 1574, ff. 46v-47r.
[xlii] ASN, R.C.S. Relevi b. 385. Calabria Citra Scala 1694. (Inform. Liquid. Relevii Terrae Scalae ob mortem q.m Ill. D.s Mauritii Coscinello in anno 1694).
[xliii] Ibidem, f. 558v.
[xliv] Ibidem, f. 511v.
[xlv] Ibidem, f. 511r.
The post Alcuni aspetti della Terra di Scala al tempo del Viceregno appeared first on Archivio Storico Crotone.
Il giorno della festa della Madonna di Capo Colonna a Crotone
Le fotografie sono state scattate dall’autore, in occasione della festa celebrata nel mese di Maggio 1979.
















































































































The post Il giorno della festa della Madonna di Capo Colonna a Crotone appeared first on Archivio Storico Crotone.
Alcuni graffiti ritrovati sulle mura delle fortificazioni di Crotone
Baluardo Santa Maria




Baluardo Il Fosso

Baluardo Don Pedro































Baluardo Miranda













The post Alcuni graffiti ritrovati sulle mura delle fortificazioni di Crotone appeared first on Archivio Storico Crotone.
La media e bassa Valle del Neto
La festa della Madonna Greca a Isola di Capo Rizzuto




































The post La festa della Madonna Greca a Isola di Capo Rizzuto appeared first on Archivio Storico Crotone.
La chiesa di Santa Anania e la basilica di San Basilio in territorio di Caccuri

Ruderi del casale di Caria presso Caccuri.
In una platea del 1582 dell’abazia di Santa Maria di Altilia ricopiata nel 1678, si legge: “Item una chiusa chiamata S.ta rania confinata sincome per la concessione di essa fatta appare, la quale sarà per di sotto inclusa. Nella platea non ci segue altro per chiarezza della detta chiusa di S.ta Rania”.[i] Come si legge dalla platea, ancora alla metà del Cinquecento rimaneva il ricordo di un antico possesso del monastero di Calabro Maria, situato nella media vallata del Neto nel territorio di Caccuri. Nell’ottobre del 1213 il frate Matteo, abate del monastero di San Giovanni in Fiore, avuto il possesso di quello di Calabro Maria, decide di sopprimervi il rito greco e di imporvi la regola florense. Perciò egli vi invierà un nuovo priore e dei frati che applicheranno alla vita monastica le regole ed il rito florensi. Allo stesso tempo l’abate impone una permuta a favore del monastero florense. Quello di Calabro Maria cede ai Florensi un suo “tenimento” particolarmente adatto alla coltura dell’olivo, dove i monaci di San Giovanni in Fiore potranno liberamente “edificari, inseri, seri, et plantari”. In cambio, i monaci di Calabromaria potranno avere libero pascolo di una mandria in Sila, nel luogo che assegnerà di volta in volta l’abate florense.

Ruderi del casale di Caria presso Caccuri.
Il luogo San Basilio
“Tenimentum oleastri, quod est super ecclesiam S. Ananiae, aptum inserendis arboribus olivarum monasterio Floris de communi voluntate et provisione relictum est. His finibus terminatum. Incipit iuxta locum in quo constructa fuisse ostenditur olim basilica nomine S. Basilii, et ascendit per vallem, quae vocatur vallis S. Basilii et ferit in capite muri veteris et vadit ipse murus a parte orientis versus austrum per capita ipsius oleastriti iuxta vallem quam habet ex parte orientis et descendit in ipsam vallem et inde ascendit versus orientem et ita in directum, tendens per latus montis; demum in descensu torrentis unius ferit in vallem que vocatur de Clara, et inde vertens per meridiem descendit versus occidentem per magnam gravam usque ad viam veterem, quae venit a casali Carie et terram, quae dicitur de Chury Anatholy et inde vertitur et per ipsam viam ex parte occidentis versus aquilonem per super pomarium praedicti S. Ananye et super fontem aquae, qui descendit in illum et habens eamdem ecclesiam a sinistra parte, vadit in directum et ferit in praedictam vallem S. Basilii et concludit in priori loco.”[ii]
Come evidenzia questa descrizione, San Basilio è un luogo situato nella media vallata del Neto in territorio e sotto l’abitato di Caccuri. Costituito da serre, piani e piccole valli, è attraversato dall’importante ed antica via percorsa dalle mandrie che, dai pascoli della marina, salgono in Sila. Per la sua posizione è particolarmente adatto sia alla coltivazione dell’ulivo che alla semina. In esso vi si potranno impiantare alberi da frutto, vigne e raccogliere il grano. Il luogo inoltre, è reso fecondo da una importante fonte di acqua, che sgorga nei pressi della chiesa di Santa Anania e alimenta il vicino frutteto.

Ruderi del casale di Caria presso Caccuri.
La toponomastica
Nel foglio 237 dell’anno 1924 dell’Istituto Geografico Militare (S. Giovanni in Fiore), troviamo i toponimi “Caria”, “S.ra S. Biagio” e “Lania” (Rania). Sappiamo che il casale di Caria apparteneva al monastero di Calabro Maria fin dai primi privilegi concessi al monastero dai regnanti Normanni e Svevi. Oltre al casale che appare nella carta IGM del 1924 e di cui rimangono i ruderi, nel Medioevo c’era quello vicino al monastero di Calabro Maria ed al quale si riferisce il documento.
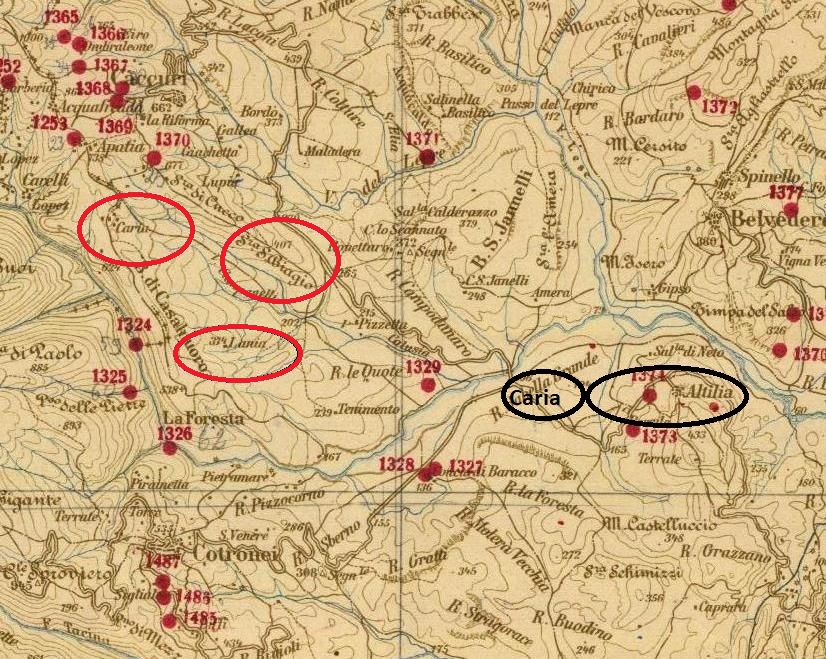
Caria presso Caccuri e Caria presso Altilia.
Nella Platea del 1582, descrivendo i confini del tenimento di Neto, situato in territorio di Roccabernarda e appartenente al monastero di Calabro Maria, la località Caria è così situata “… esce allo timpone de castelluzzo, et discende lo timpone à bascio termino med.te et esce allo canale de Caria, et ascende lo vallone ad irto de Caria confinando con lo castelluzzo e confina alla terra de crapari …”. Proseguendo nella descrizione dei beni del monastero si legge: “Item una cabella chiamata Caria con pochi terre inculte di salmate vinti incirca … Item l’altra parte del bosco nel territorio di Rocca bernarda lo quale possedono l’habitanti del Casale di Caria vassalli di esso Ill.e S.r Abbate”.[iii]
Descrivendo i confini del Corso di Casale Novo, un documento del 1576 così situa il casale di Caria: “… onde per diritto al cristone de Armirò, et Caria saglie alle scalille de Altilia …”. Ancora oggi è ben identificabile la località “Caria” sotto le “Serre di Altilia”. Essa è situata sulla traversale che congiungeva la vallata del Tacina con quella del Neto e sulla direttrice che, salendo dalle due vallate e guadando il Neto, risaliva a sinistra del fiume per Santa Rania verso la Sila.
San Basilio latinizzato in S. Biagio è richiamato dal toponimo Serra di San Biagio dove era situata l’antica “basilica” dedicata a San Basilio che, al tempo del passaggio del tenimento da Calabro Maria ai Florensi, era ormai abbandonata e distrutta ma di cui rimanevano ancora i ruderi. Il toponimo Lania non è altro che una storpiatura di Rania o Anania cioè di Santa Anania. Sempre nella stessa località rimane l’antica via che da Caria risale verso la Sila. Sempre in territorio di Caccuri vi è a ricordo dell’antica basilica il toponimo “Basilico”.

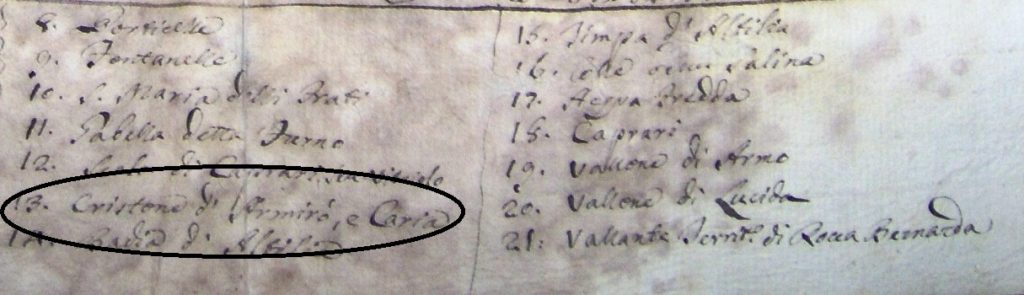
La località “Caria” presso Altilia in una carta conservata all’Archivio Arcivescovile di Santa Severina.
I possedimenti del monastero florense in territorio di Caccuri
Il toponimo San Basilio compare numerose volte nelle platee del monastero di San Giovanni in Fiore. Dalla Platea del monastero dell’anno 1533, sappiamo che il luogo San Basilio non apparteneva più direttamente al monastero, ma a numerosi enfiteuti che pagavano per questa concessione ogni anno un censo al monastero.
“Paulo Pallari tene una vigna in loco dicto / S. Basilio da circa una quartucchiata, et / cum terreno da circa tumulata meza, confi / nata verso Ponente le Terre de li Eredi di / Iacubo Russo, verso levante le Terre, che / ipso Iacubo de la Corte, verso scirocco le / Terre de Berardino Pallari, e pagava / grana due, al p(rese)nte paga anno quolibet / a dicto Monasterio grana quattro 0.0.4” (a margine: S. Basilio).
Berardino Pallari tene in lo supradicto loco / una vigna, et intorno dicta vigna da circa / tumulate quattro de Terre confinate verso / Ponente la via publica, verso borea / la vigna de Paulo Pallari, et pagava / g(ra)na quattro, et mezo, al p(rese)nte paga anno / quolibet ad dicto Monasterio tarì uno / dico 0.1.0” (a margine: S. Basilio).
Ioanromano Pallari tene in lo retroscritto loco / de S. Basilio una vigna, et terreno intor / no, che va co dicta vigna, è da circa tumu / late tre, et meze confinate de le Terre / de Berardino Pallari, et de Paulo Pallari, / et altri confini, et pagava g(ra)na quattro / al p(rese)nte paga allo dicto Monasterio anno / quolibet g(ra)na sidici. dico 0.0.16” (a margine: S. Basilio).
Girardo Pallari tene una vigna in loco / dicto Santo Basilio da circa tumulata / meza, et cum Terreno intorno da circa / tumulate, [spazio albo] confinate da uno lato le / Terre de Francesco Monteleone, et fosso / corrente, et pagava g(ra)na quattro, et sei / cavalli, al p(rese)nte paga anno quolibet a / dicto Monasterio g(ra)na decesepti, e mezo / dico 0.0.17 ½” (a margine: S. Basilio).
Cola Pallari tene in dicto loco de Santo / Basile una vigna arborata de celsi, / et altri arbori da circa una tumulata / cum terreno intorno da circa un altra / tumulata, confinata de le Terre de / Alfonso Russo, et verso Ponente le Terre / Auluchio la machia, et pagava g(ra)na / due, et mezo, al p(rese)nte paga anno quoli / bet à dicto Monast:rio g(ra)na dece, dico 0.0.10” (a margine: S. Basilio).
D. Antonio d’Anibaldi di Versini tiene, e possiede nel / luogo detto San Basilio diversi pezzi di Terreno / che nella Platea Vecchia fol: 230. 31. 32. et 33. / Stanno notate Sotto nome di And.na la macchia / Gio Andrea Russo in cinque partite del Ven(erabi)le / Monastero di Santa maria delle Grazie di / detta Città, e di delica Pellari, quali confi / nano colla difesa d’Agostino Rao l’olive del R.o Capitolo di d.a ed in altri fini, e ne paga / in tutto anno tari quattro, e grana cinque. – 4.5.
Lo Monasterio predicto tene in loco dicto Santo Ba / silio uno pezo de Terreno boscuso da circa tumu / lata meza, confinato verso levante Gravatto / ne Seccagno, et verso Ponente le Terre de Pe / truzo Sbarrera, et lormunciaro Alfonso Russo” (a margine: S. Basilio).[iv]

Le Serre di San Biagio.
Note
[i] ASCz, 529, 659, B. 8, Copia di Platea antica con i pesi de’vassalli, ff. 4v-5r.
[ii] De Leo P. (a cura di), Documenti Florensi, pp. 51-53.
[iii] ASCz, Copia cit., ff. 1-2.
[iv] ASN, Real Militare Ordine Costantiniano, Libri maggiori e platee, busta 78/I, ff. 98 – 99.
The post La chiesa di Santa Anania e la basilica di San Basilio in territorio di Caccuri appeared first on Archivio Storico Crotone.
La chiesa di San Martino di Neto, obbedienza del monastero di Abate Marco

Localizzazione del monastero dell’Abate Marco (estr. da Cosco F., Le orme del Monachesimo nel territorio del Parco Nazionale della Sila, San Giovanni in Fiore 2014).
Il monastero di Santa Maria de Abate Marco e/o di Santa Maria di Monte Marco è già presente prima della fondazione dell’abazia florense,[i] di cui i primi documenti ci indicano chiaramente il luogo dove era situato. Esso è uno dei termini dei confini del vasto territorio silano dato dall’imperatore Enrico VI nel 1194 all’abate Gioachino: “… et ascendit terminus per alveum eiusdem fluminis Neti et vadit ultra flumen per fines monasterii Sanctorum Trium Puerorum et monasterii Abatis Marci usque ad viam que venit a civitate Acheronteae et vadit per portium, que vidilicet via manet in confinio a parte aquilonis usque ad locum qui dicitur Frassinitum …”.[ii]
Concesso tra alterne vicende ai Florensi dai vescovi di Cerenzia, nel luglio 1208 fa parte dei possedimenti e privilegi che l’imperatore Federico II riconosce all’abazia di San Giovanni in Fiore.[iii] Anche il papa Onorio III nel 1218 ne riconosce l’appartenenza ai Florensi.[iv]
Secondo il Napolitano il monastero di Abate Marco “sorgeva a oltre 900 metri di altitudine, sul versante orientale di monte Gimmella, non lontano dal “Vallone di Lepore” ove un tempo sorgeva il 46° pilastro o termine della R.S. già 41° della confinazione di Valero, in luogo ancor oggi detto Petramarca … il sito, delimitato dalle contrade Patacchella, Repulicchio e Parpusa, abbonda ancor oggi di laterizi e pietrame diruto ed è attraversato dall’antica mulattiera, o “strada di Abate Marco”, che, salendo dalla chiesuola di S. Maria Trium Puerorum, per il vallone di Belladonna, “la scanzata delle Fontanelle esce alle castagne dette l’Abbate Marco”, e, per la Stragola, luogo ove un tempo sorgeva il 45° pilastro o termine della R.S. già 40° della confinazione di Valero, “va allo Cerchiaro e a S. Ioanne”. Il giudice Zurlo che vi fu di persona nel 1790, dice che ivi “erano molti piedi di castagne antiche che stavano alla destra del cammino nella falda della collina, ed a sinistra in un poco di piano vi sono li vestigi del Monistero detto dell’abate Marco”. Aggiunge però che nel 1755 non vi si trovarono più né “le reliquie del Monastero dell’Abate Marco, né gli alberi delle castagne che vi erano negli anni 1663 e 1721”.[v]
Anche per il Russo il monastero di Monte Marco “era in diocesi di Cerenzia, presso le sorgenti del fiume Lepre, affluente del Neto. Fu dato a Gioacchino, verso il 1198, dal vescovo Gilberto, suo amico. Ma, morti i due protagonisti, il vescovo Guglielmo annullò la concessione. Nel 1209 il vescovo Bernardo, succeduto a Gugliemo, reintegrò i Florensi nei diritti del monastero di Monte Marco. Se ne ebbe conferma con bolla di Onorio III del 22 gennaio 1218. Se ne vedevano ancora i ruderi nel 1663 e nel 1721, secondo lo Zurlo. Nel 1775 invece ogni vestigio era scomparso”.[vi]
La diocesi di Cerenzia
Nel pagamento delle decime alla Santa Sede al tempo di Giovanni XXII (1316-1334), compaiono in diocesi di Cerenzia i nomi dei casali di Verzino e Lucrò (“Viri et Lucrò”) ed il castrum di Caccuri. Dalle relazioni dei vescovi di Cerenzia dell’inizio del Seicento, sappiamo che in diocesi di Cerenzia vi erano due terre e due casali, cioè le terre di Caccuri e Verzino ed i casali di Montespinello e Belvedere. Il vescovo Maurizio Ricci ci informa che “Per la cura dell’anime vi erano cinque chiese parrocchiali cioè Santo Martino S.ta Maria della piacza, S.ta Marina S.ta Dom.ca et S. Nicolo le quali chiese sono destrutte et la cura è ridotta alla cathedrale sotto il tit.lo di S.to Theodoro, et ogni dignità tiene unita una di dette chiese curate, Come passa q.st’unione non si sa perche no vi è Archivio ne scrittura alcuna.”[vii]
La diocesi di Cerenzia, da una parte, confinava con la diocesi di Umbriatico e dall’altra, con la diocesi di Santa Severina. Se nel Seicento il fiume Neto segnava uno dei confini tra la diocesi di Cerenzia e quella di Santa Severina, nel Medioevo le cose erano state diverse, in quanto uno dei confini era l’abazia di Calabro Maria che, per molto tempo, godette di un suo territorio e solo successivamente, entrò a far parte del tenimento di Santa Severina.[viii]
Alla ricerca della chiesa di San Martino
Nell’ottobre 1209 Gilberto, vescovo di Cerenzia, concesse “sub annuo censu” all’abate Gioacchino e ai suoi frati, il monastero di Abate Marco e la chiesa di Santo Martino di Neto con i loro privilegi e possedimenti. In seguito il vescovo di Cerenzia Guglielmo revocò la concessione e perpetrò delle distruzioni ai luoghi, ma il nuovo vescovo e successore Bernardo riconcesse nuovamente all’abate Matteo il monastero di Abate Marco “cum ecclesia S. Martini de Neto, quae in tenimenti Calabromariae confinio sita est et omnibus tenimentis suis”.
Il vescovo inoltre diede all’abate florense due altre chiese, cioè la chiesa di Santa Maria de Agradia e la chiesa di S. Lorenzo. Esse in passato erano state due piccoli monasteri, ma da anni erano desolate e ridotte “in reptilium excubas et ferarum”. L’abate potrà così riedificare un unico monastero in monte Marco utilizzando i beni delle tre chiese “cum ista de Neto”. Il nuovo monastero poi non sarà soggetto al vescovo di Cerenzia.[ix]
La chiesa di San Martino, “obedientia” del monastero dell’Abate Marco (“… ecclesiam Sanctae Mariae de Monte Marcii cum obedientia S. Martini de Neto”),[x] come risulta dai pochi documenti nei quali è accennata, era situata in diocesi di Cerenzia vicino al fiume Neto, e ai confini del tenimento dell’abazia di Calabro Maria (“… ecclesia Sancti Martini de Neto, quae in tenimenti Calabromariae confinio sita est”).[xi]
Nel Medioevo, il tenimento dell’abazia di Santa Maria di Altilia, se da una parte confinava con il territorio di Roccabernarda e con quello di Santa Severina, dall’altra il fiume Neto ne segnava il limite anche con la diocesi di Cerenzia, e quindi, con i territori di Caccuri e di Belvedere Malapezza. Il fatto che nel documento di concessione rilasciata dal vescovo Bernardo si accenni al Neto, ci spinge a dirigere la nostra ricerca sulla riva sinistra del fiume. Il Neto, oltre a separare il territorio dell’abazia di Altilia dalla diocesi di Cerenzia, è spesso richiamato per le sue rovinose piene e per il mutamento continuo del suo corso, come documentano le liti per i limiti dei territori situati nelle sue vicinanze.

Il corso del fiume Neto presso Poligrone.
I possedimenti dell’abazia florense nella bassa valle del Neto
L’abazia florense oltre a possedere la grancia di Santa Maria de Terrate, in territorio di Rocca di Neto, ed il territorio di Iuca (o Fluce), situato presso la confluenza del Vitravo con il Neto, entrambi in diocesi di Santa Severina, aveva anche altri terreni nella bassa vallata del Neto, in diocesi di Cerenzia, come risulta dalla conferma dei beni del monastero florense fatta nel gennaio 1233 da Gregorio IX. Tra questi vi erano “tenimentum Miliae, Vallium quoque Policronii, quae prope Netum sunt”.[xii] Una parte di Poligrone era stata donata al monastero florense dal milite di Santa Severina Ioannes de Lacta.[xiii]
La presenza dell’abazia florense è anche documentata da una lite che oppose la grancia di Sant’Elena dell’abazia di Santa Maria del Patire al monastero florense. Nel 1246 il vescovo di Strongoli Guillelmus fu giudice ed arbitro di una lite che opponeva l’abate Mattheus del monastero di San Giovanni e l’archimandrita Nymphus del cenobio del Patire di Rossano. La questione oggetto di contesa era il diritto di presa d’acqua e di passaggio di un acquedotto che, attraverso le proprietà dei florensi, alimentava il mulino della fattoria della grancia di Santa Helena del monastero di Santa Maria del Patire. Il vescovo riconobbe il diritto del monastero del Patire alla presa e al passaggio dell’acqua per alimentare il mulino e allo stesso tempo, concesse ai florensi il diritto di potervi macinare.[xiv]

Il Neto, il “Piano di Marrio” e Poligrone in una carta della fine del Seicento.
Da San Martino a San Mario a Marrio
Dal Relevio presentato per conto del principe di Cerenzia Vincenzo Rota alla morte del padre Tomaso, nella “Nota dell’entrate feudali della terra di Belvedere, e feudo di Malapezza”, dal febbraio 1726 al febbraio seguente, troviamo citato più volte le vigne di Neto, la difesa e volta di Neto e soprattutto, le vigne del “Piano di S. Mario”. Le entrate erano calcolate in ducati 1030 annui, dai quali dovevano dedursi alcuni pesi, tra i quali quelli dovuti al vescovo di Cariati, che ammontavano a ducati 60 di censo enfiteutico e ducati 60 per decima.[xv]

Veduta della località Poligrone.
Le località Neto e Giardino di Neto
Dagli “Atti preliminari e Rivele ecc.” del Catasto Nociario del 1743 di Belvedere Malapezza,[xvi] sappiamo che nel territorio di Belvedere Malapezza vi erano due feudi nobili, uno chiamato Marrio seu Agromoletto e l’altro Polligrone.
Marrio di circa 300 tomolate “fra terre fertili boscose ed inculte”, confinava con il feudo Polligroni e le difese Barretta e Malapezza[xvii], mentre Polligrone limitava “con le pertinenze della terra di Rocca di Neto, della terra di Casabona e il feudo di Marrio”. I due feudi dell’estensione di tomolate 850, avevano come limiti “le pertinenze della Rocca, fiume Nieto e territorio di Casabona”.[xviii]
Nello stesso catasto sono elencati i numerosi abitanti di Belvedere ma anche di Altilia, che possedevano vigne nei luoghi detti “Neto” (Pietro Arcuri, Diano Montefusco, Leonardo Coverà, Antonio Legname, ecc.) e “Giardino di Neto” (Casimiro Labbruti, Carmine Carvello, Giacinto Amminò, ecc.).
Il luogo detto “Neto”, come appare dalla descrizione di una chiusura di terre appartenente a Giacomo Amminò, confinava con il feudo di Marrio della Camera Principale di Belvedere Malapezza.[xix]
Note
[i] De Leo P. (a cura), Documenti florensi, Rubbettino 2001, p. 7.
[ii] De Leo P., cit., p. 9.
[iii] De Leo P., cit., p. 30.
[iv] Russo F., Regesto, 606.
[v] Napolitano R., S. Giovanni in Fiore monastica e civica, Napoli 1981, pp. 137-138.
[vi] Russo F., Gioacchino da Fiore e le fondazioni florensi in Calabria, Napoli 1959, pp. 147-148.
[vii] ASV, SCC. Rel. Lim. Cariaten. Geruntinen., 1621.
[viii] Un prezioso documento del secolo XV, Siberene p. 160.
[ix] De Leo P., cit., p. 36.
[x] De Leo P., cit, p. 74.
[xi] De Leo P., cit., p. 36.
[xii] De Leo P., cit., p. 125.
[xiii] De Leo P., cit., pp. 099-101 e 102-103.
[xiv] Ughelli F., Italia Sacra IX, 517-518.
[xv] ASN, Relevi, B. 398, f. 7.
[xvi] ASN. Catasto Onciario Belvedere Malapezza, n. 6941.
[xvii] ASN. Catasto cit,. f. 255.
[xviii] ASN. Catasto cit,. f. 276.
[xix] ASN. Catasto cit,. f. 236.
The post La chiesa di San Martino di Neto, obbedienza del monastero di Abate Marco appeared first on Archivio Storico Crotone.
San Maurello poi San Morello. Un piccolo paese, una lunga storia

S. Morello frazione del comune di Scala Coeli (CS), (da ilponte-online.it).
“San Morello casale Reg. sopra un Monte scosceso, d’aria buona, Dioc. di Cariati, 3 miglia distante da detta Città. Produce grani, frutti, vini, olj, manna, ed erbaggi. Fa di pop. 320.”[i]
L’abbazia del Patire
Nel mese di maggio 1130 il re Ruggero confermava all’abate Luca del monastero del Patire tutti i privilegi e le terre, le chiese ed i casali, tra questi vi erano alcuni possedimenti in “agro” di San Mauro, donati dal protonotario Christodulo.[ii] Allora così l’Edrisi collocava l’abitato di San Mauro: “Tra Cirò a rusyanu (Rossano) la marittima quindici miglia. Da Rossano a sant mawru (San Mauro) cinque miglia. Tra San Mauro ed il mare sei miglia.”[iii]
Nelle decime per la Santa Sede del 1325 compaiono in diocesi di Rossano, sia l’abitato di S.to Mauro che quello di S.to Maurello.[iv] In seguito il casale di San Mauro fu abbandonato, mentre rimase quello vicino di San Maurello.
Il legame tra San Mauro e San Maurello sarà evidenziato molti secoli dopo dalla platea dei beni del Patire del 1661, dove non compare più l’antico casale di San Mauro ma quello di San Morello. Alla metà del Seicento l’abbazia vi conservava ancora i numerosi beni concessi nel Medioevo, anche se su alcuni aveva perso il controllo diretto, perché erano detenuti in enfiteusi da abitanti del luogo.
Dalla platea risulta che l’abbazia possedeva in territorio di San Morello: “Una vigna nella contrada Le Macchie: Due predi di 2 tomolate nel luogo detto Verdi; un altro di 6 tomolate nella contrada Pantano; una vigna nella contrada Li Cucchiari; una vigna presso il Vallone del Verde; un altro possesso vicino Le Macchie; alcuni alberi di olivo nel luogo detto Le Manche, dove possedeva pure altre terre e vigne, una vigna nella contrada Verdò; terre nelle contrade Cerza Mossa, Manche, Verdò, nonché 35 carlini e mezzo di piccoli censi in danaro”.[v]

S. Morello. Particolare del Foglio N. 553 “Cariati” 1:50.000 dell’IGM.
La chiesa di San Nicola
La chiesa è già presente all’inizio del Trecento, infatti nel 1325, “dompnus Adam S.ti Maurelli” versa grana. Decem per le decime della Santa Sede.[vi]
Nel 1437, su preghiera di Covella Ruffo, contessa di Montalto, la chiesa di S. Pietro di Cariati fu eretta in cattedrale ed unita a quella di Cerenzia dal papa Eugenio IV. Con la creazione della nuova cattedrale oltre alla città di Cariati anche le due terre di Scala e di Terra Vecchia ed il casale di Santo Maurello, che erano parte della diocesi di Rossano, passarono a far parte della nuova diocesi di Cariati.
Per avere ulteriori notizie della chiesa arcipretale intitolata a Santo Nicola dobbiamo aspettare i primi anni del Cinquecento. I primi atti di nomina degli arcipreti documentano il fatto che le rendite arcipretali della chiesa di Santo Nicola della terra di Santo Maurello sono di pertinenza dei “familiari” del papa. Questo fatto determinerà spesso lo stato di abbandono della cura delle anime del casale, in quanto coloro che avranno l’arcipretura della matrice spesso non risiederanno nel casale ma delegheranno dei rettori o degli economi per gestire le rendite.
Il 17 luglio 1509 il papa Giulio II interveniva a favore del prete di Rossano Giovanni Palaminuta, scrittore della Curia Romana e suo familiare, concedendogli la chiesa arcipretale di San Nicola della terra di Santo Maurello in diocesi di Cariati. Il papa ordinava di toglierla a Giovanni Canterisano, che la deteneva illegalmente.[vii]
Segue un intervento del papa Paolo III. Essendo morto Bartolomeo Lombardi, il 24 novembre 1544 il papa concede al suo familiare Tommaso Cardamusto il perpetuo beneficio dell’arcipretato della chiesa di Santo Nicola.[viii]
Passano pochi mesi e lo stesso papa nomina nuovo arciprete il suo familiare Raimundo de Natali.[ix]
Alla morte di Raimondo o Lorenzo de Natali segue la nomina, il 15 maggio 1560, del chierico cosentino Leonardo Leto.[x] Pochi giorni dopo il papa Pio IV incaricava l’arciprete della terra di Scala Bernardo Medici, l’arciprete della terra di Apriliano Leonardo de Bono ed il canonico di Belcastro Vincenzo Gargano di prendere in consegna la chiesa arcipretale di San Nicola di Santo Maurello, che egli ha concesso a Leonardo Leto.[xi]
Sappiamo che nel Sinodo Diocesano indetto dal vescovo Properzio Resta in Cariati l’8 gennaio 1594 partecipò D. Filippo Missina, arciprete di S. Morello.[xii]
All’inizio del Seicento il vescovo di Cariati e Cerenzia Filippo Gesualdo mette in risalto la precarietà e lo stato di povertà della chiesa di San Maurello, tanto che vi manca l’arciprete per le scarse rendite. “Il casale di S.to Maurillo ha la sua chiesa curata co’ titolo di Arcipretato, il q(ua)le ha le decime incerti di Morti, e servitio di Capille, vi è la compagnia del Santis.o Sacramento”[xiii] … “in S.to Maurello vi manca l’Arciprete che ha cura dell’anime per esser affetto alla Sede Apostolica stante la tenuità dell’entrate, non è chi voglia ricorrere per la speditione”.[xiv]
Per tutto il Seicento e Settecento, a causa dei pochi e spesso precari abitanti, il numero dei quali a seconda delle annate oscillerà, come riportano i vescovi, da 200 a 500[xv] e per la scarsità delle entrate, spesso l’arcipretura rimarrà vacante e la chiesa sarà amministrata da un economo.
Il 7 aprile 1649 essendo morto l’arciprete Giovanni Perella, Innocenzo X nomina arciprete Antonio de Ascensio.[xvi] Segue un lungo periodo nel quale la cura delle anime è esercitata la un rettore.[xvii]
Durante questi anni segnati dalla miseria e dalla povertà, causata dal fallimento dei raccolti e dalle epidemie, la chiesa matrice è quasi ridotta in rovina. Il vescovo Geronimo Barzellino, preso atto della grave situazione, nel 1680 inizia a ricostruirla; passano due anni ed i lavori molto lentamente proseguono.[xviii] Dopo cinque anni la chiesa non è ancora terminata.[xix] Altri due anni e la costruzione non è ancora perfezionata.[xx]
Morto nel mese di aprile del 1689 l’arciprete Onofrio de Accursio, la chiesa rimane vacante in quanto non c’è nessuno “qui provideri vellet de beneficiis praedictis pro non faciendis in Dataria Apostolica expensis Bullarum quia redditus et proventus cuiuslibet Beneficii, non ascendunt ad ducatos decem monetae Regni Neapolis”, ed il vescovo Sebastiano delli Franci chiede al papa di favorire la nomina di un nuovo arciprete, altrimenti nel casale verrà meno la cura delle anime.[xxi]
Nonostante la supplica la chiesa continuerà ad essere amministrata da un economo non stabile. Nel frattempo poiché l’edificio aveva subito gravi danni dal terremoto del 1688 ed i sacramenti e le funzioni religiose erano conservati e amministrati nella piccola chiesa della SS.ma Annunciazione, il vescovo Delli Franci con suo denaro la fa restaurare e riformare e la riapre al culto.[xxii]
Dopo un lungo tempo che era rimasta senza arciprete, la carica fu assunta da Parisio de Parisio, ma alla sua morte avvenuta nel maggio 1703, ritornava alla cura di un economo.[xxiii] Solamente nel novembre 1714 avveniva la nomina del nuovo arciprete, il prete di Cariati Vincenzo Leonardo.[xxiv] All’arciprete Vincenzo Leonardo seguì Donato Diacono, che partecipò al sinodo convocato dal vescovo Giovanni Andrea Tria, in Cariati dal 16 al 18 marzo 1726.[xxv] Allora la chiesa di S. Nicola poteva contare oltre che su un arciprete anche su un altro sacerdote ed un chierico.[xxvi] Morto Donato Diacono, il 17 marzo 1747 seguì il prete di Rossano Filippo Talarico[xxvii] ed alla sua morte, avvenuta nel mese di ottobre del 1787, assunse la carica nel settembre 1790 Gaetano Talarico.[xxviii]

L’abitato di “S. Morello” ed i luoghi vicini. Particolare della tavola N.° 27 (1788) della carta di G. A. Rizzi Zannoni.
Popolazione
Dalla tassazione per fuochi risulta che il numero degli abitanti, tranne una breve fase di crescita nella prima metà del Seicento, oscillerà tra i 20 ed il 30 fuochi, che possiamo stimare tra i 100 ed i 200 abitanti.
Anno 1521: fuochi 27;[xxix] anno 1533: fuochi 31; anno 1545: fuochi 18; anno1561: fuochi 21; anno 1595: fuochi 38; anno 1648: fuochi 59; anno 1669: fuochi 27; anno 1737: fuochi 24.[xxx]
Economia e società
La proprietà ed i diritti sul territorio erano detenuti quasi completamente dall’abbazia del Patire, dal feudatario e dal vescovo di Cariati. Agli abitanti del luogo, quasi tutti braccianti, rimaneva la casa terranea e qualche vigna gravata di censi. Essi prendevano in affitto con contratto a terraggeria dal feudatario ogni anno piccoli terreni adatti alla semina, obbligandosi al raccolto a pagare un canone fisso in grano.
Beni feudali
Il “Relevio delo Ill.o S.r q.o donno Ant.o de Aragonia Duca de Montealto” del 1544,[xxxi] ci informa sulle rendite, che il duca percepiva annualmente all’inizio del Cinquecento dal feudo di S. Maurello. Esse erano composte da quattro voci principali, che in ordine decrescente per importanza di gettito erano: I pagamenti fiscali pagati al feudatario dall’università di San Maurello (41%),[xxxii] l’affitto a pascolo concesso quasi sempre a custodi d’armenti dei casali di Cosenza (41%),[xxxiii] la bagliva, che era data in fitto a benestanti del luogo (11%)[xxxiv] ed i censi e gli affitti provenienti dalla concessione a semina dei terreni (7%).[xxxv] Il tutto rendeva poco più di cento ducati.
Dal “Quinterno del grano de la Corte exatto per me S.to Forno de lo territorio de p(etra) p(au)la et s.to maurello” riportiamo l’elenco degli abitanti di Pietrapaola e di San Morello, che alla metà del Cinquecento avevano in fitto con contratto a terraggeria i terreni del duca di Montalto. Accanto al nome del terraggere è segnata la quantità di grano, che egli doveva all’erario della corte ducale. Si trattava della conduzione a semina di piccoli vignali quasi tutti della stessa estensione.
(Pietrapaola): Thi galtirello t.a 30 – 90; Franco mingore t.a 14 – 90; Vinzalao fuxco t.a 03 – 90; Cola cicita t.a 02 – 90; B.b. fistilli t.a 02 – 90; Joi patera t.a 02 – 90; Morrizano de manfuda t.a 01 – 90; Adante calabrese t.a 01 – 90; Mantio blacona t.a 00 – 92; Cesaro picachio t.a 02 – 90; Ber.no viola t.a 04 – 90; Joan frida t.a t.a 01 – 92; Ber.no sciglano t.a 01 – 92; (totale t.a 64 – 92).
(San Morello): Cesaro Giradino Inalia t.a 02 . 90; Aug.no visanti t.a 00 . 92; Ber.no Viola t.a 01 . 90; Cola vulcano t.a 00 . 92; Ant.no curto t.a 00 . 92; Hier.mo vulcano t.a 00 . 92; Ant.no riczuto t.a 01 . 91; B.b. Viola t.a 2 . 90; Janbaro la mantia t.a 01 . 90; Valerio fuxco t.a 02 . 90; Palerano marino t.a 01 . 90; Cruchie vulcano t.a 02 . 90; Et in alia lo sup.to t.a 01 . 91; Andria cuvello t.a 01 .- 91; Linardo rumpano t.a 00 . 93; (totale) t.a 17 . 92.

Panorama da S. Morello (da mapio.net).
Pascolo e semina
Il 15 marzo 1585 Camillo de Alemagna, procuratore di Maria de Aragona, duchessa di Montalto, presentava in Regia Camera della Sommaria il “Relevio”. Allora la terra di San Maurello era parte della Baronia di Pietrapaola, che comprendeva Pietra Paula, S.to Maurello, Caloviti, Cropalati e Crosia. Il relevio per quanto riguarda la terra di San Morello, evidenzia un aumento più del doppio delle entrate feudali, soprattutto per il forte aumento del gettito del fitto dei terreni a pascolo, o erbaggio,[xxxvi] mentre diminuisce la rendita di quelli concessi a semina, condizionati dai raccolti incerti e dalla scarsità della manodopera.[xxxvii]
Il feudo
Per tutto il Medioevo e nell’età moderna gli abitanti del casale di San Maurello dovettero sopportare oltre al potere economico esercitato dagli abati del Patire e dai loro procuratori anche quello dei feudatari e dei loro erari. Durante questo lungo periodo il feudo di San Morello dapprima fece parte della contea di Cariati, poi della baronia di Pietrapaola e quindi passò da barone in barone. Essendo un piccolo feudo, parte della baronia di Pietra Paola, spesso gli intestatori della baronia, sempre alla ricerca di denaro, lo vendettero con patto di ricompra. Questo continuo passaggio da barone a barone e la precarietà del possesso, in quanto soggetto al patto di ricompra, spingeva il barone del momento a sfruttare quanto più gli era possibile il territorio e gli abitanti del casale. Il succedersi di annate scarse e delle epidemie e gli aggravi fiscali e baronali determinarono il fenomeno dello spopolamento del feudo, che in certi anni portò San Maurello quasi all’estinzione. La mancanza di braccia, per aprire le terre, determinò l’estensione dell’incolto e l’aumento del pascolo a scapito della semina.

Panorama da S. Morello (da Panoramio).
I baroni
Nel 1305 Gentile di San Giorgio “hebbe in Capitanata S. Nicandro col feudo di Brancia, e in Calabria anche Cariati, Casabuono, Motta, Scala, S. Maurello, Lensaco Vecchio, Francavilla, Vertini (Verzino), Scarpizzati, con i feudi di Terentia (Cerenzia), di Cacuzzio (Caccuri), e di Rossano.
Seguì Petruccio de Sus e poi la figlia Thomasella de Sus. Morta senza figli nel 1333, “lo stato suo ricaduto alla Corona fu da re Roberto conceduto alla regina Sancia”.[xxxviii] Seguirono Polissena Ruffo, Contessa di Montalto, figlia primogenita del conte Carlo (1407), Covella Ruffo, contessa di Montalto, Marino Marzano Ruffo, principe di Rossano e Conte di Montalto, (1445-1464).
Quest’ultimo ebbe confiscati i feudi dal re Ferrante e San Morello andò a far parte della Baronia di Pietrapaola.
Nel 1471 era signore della baronia Tomaso Guindazzo. Indi spogliatone l’anno 1473 ricerca d’esserne reintegrato con tutta la sua baronia.[xxxix] Seguono Diego Cavaniglia (1472) e Ferdinando D’Aragona (fine sec. XV). Nel 1507 il contado di Caiazzo fu restituito a Roberto Ambrogio Sanseverino e in cambio, fu data a Ferdinando d’Aragona la terra di Montalto, nonché la baronia di Pietrapaola e i feudi di San Morello, Casalvono, Crosia, Cropalati e la dogana del pesce delle città di Reggio.
Poi San Morello fu concesso con patto di ricompra a Mariano Abenante. Il 2 luglio 1525 il capitano delle armi di Crotone riceveva ordine dal Vicerè di reintegrare il rossanese Mariano Abenante nel possesso delle terre di Casabona e di San Morello, che si erano ribellate alla Regia Corte, per istigazione di Scipione e Diomede Antinoro. Quindi ritorno a Ferdinando D’Aragona, primo duca di Montalto (morto il 23 luglio 1543) poi passò ad Antonio D’Aragona (morto il 6 ottobre 1543) e successivamente a Pietro D’Aragona (morto il 19 aprile 1552 e a Antonio D’Aragona (morto l’8 febbraio 1583).
Sul cadere del secolo xvi e per un breve periodo, Pietrapaola e San Morello appartennero alla famiglia Vollaro. Ed infatti Paolo Vollaro – quale figlio ed erede del fu Lorenzo (deceduto il 24 marzo 1584), che le aveva acquistate col patto di retrovendita dal duca di Montalto, il 27 marzo 1585 ebbe significatoria di relevio per le terre di Pietrapaola e San Morello. Il patto di ricompra fu però esercitato.[xl]
Maria D’Aragona, 5.a duchessa di Montalto, il 6 settembre 1586 ebbe significatoria di rilevio per lo stato di Montalto, con Pietrapaola e San Morello, Cropalati, Crosia e Caloveto come erede del duca di Montalto Antonio d’Aragona suo padre deceduto l’8 febbraio 1583, e vendette Pietrapaola e San Morello a Fabio Alimena con regio assenso del 1609.
Fabio Alimena, barone di Poligroni e Marri comprò le terre di Pietrapaola e San morello per il prezzo di 40.000 ducati. Nel 1620 è feudatario Francesco Maria Caligiuri.[xli] Scipione Migliarese comprò il feudo di San Morello e ne divenne barone, seguì il figlio Diego che, nel 1680, risulta barone di San Maurello.[xlii]
Alla fine del Seicento secondo il Fiore “S. Maurello va unito allo stato di Umbriatico del marchese Rovegno.[xliii] Poi passò dai Coscinelli al monastero di Santa Teresa d’Avila dei Carmelitani Scalzi di Cosenza: “Terra S. Maurelli manet sub dominio temporali Vblis Monasterii Sanctae Theresiae Civitatis Consentiae ex legato facto a q.m Cajetano Cusinelli”.[xliv]
Seguì Antonio Ferrigno (1737) e nel 1760, gli Abenante acquistarono il feudo.[xlv] Successivamente decadde in mano al fisco regio,[xlvi] poi pervenne ad Emanuele Abenante.[xlvii] (47)

Panorama da S. Morello (da Panoramio).
Il vescovo di Cariati
Tra i diritti del vescovo vi era quello di decima su tutti gli animali forestieri, che pascolavano nel territorio della terra di San Morello. Questo antico diritto fu contrastato dai frati Carmelitani Scalzi del convento di Santa Teresa d’Avila di Cosenza che, all’inizio del Settecento, per un legato fatto dal barone Gaetano Coscinelli, cominciarono ad esercitarvi la giurisdizione baronale, amministrando la giustizia ed ogni altro diritto secolare.
Fin da subito divampò la lite tra il vescovo di Cariati ed i frati, sul modo e su quali animali il vescovo poteva riscuotere la decima. Dopo che molte controversie e minacce avevano avvelenato il rapporto tra il vescovo Gio. Andrea Tria (1720-1726) ed i frati, il nuovo vescovo Marcantonio Raimondi (1726-1732) decise, previo assenso apostolico, di porre fine alle liti e di accordarsi, così in cambio di trentatré ducati annui, concesse ai frati in perpetuo il diritto di decima.[xlviii] Ma le liti non erano sopite e ripresero con l’insediamento del successore, il napoletano Carlo Ronchi, il quale mal sopportò l’invadenza dei frati e si adoperò affinché cessasse la loro giurisdizione baronale su Santo Maurello. Fu ottenuto l’assenso dalla Sacra Congregazione dei Vescovi e dei Regolari ed i frati furono costretti a mettere all’asta il feudo.[xlix]
Note
[i] Alfano G. M., Istorica Descrizione del regno di Napoli, Napoli 1823, p. 178.
[ii] Trinchera F., Syllabus Graecarum Membranarum, p. 139.
[iii] Amari M. – Schiaparelli C., L’Italia descritta nel “Libro del re Ruggero”, Roma 1883, p. 112.
[iv] Russo F., Regesto, 5253, 5293.
[v] Gradilone A., Storia di Rossano, pp. 205-207.
[vi] Russo F., Regesto, 5293.
[vii] 17 luglio 1509. “Giulio II. Terentin. Et Sipontin. Archiep.is et episcopo Anconitan. Iohanni Palaminuta, pbro Rossanen., scriptori Ro. Cu. et familiari suo, providetur de parochiali ecclesia, archipresbyteratu nuncupato, S. Nicolai, terrae S. Maurelli, Cariaten. dioc., c. m. vac., amoto Iohanne Canterisano, qui se gerit pro clerico et, nullo canonico titulo suffragante, eam tenet occupatam”. Russo F., Regesto, 15273.
[viii] 24.11.1544. “Paolo III, Thomae Cardamusto, familiari suo, providetur de perpetuo beneficio, archipresbyteratu nuncupato, in ecclesia S. Nicolai, loci Sancto Maurello, Cariaten. et Geruntin. Dioc. vac. Per ob. Bartholomaei Lombardi”, Russo F., Regesto, 18886.
[ix] 22.3.1545. “Raimundo de Natalibus, clerico cassanen., familiari suo, provideat de parochiali ecclesia, archipresbyteratu nuncupato, S. Nicolai, castri S. Maurelli, vac. Per ob. Batholomaei de Narenta”. Russo F., Regesto, 18936.
[x] 15.5.1560. “Leonardo Leto, clerico Cusentin., providetur de parochiali ecclesia, archipresbyteratu nuncupato, S. Nicolai, loci S. Maurelli, vac. per ob. Laurentii de Natalibus”. Russo F., Regesto, 20801.
[xi] 31.5.1560. “Pio IV. Bernardo Medici de terra Scala, Cariaten dioc., et Leonardo de Bono, Terrae Apriliani, Cusentin. Dioc., archipresbyteris, nec non Vincentio Gargano, canonico ecclesiae Bellicastren., mandatur ut capiant possessionem, nomine Camerae aplicae, parochialis ecclesiae, archipresbyteratus nuncupati, S. Nicolai seu Nicolae, loci S. Maurelli, Cariaten. dioc., collatae, per ob. Rainutii seu Laurentii de Natalibus, Leonardo Leto, clerico Cusentin.”. Russo F., Regesto, 20803.
[xii] Liguori R. – Liguori F., Cariati nella storia, Cirò Marina 1981, p. 192.
[xiii] 13.1.1615. “Pro confraternitate SS. Corporis Christi, in parochiali ecclesia, archipresbyteratu nuncupato, S. Nicolai, casalis S. Maurelli, Cariaten. dioc., indulgentia in festo Corporis Christi et Natalis Domini et BMV et Annuntiationis et Conceptionis BMV, Russo F., Regesto, 27498.
[xiv]ASV, SCC. Rel. Lim. Cariaten. et Geruntin., 1605, 1612.
[xv] “Il luogho detto S.to Maurello che farà da 300 anime governate da un Arciprete senza Monasterii di frati” (ASV, SCC. Rel Lim. Cariaten. et Geruntin. 1621). “Habet haec Cariaten dioecesis Terram Scalar. Animar. fere duor. Millium, et duo oppida Terrae Veteres animar. fere 500, et Santi Maurelli fere 500” (ASV, SCC. Rel. Lim. Cariaten. et Geruntin. 1631).
[xvi] 7 aprile 1649. “Antonio de Ascensio providetur de parochiali ecclesia, archipresbyteratu nuncupato, S. Nicolai, loci S. Maurelli, Cariaten. dioc., vac. per ob Ioanni Perella, de mense Ianuarii ex Ro. Cu. Def.”. Russo F., Regesto, 35731.
[xvii] “In oppidulo Sancti Maurelli cura animarum per perpetuum Rectorem laudabiliter exercetur” (ASV, SCC. Rel. Lim. Cariaten. Geruntin. 1666). “In Santi Maurelli oppido cura per perpetuum Rectorem, qui Archipresbyter est nuncupatus, exercetur” (ASV, SCC. Cariaten. et Geruntin. 1673).
[xviii] “In oppidis Terrae Veteris, et S. Maurelli, Parochiales seu Matrices Ecclesias vetustate collapsas, et egestate Parochorum, et Populi restaurari nequeuntes, duobus ab hinc annis reedificandas accepi et Divina gra. Adiuvante, spero illas brevi me perfecturum et absoluturum” (ASV, SCC. Rel. Lim. Cariaten. et Geruntin. 1682).
[xix] “In oppidis Terrae Veteri et S. Maurello parochiales, seu Matrices Eccl.ae vetustate pene collapse sunt et egestate Parochorum, et Populi, restaurari nequeunt. Quinque ab hinc annis illas reedificandas coepi et divina adiuvante gratia spero illas proprio aere, me perfecturum” (ASV, SCC. Rel. Lim. Cariaten. et Geruntin. 1685).
[xx] “In oppidis Terreveteris et S. Maurello Parochiales, seu Matrices Eccl.ae vetustate pene collapsae erant, et egestate Parochorum et Populi restaurari nequibant nunc vero divina adiuvante gra. Terreveteris cum perplurimis meis laboribus vigiliis industria, et sumptibus denuo reedificata est, alia S. Maurelli stat in fabrica, et quam primum spero esse completam” (ASV, SCC. Rel. Lim. Cariaten. et Geruntin. 1687).
[xxi] “In castro Sancti Maurelli Cariaten. Diocesis per obitum q.m D. Onophri de Accursio secutum in mense Aprilis Anni 1689 Ecclesia Archipresbyteralis reperitur sine curato … exercetur per Aeconomos, qui cum difficultate inveniuntur, et nemo repertus fuit qui provideri vellet de beneficiis praedictis pro non faciendis in Dataria Apostolica expensis Bullarum quia redditus et proventus cuiuslibet Beneficii, non ascendunt ad ducatos decem monetae Regni Neapolis. Suppliciter propterea petitur pro bona Sacramentorum administrationem et ne dicatur filii petierunt panem et non erat qui franceret eis, ut EE. VV. dignentur provisionem victorum beneficiorum cum expeditione Bullarum Ordinario loci committere et mandare” (ASV, SCC. Rel. Lim. Cariaten et Geruntin. 1693).
[xxii] “In pago S. Maurelli, ad praesens per Oeconomum ad nutum amovibilem, dum ecclesia pluribus ad hinc annis caret suo Rectore et nemo ob paupertatem Ecclesiae comparuit pro illa obtinenda. In primo anno mei Praesulatus, ecclesia Matrix, sub titulo S. Nicolai Baren. Eiusdem oppidi, erat collapsa, et sacramenta, et sacramentalia conservabantur et administrabantur in parva ecclesia sub titulo SS.mae Annunciationis, a me ecclesia matrix fuit restaurata et redacta ad formam decentem, in qua ad praesens conservantur sacramenta et sacramentalia, et sacramenta administrantur.” (ASV, SCC. Rel. Lim. Cariaten. et Geruntin.1698).
[xxiii] “In castro S. Maurelli à tribus annis vacavit, et vacat Archipresbyteratus, quia nemo comparuit prò illo impetrando prò non faciendis expensis Bullarum et e.po opus est laborare prò inveniendis oeconomis qui curam Animarum habeant” (ASV, SCC. Rel. Lim. Cariaten. et Geruntin. 1707). “In Terra S. Maurelli, à sex annis vacavit, et vacat Archipresbyteratus quia nemo comparuit prò illo impetrando prò non faciendis expensis Bullarum et e.po opus est laborare prò inveniendis oeconomis qui curam Animarum habeant” (ASV, SCC. Rel. Lim. Cariaten. et Geruntin. 1710).
[xxiv] 22 novembre 1714. “Vicario Generali archiep.i S. Severinae. Als de parochiali ecclesia, archipresbyteratu nuncupato, Castri S. Maurelli provisum fuit Vincentio Leonardo, pbro Cariaten., per ob. Parisii de Parisio de mense Maii 1703 def., cum mandato Vicario Generali ep.i Cariaten. de executione, sed interea ep.us Cariaten. e vivis sublatus est, propterea mandatus dicto Vicario archiep.i S. Severinae ut dictam provisionem executioni mandat”. Russo F, Regesto 52602.
[xxv] Liguori F. – Liguori F., Cariati cit., p. 215.
[xxvi] “Cura animarum exercetur per Archipresbyterum in ecclesia Parrochiali sub titulo S. Nicolai, animae habitantes sunt biscentum, adest unus sacerdos, et unus clericus ultra Archipresbyterm”. ASV, SCC. Rel. Lim. Cariaten. et Geruntin. 1733.
[xxvii] 17 marzo 1747. “Mgro Iosepho Simonetti, US Ref., et Hieronimo Malatacca Campana, canonico ecclesiae Cariaten., ac Vicario in Civ. et dioc. Cariaten. auctoritate aplca deputato, mandat ut Philippo Talarico, pbro Rossanen. Dioc., provideant de parochiali … S. Nicolai Terrae S. Maurelli cuius fructus 13 duc., vac. per ob Donati Diacono, ab anno et ultra def.”. Russo F., Regesto, 61457.
[xxviii] Settembre 1790. “De parochiali, archipresbyteratu nuncupato, terrae S. Maurelli, Cariaten. Dioc., cuius fructus 24 duc., vac. per ob. Philippi Talarico, de mense octobris 1787 def., providetur Caietano Talarico, pbro oriundo, in concursu, unico comparente, approbato.” Russo F., Regesto 68244.
[xxix] Pedio T., Un foculario del Regno di Napoli del 1521, in Studi Storici Meridionali, n. 3/1991, p. 263.
[xxx] Giustiniani L., Dizionario Geografico – Ragionato del Regno di Napoli, Napoli 1804, T. VIII, p. 324.
[xxxi] S. Maurello (1544): Li pagamenti fiscali 45 – 1 – 10. Le entrate de detta terra 7 – 3 – 0. Lo herbagio et prato de d.ta t.ra 45 – 0 – 0. Li Censi 12 – 0 – 0. (tot.) 109 – 4 – 10. ASN. R.C.S. Relevi, b. 355, f. 567. “Relevio del qm Don Vincenzo Ruffo delo Sciglio denun.to per Nardo Mirante procuratore de Donna Gioanna Ruffa Baronessa de Fiumara de Muro Calanna Città di S.ta Severina Melicuccà et Petra paula.”
[xxxii] In p.is Paga d.ta univ.ta de S.to Marello alla duc.le Corte per li pagamenti fiscali quolibet anno ducati quaranta cinque tari uno et gr. dece. ASN. R.C.S. Relevi, b. 355, f. 567.
[xxxiii] Item ce et uno territorio et prato de l’herbagio che fo venduto lo anno paxato innanti che morì per lo S.r duca a ber.no scigliano de ditta motta ducati quaranta cinque et lo anno proximo paxato fo venduto allo midisimo per lo predetto prezo et in lo presente anno fo venduto ad vittorio napparo di li casali di cosenza per li ditti quaranta cinque ducati. ASN. R.C.S. Relevi, b. 355, f. 567.
[xxxiv] Item per la bagliva di dicta t.ra seu motta fo venduta lo anno pax.to p.ae Ind.s ad carlo risoleo per ducati otto et in lo p.nti anno simil.ter et stata venduto ducati ottobre. ASN. R.C.S. Relevi, b. 355, f. 567.
[xxxv] Item ci sono certi renditi et censuali quali exigi lo baglivo ordinario per la ducali corte che sono ducati nove lo anno et altre entrati non sape ipozo che nce siano perche li t.ragi de santo maurello si exigino con li t.ragi de petra paula.
[xxxvi] Tra i corpi e entrate feudali e burgensatici di Pietrapaola e San Maurello vi è “l’herbaggio del curso del prato nel territorio di S.to Maurello, confina con lo territorio di Cariati p.p.o detto lo vallone delli torrelli lo lito del mare la fiumarella del arso con lo territorio della Scalea in loco detto l’acqua ramata et S.to Jo.e con la difesa de palumbo della città di Cariati …”. ASN. R.C.S. Relevi, b. 355, f. 567.
[xxxvii] Lo curso de S.to Maurello sta affittato. Duc. 180; Bagliva di S.to Maurello Duc. 42; Mastro d’Attia di S. Maurello duc. 20; Li terraggi di Pietrapaula e S.to Maurello de fertile ed infertile grano tt.a venticinque. (circa tt.a 10 S. Maurello), ASN. R.C.S. Relevi, b. 355, f. 567.
[xxxviii] Ferrante della Marra, Discorsi delle famiglie estinte, forestiere ecc., Napoli 1641, p. 363 e sgg. Maone P. La Contea di Cariati, ASCL (1963), Fasc. III-IV.
[xxxix] Fiore G., Della Calabria Illustrata I, p. 236.
[xl] Pellicano Castagna M., Storia dei feudi cit., Vol. IV, pp. 76 e sgg.
[xli] Mazzoleni J., Fonti cit. p. 22.
[xlii] Valente G., La Sila dalla transazione alla riforma, Rossano 1990, p. 342.
[xliii] Fiore G., Della Calabria Illustrata I, 236.
[xliv] ASV, SCC. Rel. Lim. Cariaten. 1725.
[xlv]“T.ra S. Maurelli, in qua 182 sunt animae, et Reggio Fisco subjacet, ut dictum. Adest Eccl.a Archipresb. Cum duobus sacerdotibus, duobus Diaconis, et uno clerico … T.ra Vertinar. Et Sabellor., qua de familia Cortese in manus Regii Fischi pervenerunt, una cum t.ra S. Maurelli alterius meae Dioecesis ob rebellionem in Principem …”. ASV, SCC. Rel. Lim. Cariaten., 1769. Covino L., Governare il feudo, Franco Angeli 2013, pp. 112, 124.
[xlvi] “T.ra S. Maurelli, in qua 182 sunt animae, et Reggio Fisco subjacet, ut dictum. Adest Eccl.a Archipresb. Cum duobus sacerdotibus, duobus Diaconis, et uno clerico …T.ra Vertinar. Et Sabellor., qua de familia Cort … “, ASV, SCC. Rel. Lim. Cariaten., 1769.
[xlvii] Emanuele Abenante alla fine del Settecento era barone di Monasterace e di San Morello, Gradilone A., Storia di Rossano, Cosenza 2009, p. 596. “Emanuele Abenante nel 1799 aderì alla Repubblica sicchè, come reo di stato, subì la confisca dei suoi beni. Assunse però nuovamente posizione di spicco durante il decennio francese.” De Rosis, cit., p. 312.
[xlviii] “Iter jura quibus haec Mensa fruitur adest illud decimandi super animalibus pascua sumentibus in territorio Terrae Sancti Maurelli huius Dioecesis Cariaten., ad praesens de dominio, et possessione Fratrum Discalceatorum Sanctae Theresiae (), super quo, et de praeterito, et de praesenti controversiae erant, circa modum decimandi, et super quibus animalibus potuerat decimari, itaut, et Episcopi mei Praedecessores, et egomet in litibus et jurgiis scandalosis involvebantur tandem ad huiusmodi obvianda praevio Assensu Apostolico, Fratribus praedictis pro annua summa ducatorum triginta trium contractu perpetuae locationis, seu transactionis concessi, et sic animi tranquillitatem et quietem pro me, et successoribus meis adeptus sum”. ASV, SCC. Rel. Lim. Cariaten. Kalendis Octobris 1731.
[xlix] “Terra S. Maurelli manet sub dominio temporali Vblis Monasterii Sanctae Theresiae Civitatis Consentiae ex legato facto a q.m Cajetano Cusinelli, solet in Palatio Baronali residere sacerdos religiosus, qui baronalem jurisdictionem exercet, justitiam ministrando, et omnia alia soecularia tractando magno cum dedecore habitus, et instituti. Hinc zelotes religionis Patres ad tollendam talem scandali occasionem supplices porrexerunt praeces Sacrae Congregationi Episcoporum, et Regularium negotiis praepositae prò obtinendo Apostolicoi assensu ad effectum alienandi feudum praedictum, qui quidem impetrarunt, et jam in diversis locis huius Provinciae fuerunt affixa edicta de subhastationibus faciendis.” ASV, SCC. Rel. Lim. Cariaten., 1 aprile 1733.
The post San Maurello poi San Morello. Un piccolo paese, una lunga storia appeared first on Archivio Storico Crotone.
Maestri di musica e discepoli nel Crotonese (sec. XVI-XVIII)

Strongoli (KR), suonatore di fisarmonica in un momento di pausa durante la festa.
In quanto “attività strettamente correlata ai bisogni dell’esistenza”,[i] legata alla esigenza espressiva dell’uomo ed alla sua socialità, la musica ha accompagnato la vita delle popolazioni fin dall’antichità e, per quanto riguarda questa dimensione privata, al pari di altre arti, è stata tramandata localmente dalla tradizione popolare.
Per quanto riguarda invece, il ruolo della musica nella dimensione pubblica, il consolidamento in età medievale, di un clero che stabilì e fissò, sempre più rigidamente, i canoni del culto religioso, favorì, all’interno della propria struttura sociale, la selezione di una musica funzionale a tale scopo, in quanto strumento utile a regolare ed ordinare la vita del singolo nella comunità.
Una liturgia medievale
Fin dal Medioevo, il “vasto repertorio vocale gregoriano, perlopiù anonimo”, rappresentò un elemento fondamentale della liturgia, ovvero, come affermano alcuni, andò a costituire la “liturgia stessa”,[ii] intendendo con questo termine l’insieme delle preghiere e dei riti che, a quel tempo, appartenevano al culto della religione cristiana.
La centralità di tale aspetto e la sua importanza nella struttura sociale delle comunità monastiche medievali, ci è segnalata dalla presenza del “cantore” tra le dignità che costituivano il capitolo cattedrale, figura principale alla quale, in origine, possiamo ricondurre il governo e la trasmissione del sapere musicale fissato nel canto, all’interno della comunità ecclesiastica stessa.
Nel territorio crotonese, di antica tradizione bizantina, l’introduzione del canto gregoriano nella celebrazione liturgica, può essere ricondotta ad un periodo successivo alla conquista normanna (metà del sec. XI), quando il passaggio al rito latino degli antichi monasteri greci, oltre all’assoggettamento economico e politico, impose loro anche un rapido adeguamento ai nuovi modelli sociali della chiesa occidentale, a cominciare dall’adozione del canto gregoriano nell’ambito liturgico che prevedeva solo l’uso della lingua latina.
Non stupisce quindi, ad esempio che, tra i beni dati in permuta dal monastero di “Sancti Ioannis de Flore” a quello greco di “Calabromariae”, elencati in un atto dell’ottobre 1216, subito dopo che quest’ultimo era passato al rito latino ed all’obbedienza dell’ordine florense, risultino messi in evidenza i libri liturgici destinati al coro dell’antica comunità monastica, incardinata nella nuova regola: “Missale, Evangelistarum, Epistolarum, Gradale collectaneum, Breviaria duo, Dominicale unum et unum de via, Antifonarium in duo volumina, Hynnarium, Volumen quatuor Evangelistarum, Epiostolae Sancti Pauli glosatae, Actus Apostolorum, Volumen exceptionis moralium, Psalteria duo et Passionale de lictera longobarda”.[iii]

Il clero che canta il divinum officium in una miniatura (da traditionundglauben.com).
Tutti in coro
Oltre a rappresentare uno strumento regolatore ad uso interno della comunità ecclesiastica, il canto gregoriano ebbe anche una importante valenza all’esterno di essa, nei confronti della popolazione urbana o rurale subalterna.
Accanto a quello che accompagnava la messa, il canto prorompente dalle chiese durante la liturgia delle ore, infatti, fu lo strumento attraverso cui (assieme alla campana), i monaci e i clerici potevano raggiungere la popolazione del luogo nelle proprie case raccolte attorno alle chiese, vere e proprie casse armoniche che, amplificandola, davano più forza e vigore alla voce della comunità ecclesiastica, scandendo così il tempo durante l’arco della giornata, in maniera da ribadire il suo ruolo guida di classe dominante.
In relazione a tale particolare funzione, volendo perseguire questo obiettivo, durante la sua visita ai luoghi pii di Santa Severina, iniziata il 15 maggio 1559, il cantore della chiesa di Mileto Giovanni Tommaso Cerasia, vicario generale dell’arcivescovo Giovanni Battista Ursino, raccomandò e prescrisse a tutti gli ecclesiastici della cattedrale che, evidentemente, sonnecchiavano, di cantare ogni giorno l’ufficio della prima ora nel coro, con “alta et intelligibili voce ad modum lectionis Martirologium”.
A quel tempo, la trascuratezza del clero locale a riguardo di questo aspetto, era evidenziata anche dallo stato del coro della cattedrale, che il vicario trovò “in aliquibus locis dirutum”, ordinando subito di provvedere ai rifacimenti necessari, e disponendo di riorganizzare la sua struttura affinchè, in luogo del “discolum magnum” e del “chorum parvum seu discolum” nel quale si cantavano “lechtiones et epistole”, fossero realizzati due cori piccoli, in maniera che potessero essere cantati i salmi secondo le consuetudini di Santa Romana Chiesa.
Sempre da notizie della seconda metà del Cinquecento, sappiamo che la “cappella” della cattedrale accompagnava le funzioni con la musica “in canto figurato”[iv] nelle festività ed in occasione delle principali ricorrenze, cantando ordinariamente “a due chori” e nelle solennità maggiori “a quattro”, ai quali non erano ammessi laici “né a sonare, né a cantare”, in quanto la maggior parte del clero di Santa Severina era “di questa professione molto bene intendente”.[v]

Isola di Capo Rizzuto (KR). Particolare degli stalli del coro della ex cattedrale.
I libri
Come era consuetudine, anche nella cattedrale di Santa Severina, i libri necessari ad eseguire i canti liturgici erano riposti all’interno del “discolum magnum in choro” dove, alla metà del Cinquecento, risultavano: due “gradualia” uno in pergamena e l’altro simile “dominicale et aliud sanctorum”, due “antifonarios in carta regale unum dominicale et aliud sanctorum”, un altro antifonario piccolo in pergamena “dominicale et sanctorum”, due “psalteria” di carta, due “breviaria”, un “martirologium”, due “missalia” di carta, tre “missalia” in pergamena, un “breviarium” in pergamena, quattro “psalmisti” in pergamena, un altro “psalterium” in pergamena e tre “breviaria” in pergamena vecchissimi.
I “missalia” in pergamena, oppure in carta “banbacina”, alcune volte definiti grandi, altre volte vecchi, oppure antichi, compaiono ricorrentemente anche nell’inventario nei numerosi altari della cattedrale dove, in alcuni casi, risulta anche il “manuale” in pergamena oppure a stampa.
In questo periodo, questi libri si ritrovano anche nelle altre chiese della città, dove, a volte, risultano inventariati il “graduale” o l’“antifonarum”, ma anche, il più semplice “quaternum” di canti per la messa e similmente, in quelle di tutta la provincia ecclesiastica.
Lo riscontriamo a Policastro dove, nella “capp.la mag.a” della chiesa matrice di San Nicola della Piazza, esisteva un “chorum” con “aliquibus scannis”, privo però del “discolum” dove poter riporre i “libri” per i canti, per cui fu ordinato che si realizzasse un “discolum ut honorificae possunt Cantari divinia off.a”. A quel tempo nella chiesa si conservavano un “antifonarium pergamilis parvum”, un “bactisterium pergamilis”, un “graduali” ed un “antifonarium festivum”.
Anche la “Matrem ecc.am parrocchialem sub invocatione S.ti Nic.ai delo Casale” di Mesoraca evidenziava una situazione simile. Qui, infatti, esistevano solo alcuni scanni per sedersi disposti “ad modum chori” e nella chiesa si conservavano un “graduale in pergamino veterrimum” ed un “antifonarium”, per cui fu ordinato di acquistare un graduale, due “missalia in carta” ed uno “in Coiro”.
Un “discolum veterrimum” costituito da “scanna de pet.a Cum tabulis sup.a”, si trovava invece nella chiesa arcipretale di Cutro dedicata a San Giuliano, mentre, nella chiesa maggiore della terra di Verzino, dedicata a Santa Maria, esisteva un “discolo” nel quale si conservava un graduale festivo e domenicale in carta bambacina.
Anche la cattedrale di Cerenzia denotava questa situazione esigua e trascurata. “In medio dictae ecc.ae”, che “habet duas Alas in modo antiquo”, esisteva un “chorum ligneo”, ma “in disculo” non vi erano libri. Essa possedeva solo un “missale” ed un “graduale”, mentre decisamente migliore era la situazione della cattedrale di Umbriatico, che possedeva quattro “missali”, di cui due “magnos”, un “pontificale”, due “gradualia” e un “Antiphonario” festivo e domenicale.[vi]
Di tutto rispetto risultava invece in questo periodo (1571), la dotazione del monastero di San Giovanni in Fiore, che conservava ancora antichi volumi manoscritti appartenuti al coro dell’antica abbazia florense.
Da un inventario compilato al tempo dell’arcivescovo di Santa Severina Giulio Antonio Santoro, apprendiamo che, oltre ai numerosi “libri” antichi “in carta pergamena” conservati nel monastero, si trovavano anche dei “libri Ecl(esiati)ci choristi”: “uno graduale grande stampato Curiale seu modum romane Curie”, “un missale de l’ordine”, “unaltro missale piccolo gallicanum jux.a usum ecl(esi)e cosentine”, “uno graduale vecchio de’ lordine”, “un libro di evangelio [ve]cchio”, “uno libro dep(isto)le di san paulo vecchio”, “uno [gradu]ale vecchio s(ecun)do l’ordine”, “uno collectario scritto a mano in carta pergamena”, “unaltro collectario vecchio scritto a mano de pergamili”, “uno martirilogio Innavo vecchio” e “processionale uno vecchio senza principio et fine”.[vii]


Fogli di canto gregoriano in pergamena appartenenti ad un libro liturgico medievale della cattedrale di Crotone, caratterizzati dall’uso del tetragramma (rigo musicale a quattro linee) e da segni grafici (neumi) di una, due, tre o più note. ASN, Dip. Della Sommaria Fs. 315, Mensa Vescovile di Crotone 1572-73.
Una musica profana
Rispetto al canto gregoriano, creato espressamente in relazione alla liturgia, più scarsa è la documentazione che ci fornisce informazioni circa l’esercizio dell’arte musicale in ambiti diversi dal contesto sacro. Determina ciò la natura dei documenti in nostro possesso, in larga parte provenienti dall’ambito ecclesiastico, mentre anche i protocolli notarili escludono molto circa la sfera privata della persona, dove la musica doveva continuare ad avere quel ruolo importante che, da sempre, accompagna la vita dell’uomo. In particolare nell’ambito pastorale dove, ancora oggi, si concentra quel che resta della tradizione musicale calabrese, accanto all’uso degli antichi strumenti (pipita, tamburo, zampogna, lira, ecc.).
Non sembra quindi casuale che uno dei pochi documenti di cui disponiamo che c’illustra questa realtà, provenga dall’area dei “Casali di Cosenza”, dove la principale attività della popolazione era la pastorizia, che i casalesi cosentini praticavano nel loro andirivieni stagionale, tra l’altipiano silano e le pianure del Crotonese.

Suonatori ambulanti per le strade di Lungro (CS).

Flauti. Museo Calabrese di Etnografia e Folklore Raffaele Corso di Palmi (RC).
L’apprendistato di Filippo Sisca
Il 3 aprile 1537 in Cosenza, davanti giudice a contratto Marco de Tuchio, al notaro Napoli de Machia e ad alcuni testi, si costituivano il maestro (“mastro”) Jacobo Rispoldi di Cosenza da una parte, e Filippo Sisca “de fillino” dall’altra.
Quest’ultimo, impegnandosi per tre anni, a partire dal giorno successivo alla stipula del presente contratto, “se acconcza per descipulo” con il predetto maestro Jacobo, promettendo di servirlo “bonamente, lealmente et fidelmente in tucti servitii”, convenienti e spettanti a detto Filippo, e stabilendo che, durante questi tre anni, “non se possa insurare senza licentia” del detto maestro, di suo fratello Francesco e del suo “compagno” Berardino Tosto, con la promessa che “non se habea da partire per dicto tempo”, rimanendo soggetto, in caso contrario, al pagamento di “tucti i danni spise et interesse”.
Dalla sua parte, il maestro prometteva di “imparare lo p.to Filippo tanto de sonare lo bucta foco tamburro et frauto tanto de Cano como de tenore Como anco de ballare et donarli tucte bascie balli et adancze sincomo se convene da m.ro ad desciputo”, ed al fine dei tre anni “Cacchiarelo m.ro che possa tenire scola et imparare descipuli Como convene alli m.ri de dicta arte”.
Il contratto prevedeva che, durante i primi due anni, quando il futuro discepolo si sarebbe dovuto dedicare solo ad apprendere l’arte necessaria al suo futuro mestiere, il detto maestro si sarebbe impegnato nei suoi confronti a “dareli de magnare et calczare deli pedi et fareli Camise”, mentre, al terzo anno, una volta iniziato a suonare, avrebbe provveduto a “donareli la tercza parte de quello guadagneranno con dicta arte”, ma sia tenuto detto Filippo, “faresi le spise”.
Durante quest’ultimo anno, egli avrebbe dovuto servire il suo maestro, “et andare ad sonare in omne parte che lo mandera”, “tanto sulo Come accompagnato”, mentre, alla fine dei tre anni di contratto, dovendo egli ormai comparire convenientemente in pubblico in maniera indipendente, il maestro s’impegnava nei suoi confronti, a “fareli una Cappa” del valore massimo di venti Carlini ed “uno paro de Calczi”,[viii] gli elementi di vestiario che attestavano il raggiungimento del suo nuovo status.

Cattedrale di Matera. La statuina del pastore che suona la zampogna nel presepe di Altobello Persio e Sannazzaro di Alessano (1534).

Zampogna. Museo Calabrese di Etnografia e Folklore Raffaele Corso di Palmi (RC).
Gli strumenti della festa
Questo contratto, oltre ad informarci circa le condizioni e gli usi che regolavano il rapporto tra maestro e discepolo durante la prima metà del Cinquecento, ci permette di fare luce anche su altri aspetti relativi all’esercizio dell’arte musicale durante le feste in questo periodo.
In primo luogo ci riferisce esplicitamente che quanti suonavano per mestiere in occasione delle ricorrenze, erano organizzati in un gruppo con regole e gerarchie precise, in cui era possibile tanto apprendere canti e balli che si svolgevano in queste occasioni, tanto imparare a suonare tutti gli strumenti che li accompagnavano: il flauto, il buttafuoco e, in particolare, il “tamburro”, suonato usualmente da gruppi di “tamborinari” o “Tumbarinari” che, accompagnati dal suono del “bifaro” (flauto bicalamo)[ix] e facendo a gara tra di loro, percuotevano di continuo i loro “tamburri” o “Tamburre”, come risulta ben documentato durante la seconda metà del Settecento, in occasione della festa di Sant’Anna presso Crotone, da un documento dove, annualmente, per il periodo di un quarantennio, risultano annotati i denari pagati (“Rigalati”) ai suonatori.[x]
Ritroviamo insieme questi strumenti anche in una famosa rappresentazione coeva al nostro documento, esistente nella cattedrale di Matera, dove tutti e tre sono utilizzati da due musici raffigurati vicino alla natività del presepe c.d. di Altobello Persio e Sannazzaro di Alessano (1534).
In questa antica rappresentazione che, in relazione al suo contesto, possiamo considerare a tutti gli effetti illustrativa di una scena reale di questo periodo, si vede uno di questi musici che, mentre suona con la sinistra un lungo flauto ad una mano, con la destra tiene l’archetto del suo buttafuoco: una cetra rettangolare a quattro corde, assicurata alla sua spalla sinistra attraverso una cinghia.

Cattedrale di Matera. Le statuine dei musici nel presepe di Altobello Persio e Sannazzaro di Alessano (1534).
Considerata l’analogia con la situazione illustrata dal nostro documento, possiamo ritenere che questi tre strumenti, possano essere considerati una combinazione consolidata per eseguire le melodie previste in questi casi, sembrando escludere altri strumenti cordofoni, la cui presenza, come quella della “chitarra”, è documentata, a volte, nell’ambito domestico.[xi]

Mandolino e chitarra. Museo Calabrese di Etnografia e Folklore Raffaele Corso di Palmi (RC).

Lira da gamba. Museo Calabrese di Etnografia e Folklore Raffaele Corso di Palmi (RC).

Lira da braccio. Museo Calabrese di Etnografia e Folklore Raffaele Corso di Palmi (RC).

Dubrovnik (Croazia), putto che suona una lira da braccio.
L’insegnante tedesco
Occasioni di guadagno migliori per i professionisti della musica più raffinati, rispetto a quelli cui potevano aspirare i loro colleghi di strada, si presentarono nella seconda metà del Cinquecento, a seguito delle disposizioni del Concilio di Trento (1545-1563) che, in ogni diocesi, raccomandò l’erezione del seminario: istituzione dove era previsto anche l’insegnamento della musica e del canto gregoriano[xii] che, ad esempio, troviamo eretto a Isola già nel 1566.[xiii]
Anche ad Umbriatico il seminario trovò un precoce avvio, e pur essendo questo un luogo remoto e disagiato, cominciò lo stesso ad attirare l’attenzione di quanti, anche venuti da molto lontano, percorrevano il regno alla ricerca di un impiego remunerativo come insegnanti.
È il caso di Herasmo Gritti, “genere germanus musicae doctor”, ovvero “musicae Artis doctor”, che, avendo assunto nel corso del 1572, su mandato del vescovo di Umbriatico, l’incarico “in erudiendis levilis musicam artem in venerabili seminario civi.tis Un.ci”, il 2 gennaio dell’anno successivo, ricevette dalle mani del R.do D. Antonino Galeoto, vicario generale, il pagamento finale di 4 ducati, quale residuo di maggior somma, relativamente al suo salario d’insegnante.[xiv]
Un incarico che gli portò anche altri frutti. Lo ritroviamo, infatti, il 15 agosto 1574 in Cirò, davanti al notaro Baldo Consulo, per stipulare un contratto con alcuni ecclesiastici, esponenti delle principali famiglie del luogo: il R.do D. Didaco Trugillo, D. Alfonso Coriala, D. Marc’Antonio Morello, il diacono Marcello Ferrari, il diacono Fran.co Schito, il clerico Stefano Coluto, il clerico Pompeo de Franza, il clerico Camillo Casopero per il R.do D. Nicolao Casopero suo padre, D. Alfonso Bisantio per il clerico Fabio Bisantio, e messer Scipio de Ferrari.
In questa occasione, il dottore tedesco prometteva d’insegnare loro l’arte della musica per lo spazio di un anno continuo, durante il corso del 1574 e del 1575, iniziando dal giorno successivo alla stipula del presente contratto, mentre gli ecclesiastici cirotani gli riconoscevano un salario (“mercede”) di ducati 4 e carlini 5 per ciascuno di loro da pagare in tre terze. Facevano eccezione il detto clerico Fabio il detto clerico Camillo ed il detto D. Alfonso che, invece, avrebbero dovuto pagare ducati 2 e mezzo.[xv]
L’organo
Anche se l’organo a canne è uno strumento antico, utilizzato già durante il Medioevo, la sua presenza nelle chiese del Crotonese risulta documentato soltanto nella seconda metà del Cinquecento, dopo il Concilio di Trento.
Così riscontriamo a Cerenzìa dove, in occasione della sua visita iniziata il 13 gennaio 1560, il vicario dell’arcivescovo di Santa Severina trovò la cattedrale priva di organo, e considerato che era prescritto “laudate eum in cordis et organo”, dispose che ne fosse dotata.[xvi]
Durante la prima metà del secolo seguente, però, l’antica cattedrale risultava ancora sprovvista dell’importante strumento,[xvii] mentre sappiamo che, successivamente, agli inizi del vescovato di Geronimo Barzellino (1664-1688), questi fornì di un nuovo organo, l’altra cattedrale esistente nella sua diocesi, quella di Cariati.[xviii]
Anche nella cattedrale di Santa Severina non esisteva l’organo prima che provvedesse l’arcivescovo Giulio Antonio Santoro, detto “il Cardinale di Santa Severina” (1566-1573).[xix] Questo “organo grande”,[xx] “quale si sente alle volte accompagnato da altri instrumenti di musica”,[xxi] fu rifatto, “pro decentiori servitio Dei”, spendendo 65 ducati, dal crotonese Mutio Suriano (1674-1679), il quale lo trovò ormai in abbandono, “non pulsatum”, e mancante della maggior parte delle sue canne di piombo. Lo stesso arcivescovo assegnò un “salario” ad un “Organistam” che esercitava anche la funzione di “Magistri Cappellae, et Seminarii”.[xxii] Lo strumento era posto nella “nave grande” di fronte al pulpito,[xxiii] ed è ancora ricordato all’inizio dell’arcivescovato di Antonio Ganini (1763-1795).[xxiv]

Petilia Policastro (KR), organo della chiesa Matrice. “Quattro son oggi le Chiese Parocchiali. La prima è l’Arcipretale di San Nicolò Maggiore delli Latini (…) e qui vi è un organo delli più nobili della Comarca” (Mannarino F.A., Cronica della Celebre ed Antica Petilia detta oggi Policastro, 1721-1723).

Petilia Policastro (KR), organo della chiesa Matrice. Particolare della tastiera.
Un materiale ricercato
La circostanza relativa alla sottrazione delle canne dell’organo della cattedrale di Santa Severina, riscontrata al tempo dell’arcivescovo Mutio Suriano, trova corrispondenza in altri casi analoghi, che riguardano altre chiese del Crotonese dove, attorno alla metà del Seicento, le canne di diversi organi furono asportate più o meno tacitamente, per fonderle ed ottenere il piombo di cui erano fatte.
Così avvenne ad Isola dove, nel 1644, la cattedrale non aveva più un organo funzionante, perché le sue canne erano state rubate e liquefatte, al fine di ricavarne proiettili per la caccia,[xxv] mentre, secondo la testimonianza di altri, essendo già fuori uso, le sue parti di piombo erano state concesse dal vescovo Antonio Celli (1641-1645) al sindaco della città, in maniera da farne proiettili per proteggere la popolazione, essendo sopraggiunti i Turchi per fare razzia.[xxvi]
Resta il fatto che il vescovo Io Battista Morra (1647-1649) non trovò l’organo,[xxvii] che risulta mancante anche successivamente.[xxviii] Nel 1692, finalmente, come ricorda una lapide marmorea,[xxix] il vescovo Francesco Marino (1682-1716) riuscì a provvedere la cattedrale dell’organo che, successivamente, fu fatto riparare dal vescovo Domenico Votta (1717-1721) perché era stonato (“Organum dissonum).[xxx]
Anche nella cattedrale di Strongoli possiamo rilevare una situazione analoga. Il vescovo Bernardo Piccolo (1627-1636), nonostante che la sua mensa avesse una rendita che non eccedeva i mille ducati e fosse gravata da una pensione di 100 ducati, aveva fornito la cattedrale di un “organum magnificum”.[xxxi]
A causa dell’incuria dei suoi predecessori, però, il vescovo Giovan Battista Carrone (1692-1706) trovò lo strumento che, ormai, non suonava più (“insonum”), mancante di alcune parti (“incompositum”) e da aggiustare, così lo fece rifare a sue spese per riportarlo allo stato originario,[xxxii] affidandolo ad un “Organistam”, pagato da lui stesso, per suonarlo in tutti i giorni festivi, durante le messe conventuali ed i vespri.[xxxiii] Al tempo del vescovo Domenico Marzano (1719-1735) quest’organo fu indorato.[xxxiv]
Le circostanze relative all’indebita sottrazione delle importanti canne di piombo, riguardano anche Umbriatico dove il vescovo Alessandro Filaretto Lucullo (1592-1606), per aumentare il culto divino, aveva arricchito la cattedrale di un nuovo organo, con le immagini dei Santi Pietro e Paolo da una parte, e quelle dei patroni e titolari Sant’Andrea Apostolo e San Donato dall’altra che, nel 1602, era stato collocato nel lato sinistro della chiesa, in un luogo adatto ed eminente.[xxxv]
Quest’organo segnalato nelle relazioni vescovili successive,[xxxvi] si trovava nelle vicinanze del presbiterio, al cospetto del pulpito,[xxxvii] ed il vescovo Vitaliano Marescano (1661-1667) lo trovò “Consumptum” per la vecchiaia,[xxxviii] mentre il vescovo successivo Giovanni Battista Ponzio (1682-1688), riferisce che l’organo non funzionava più perché le canne maggiori erano state rubate.[xxxix]
Domenico Peronacci (1732-1775) fece restaurare l’organo[xl] che, nel 1783, risulta esistente nella navata maggiore, di fronte alla cattedra vescovile.[xli]
Volendo ricercare ragione di tutto ciò, possiamo ipotizzare che la sottrazione delle canne di questi organi, che appare successiva agli eventi disastrosi del terremoto del 1638, possa essere messa in correlazione con i danni causati alle chiese da questo sisma, come testimoniano anche altre notizie, che riferiscono del rifacimento di alcuni di questi strumenti, subito dopo il tragico evento.
La cattedrale di Belcastro ad esempio, all’inizio del vescovato di Francesco di Napoli (1639-1651), mancava di organo[xlii] che, invece, troviamo al tempo del vescovo Tommaso Fabiani (1755-1778), il quale riferisce l’esistenza di organo e “orchestra”,[xliii] sopra la porta maggiore dove, secondo l’antichissimo rito, nei giorni prescritti dal nuovissimo cerimoniale di Benedetto XIV, era suonato da un idoneo organista (“Organarum modulatorem”).[xliv]
Per quanto riguarda invece la cattedrale di Crotone, sappiamo che il vescovo spagnolo Giovanni Pastor (1638-1662), resa agibile la cattedrale dopo il sisma del 1638, usando le rendite della cappella del SS.mo Sacramento, acquistò un organo di decente grandezza e bellezza, che fece collocare nella parte più alta del coro,[xlv] mentre al tempo del vescovo crotonese Giuseppe Capocchiani (1774-1788), fu edificata la cantoria adornata “delle sue armi” ed istallato l’organo che attualmente si trova in cattedrale.[xlvi]

Organo della cattedrale di Crotone, sistemato al tempo del vescovo Giuseppe Capocchiani (1774-1788), la cui arme è riprodotta sul parapetto della cantoria.
I discepoli o “scolari” della nobiltà
Durante il Settecento, l’uso di eseguire composizioni musicali più ricercate per meglio solennizzare le funzioni, accompagnate dall’organo e da altri strumenti (violino), accanto alla possibilità d’insegnamento offerta presso le case dei privati più facoltosi che, in alternativa ad una più costosa residenza a Napoli, potevano così prendere lezioni private studiando presso le proprie dimore, attirò verso la città di Crotone, luogo caratterizzato dalla “deficienza” di maestri di musica, l’attenzione di musicisti che frequentavano la vicina città di Cosenza.
Lo documenta un atto stipulato il 18 giugno 1758 in Crotone, tra il Sig. D. Fran.co Bifaro “Professore Mae[stro] di Musica, e Cappella della Città di Napoli”, commorante in quella di Cosenza ed attualmente presente a Crotone, ed un gruppo di nobili della città: il R.mo D. Lelio Maria Montalcini, il Sig. D. Carlo Berlingieri marchese di Valleperrotta, il Sig. D. Carmine Lucifero cavaliere gerosolomitano non professo, il Sig. D. Carlo Sculco, il Sig. D. Raffaele Suriano anche per parte del Sig. D. Giuseppe Antonio Oliverio, il Sig. D. Pietro Barricellis, il Sig. D. Pietro Zurlo ed il Sig. D. Pietro Asturelli.
Il detto maestro, infatti, essendosi “risoluto di venire in p(redic)ta Città ad insegnare la sua Professione di Musica” ad un “certo numero di scolari” crotonesi, aveva trovato l’accordo con alcuni particolari, dai quali aveva preso “l’appaldo” di fare lezione a “dieci Discepoli seu scolari per lo cuorso di tre anni continui”, iniziando dal mese di novembre del presente anno 1758, per terminare nello stesso mese dell’anno 1761.
Tale accordo prevedeva che il detto maestro avrebbe dovuto “insegnare e dare in propria Casa di essi Sud.ti Sig.ri ut sopra Cost(itut)i, la lezzione della sua professione di Musica cossi in Cembalo, che in Canto figurato”, mentre i detti signori non avrebbero potuto esimersi per alcuna ragione, “di mantenere d.o prefissato numero di dieci discepoli e p(er) essi corrispendere e pagare a d.o Sig. Maestro di musica le mesate alla lezzione”, in relazione al “salario, e stipendio” convenuto, che era stato stabilito alla “raggione” di carlini 10 al mese per ciascun discepolo, a meno che qualcuno di loro “non volesse, o non potesse” fare la detta lezione per qualche impedimento.
Si stabiliva ancora che il Sig. Asturelli, considerato che intendeva “fare applicare ad professione di Musica il di lui figlio Cl.o D. Fran.co Astorello che pensa pure doverlo mandare in Napoli per applicarsi alle lettere”, dovesse pagare le mesate solo per il primo anno, alla condizione però, che avrebbe regolarmente pagato anche per gli altri due nel caso non fosse partito.

Crotone, chiesa di Santa Chiara. Organo realizzato da Tommaso de Martino nel 1753, “all’epoca tra i più accreditati organari di Napoli”, su commissione di suor Cecilia Lucifero, la cui arme di famiglia spicca nella cimasa intagliata, mentre altri riferimenti alla sua persona si ritrovano nelle decorazioni dipinte sugli sportelli, che raffigurano Santa Chiara e Santa Cecilia. Si ricorda che l’organo fu consolidato nel 1767. “… sopra la tastiera: «Proprys sumptibus reverendae / matris, / sororis Ceciliae Lucifero»; sulla porticina della secreta: «Nicolaus (…) consolidavit 1767» …”. Ceraudo G. (a cura di), Capolavori di Arte Organaria Restaurati in Calabria, Ed. Rubbettino 1995, pp. 42-45.
Il maestro di cappella
Contestualmente alla stipula dell’atto che affidava i discepoli della nobiltà crotonese agl’insegnamenti del maestro Fran.co Bifaro, quest’ultimo ottenne anche un altro importante incarico, diventando il maestro di cappella della cattedrale di Crotone.
Quello stesso giorno, infatti, a questo scopo, nel “Palazzo vescovile” di Crotone, davanti al notaro e con l’intervento dell’Ill.mo e R.mo D. Mariano Amato, vescovo della città (1757-1765), si costituivano gli amministratori di alcuni enti eclesiastici della cattedrale: il Sig.r D. Alfonso del Castillo primicerio del capitolo, il canonico Sig.r D. Muzio del Castillo, tanto come procuratore del capitolo che in qualità di rettore e procuratore dell’arciconfraternita del SS.mo Sacramento, il canonico Sig.r D. Alessandro Albani, tanto come rettore e procuratore della cappella della Beata Vergine sotto il titolo del Capo delle Colonne, che in qualità di secondo consultore del pio monte dei Morti delle Anime del Purgatorio, ed il canonico Sig.r D. Michele Messina, come rettore e primo consultore del detto monte. Con loro, si costituiva anche il Sig.r D. Dionisio Venturi di Napoli, patrizio della città di Crotone e odierno procuratore della cappella e confraternita del SS.mo Rosario esistente nella cattedrale.
Dall’altra parte parte, si costituiva il Sig.r D. Fran.co Bifaro “Professore Maestro di Musica, e Cappella della Città di Napoli”, presente nella città di Crotone, avendo deciso di trasferire qui il suo domicilio dal prossimo mese di novembre, in relazione al fatto di aver concluso un “apaldo” con alcuni particolari di Crotone per “insegnare e dare a p(redic)ti lezzione di musica”.
In ragione di ciò, con l’approvazione ed il consenso del vescovo Amato, e poiché per “la deficienza in p(redic)ta Città di maestri di musica”, la cattedrale si trovava sfornita “di buon accompagnamento d’organo”, si conveniva tra le parti affinchè il detto Bifaro dovesse “assistere da Mastro di Cappella in essa sud.a Catredal Chiesa per le funzioni che in quella occorrono farsi per tutto il sud.o decorso d’anni tre”, cominciando dal prossimo mese di novembre per terminare nello stesso mese del 1761.

Crotone, chiesa di Santa Chiara. Particolare delle pitture presenti sugli sportelli dell’organo, un tempo sistemato sulla cantoria.

Crotone, chiesa di Santa Chiara. Particolare della scritta dipinta sulla cassa dell’organo. “THOMAS DE MARTINO NEAPOLITANUS REGIAE CAPPELLAE SVAE MAIESTATIS ORGANARIVS FECIT ANNO DOMINI 1753”
Gli obblighi del maestro
Il contratto stipulato in questa occasione, prevedeva una serie di obblighi da parte del nuovo maestro, relativi alle modalità con cui avrebbe dovuto svolgere il suo compito.
“Primieram.te sia tenuto ed obligato d.o Sig.r D. Fran.co Bifaro sonar l’organo, accompagnando il Coro in Canto gregoriano in tutte le funzioni che in essa Catredale occorressero cossi nelli giorni festivi, che nell’altri giorni tutti, nelli q.li deve pred.o R(everendissi)mo Capitolo intervenire a tenore del solito cossi coll’assistenza di d.o Monsig.r Vescovo, che tutto … per la Celebrazione della messa Cantata, che p(er) la recita del Vespero, e officio … ed in quals.a altra funzione per cui d.o R(everendissi)mo Capitolo avesse l’obligo in musica d’intervenire al Coro, senza che d.o Sig.r Fran.co Bifaro in d.e funzioni possa destinar altri in suo luogo, ma ciò soltanto li fosse lecito pratticare quall’ora egli fosse ammalato, nel qual Caso possa destinare, e mandare a sue spese altra Persona Capace a toccar d.o organo in d.o Canto gregoriano.
Inoltre nel giorno della solennizzazione della festa del Corpus Domini principiando dalli primi vespere ed in tutto l’ottavario debba assistere alla messa cantata toccando l’organo in Canto gregoriano e volendo il Procuratore presente, ò pro tempore di d.a Arciconfraternita del SS.mo Sagram.to solennizar la sud.a festa con musica in Canto figurato sia tenuto d.o Sig.r Bifaro di reggere la musica dare la Composizione atta a rappresentarsi in p(redic)ta Città, e toccar l’organo, ò la battuta ad elezzione di d.o Proc.re restando però a peso, e carico di p(redic)to le Persone che dovranno sonare il violino, ed altri Istrum.ti Musicali, e le voci seu Cantatori, ed essendono p(redic)ti dilettanti, e novelli di p(redic)ta Città sia tenuto d.o Sig. Bifaro fare a p(redic)ti il debito preventivo Concerto sop.a d.a Composizione, ma se mai d.i Cantatori si dovesse prendere a paga si debbano preferire li figli di esso Sig.r Bifaro.
Di vantaggio come che in tutti i giorni di sabato si devono cantare le lodi ad B. V. del Capo delle Colonne nella Particolar e propria Cappella dell’istessa perciò sia tenuto d.o Sig.r Bifaro in tutti d.i giorni di sabato intervenire alla Recita di d.e lodi, toccar l’organo in Canto gregoriano accompagnare l’Inno Te Deum Laudamus, e cantare esso lui le litanie della B.a V.e, ed attrovandosi in d.i giorni di sabato, ò alcuno di essi inpedito il d.o Sig. Bifaro li sia lecito a mandare altra Persona Capace a sopplire a tutto ciò che di sop.a si a detto; Inoltre debba assistere alla solennizzazione della festa principale di d.a B.a V.e del Capo delle Colonne, che si celebra nella seconda domenica del mese di Maggio di ciasched.o anno in essa sud.a Catredal Chiesa, cossi nel Triduo delle lodi che si recitano la sera di giovedì, venerdì e sabato, che nel Vespero, Messa cantata, e p(er) tutto l’ottavario che si continuan d.e lodi nel giorno nelle quali funzioni debba intervenire, ed assistere esso lui personalm.te d.o Sig.r Bifaro toccando l’organo in Canto gregoriano cantando le litanie pred.e coll’antifona Regina Coeli, e se il Proc.re di d.a Cappella disponesse di solennizzarsi d.a festa con musica in Canto figurato cossi in d.e lodi di d.o Triduo della sera, che nel vespero, e Messa Cantata, debba d.o Sig.r Bifaro diriggere la musica dar la Composizione atta a rappresentarsi in p.a Città e toccar l’organo, e far l’abbattuta ad elezz.ne di d.o Proc.re a carico di chi resta di rinvenire le Persone p(er) sonare il violino ed altri Istrum.ti Musicali, e che dovranno cantare, e se p(redic)ti dovranno chiamarsi a paga si debban preferire li figli di d.o Sig. Bifaro, e se d.i Cantatori fossero dilettanti, o Principianti ut sup.a si debba d.o Sig.r M(aest)ro di Cappella fare il dovuto concerto preventivam.te alla Rappresentaz.ne come si è detto p(er) la solennità della festa del Corpus Domini; E similm.te debba esso Sig. D. Fran.co assisterci alla Novena del Santo Natale che in essa Cappella della B.a V.e del Capo delle Colonne si recita doppo il vespero di … giorno, nella q(ua)le debba toccar l’organo in Canto gregoriano cantar le litanie pred.e il Pange Lingua, e Tantum ergo per l’esposizione del Venerabile che in essa novena si suole fare.
Per anche sia tenuto d.o Sig.r Bifaro di assistere à sonar l’organo in Canto gregoriano, cantar le litanie della B.a V.e ed il Tantum ergo per la esposizione si fa del V(enerabi)le in tutti li giorni che si recita il SS.mo Rosario nella Cappella dell’istesso, che sono i giorni di Domenica, mercordì, e venerdì doppo il vespero e l’istesso obligo debba tenere nella quindicina che si suole celebrare antecedente alla festa di d.o SS.mo Rosario, ed essendo impedito possa in suo luogo destinare altra Persona Capace a sopplire alle sue veci; E debba pure assistere alla festa pred.a di d.o Sacratiss.o Rosario che si celebra nella prima Domenica di ottobre tanto p(er) le vesperi se si recita però, quanto p(er) la messa cantata, e volendo il Proc.re la med.ma solennizzare con Musica sia tenuto d.o Sig.r Bifaro diriger la Musica dar la Composiz.ne atta a rappresentarsi in q.a Città, e toccar l’organo, ò l’abbattuta ad elezzione di d.o Proc.re a carico di cui però restano le Persone p(er) sonare il violino, ed Is(trumen)ti Musicali, e li Cantatori, e se p(redic)ti Cantatori si dovessero da d.o Proc.re procurare a paga, si debbano preferire come s.a li figli di d.o Sig.r Bifaro ma se poi fossero dilettanti, sia tenuto d.o Sig.r Maestro di farli il debito preventivo Concerto sincome si sop.a si è detto.
E p(er) ultimo sia tenuto d.o Sig.r D. Fran.co Bifaro d’intervenire alla messa cantata, esposizione, e riposizione del Vene(rabi)le che suole farsi in essa Catred(ra)le nel Triduo del Carnovale in suffraggio dell’Anime del Purgat.rio, nel funerale che si fa nel giorno della Commemoraz.ne de tutti i morti, nell’altro della quaresima, doppo la predica dell’Anime del Purgat.rio ed in qualsivoglia altro Funerale che in suffragg.o di d.e Anime del Purgatorio si facesse in essa Catredale nelle q.li funzioni esso Sig.r Bifaro debba intervenire a toccar l’organo in Canto gregoriano accompagnando il Coro, e rispetto al Triduo di d.o Carnovale debba la sera nella Reposizione del q(ua)le cantare le litanie, ed il Tantum ergo, e volendosi dall’Amm.ri di d.o Monte far d.e funzioni, o alcuna di esse in Canto figurato sia tenuto d.o Sig.r Bifaro dirigere la Musica dar la Composizione atta a rappresentarsi in q.a Città, e toccar l’organo, ò l’abbattuta ad elezzione di d.i Amm.ri a carico delli q.li resta come s.a d.o il peso delle Persone p(er) sonare il violino ed altri instrum.ti musicali e quelle che dovessero Cantare e se poi detti Cantatori si dovessero prendere a paga si debban preferire li figli di esso Sig.r Bifaro ed essendono dilettanti si debba Come s.a d.o il med.o fare il dovuto preventivo Concerto.”
In relazione a quanto minuziosamente specificato e per “tutte le quali fatighe”, i signori procuratori, in nome e parte del capitolo, cappelle e monte suddetti, con il consenso dell’Ill.mo Monsignor Vescovo, convenivano con il maestro di pagargli durante i previsti tre anni di contratto, “l’annuale stipendio” di ducati ottantadue, da pagarsi sempre anticipatamente ogni trimestre in 4 “paghe” uguali di ducati 20 e grana cinquanta, così ripartito tra loro: ducati 15 per la cappella del SS.mo Sacramento, ducati 30 per la cappella della B.a V.e del Capo delle Colonne, ducati 12 per la cappella del SS.mo Rosario, e ducati 25 per i detti Pio Monte e R.mo Capitolo.
Da parte sua, il detto maestro prometteva di giungere nella città di Crotone dal prossino mese di novembre, ed “immediatam.te intraprendere, e principiare la Carica di Mastro di Cappella in d.a Catredal Chiesa” e questa esercitare continuatamente nel detto triennio, provvedendo ad “assistere al servizio di d.a Chiesa nelle sud.e Funzioni che in quella si dovranno come sop.a Celebrare nella maniera e forma di sop.a descitta, e convenuta”.[xlvii]
Note
[i] Surian E., Manuale di Storia della Musica, vol. I, Milano 2012, p. 32.
[ii] Surian E., cit., p. 67.
[iii] De Leo P. (a cura di), Documenti Florensi 2001, pp. 067-068.
[iv] “musica polifonica che, invece di essere scritta nota contro nota, come nella primitiva forma di polifonia, presenta varietà di figurazioni melodiche e ritmiche (più note contro nota, sincopi, contrattempi, fioriture, ecc.).” da www.treccani.it
[v] “La cappella fa musica in canto figurato le Domeniche, e giorni di festa tanto nelle prime, e seconde vesperi, quanto nella messa conventuale, e così anco i giorni feriali di Quaresima, e delle Rogationi anzi nelle feste degli Apostoli, della Beata Vergine, e del Signore si canta ordinariamente a due chori, e nelle maggiori solennità a quattro, non mancando mai l’organo, quale si sente alle volte accompagnato da altri instrumenti di musica. In quella né a sonare, né a cantare si ammettono laici essendo la maggior parte del Clero di questa professione molto bene intendente.” ASV, Rel. Lim. S. Severina., 1589.
[vi] AASS, 16B.
[vii] ASCZ, protocollo notaio Santoro M., II, ff. 122-123v.
[viii] ASCS Notaio Napoli di Macchia, vol. 11-12, 1537-38, ff. 107-107v.
[ix] Lo strumento è descritto all’indirizzo saverioaceto.blogspot.it
[x] “Rigalati alli Tamborinari d’Isola, che sonorono nelli giorni della festa d. 00=70. Regalati allo Tamborinaro di Cutro, che anco sonò nel dì della festa d. 00=25”. “Al Tambarinaro, e bifaro d. 0:60”. ASCZ, Cassa Sacra, Libri Antichi e Platee, Libro de’ conti della Procura della Ven.le chiesa di S.ta Anna (1745-1784).
[xi] Così risulta da alcuni inventari. 09.12.1632. Nella domus palaziata dove aveva abitato il quondam Joannes Fran.co Schipano, posta nella terra di Policastro in convicino della SS.ma Annunziata “nova”, si ritrova un “baullo” all’interno del quale è una “chitarra scasciata” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 299, ff. 091v-092v). 26.01.1649. Nella casa del quondam Giacinto Cavallo, posta dentro la terra di Policastro “nella ruga del fumarello”, si ritrova “una Chitarra” (ASCZ, Notaio F. Cerantonio, Busta 196 prot. 876, ff. 013v-015).
[xii] Il canto gregoriano risulta tra gli insegnamenti impartiti nel seminario di Crotone (ASV, Rel. Limina Crotone, 1673; 1667; 1709, f. 081; 1722 f. 200; 1754 f. 295; 1774 f. 352; 1795 f. 023).
[xiii] ASV, Rel. Lim. Insulan. 1633.
[xiv] ASCZ, Notaio Consulo B., busta 8, ff. 5-5v.
[xv] ASCZ, Notaio Consulo B., busta 8, ff. 66-66v.
[xvi] AASS, 16B.
[xvii] ASV, Rel. Lim. Cariaten. et Geruntin., 1621 e 1643.
[xviii] ASV, Rel. Lim. Cariaten. Geruntinen. 1666, f. 173v.
[xix] “L’organo non vi era prima, ma vi fu fatto dall’Ill.mo e R.mo Sig.or Giulio Antonio Santori Cardinale di S. Severina allora Arcivescovo di quella Chiesa.” ASV, Rel. Lim. S. Severina., 1589.
[xx] Scalise G. B. (a cura di), Siberene Cronaca del Passato per le Diocesi di Santaseverina – Crotone – Cariati, Una platea del secolo XVI, p. 331.
[xxi] ASV, Rel. Lim. S. Severina., 1589.
[xxii] ASV, Rel. Lim. S. Severina., 1675.
[xxiii] All’inizio dell’arcivescovato di Carlo Berlingieri (1679-1719), “Dentro la nave grande vi è il pulpito di marmo pardiglio con due Colonne di cipollazzo d’ordine jonico, e dall’altra vi è l’organo.” Scalise G. B. (a cura di), Siberene cit., p.104.
[xxiv] “Organum non desideratur magnificum”. ASV, Rel. Lim. S. Severina, 1765.
[xxv] “Caret Organo musicali eo quia furati sunt, ut liquefacere tubulos possent pro venatione;”. ASV, Rel. Lim. Insulan. 1644, f. 549v.
[xxvi] Pesavento A., La chiesa di Santa Maria dell’Isola. Da cattedrale a arcipretale, in www.archiviostoricocrotone.it
[xxvii] “Virginis Imaginem, ac organum non inveni,”. ASV, Rel Lim. Insulan. 1648, f. 503.
[xxviii] ASV, Rel. Lim. Insulan. 1651, f. 1228; 1660; 1673; 1677.
[xxix] D.O.M. / Franciscus Marinus cam / panem Ep.s Ins. Cathedrale / hanc Basilicam imis pene a / fundamentis aere suo exci / tavit, atque omni prorsus vetustate sublata, in amplio / rem, decentiorem restituit formam sacellis i=/ tidem magnifice constructis adauxit reso=/nis tandem organis / sculpto item suggestu / pictisq. laquearibus ex / ornavit an. a. nat. D.ni / MDCXCII.
[xxx] ASV, Rel. Lim. Insulan. 1721.
[xxxi] ASV, Rel. Lim. Strongulen. 1630.
[xxxii] “Organum adest, quod insonum reperi, et meis sumptibus statim reficiendum curavi.” (ASV, Rel. Lim. Strongulen. 1694). “Adest Organum, quod insonum et incompositum etiam reperi, et parte reaptari, et ad pristinam formam reduci mandavi.” (ASV, Rel. Lim. Strongulen. 1696). “Organum etiam adest, quod a principio refeci, et in dies esigere curabo.” (ASV, Rel. Lim. Strongulen. 1700).
[xxxiii] “Adest Organum, quod a principio insonum reperi, ut alias significavi, et meis suptibus rieficiendum curavi, et de p(rese)nti per Organistam, a me deputatum omnibus festis diebus pulsatur in Missis Conventualibus et Vesperis.” (ASV, Rel. Lim. Strongulen. 1702).
[xxxiv] ASV, Rel. Lim. Strongulen. 1729.
[xxxv] ASV, Rel. Lim. Umbriaticen., 1603.
[xxxvi] ASV, Rel. Lim. Umbriaticen., 1611, 1615, 1630.
[xxxvii] ASV, Rel. Lim. Umbriaticen., 1634.
[xxxviii] ASV, Rel. Lim. Umbriaticen., 1662, 1666.
[xxxix] ASV, Rel. Lim. Umbriaticen., 1688.
[xl] ASV, Rel. Lim. Umbriaticen., 1739, 1753.
[xli] ASV, Rel. Lim. Umbriaticen., 1783.
[xlii] ASV, Rel. Lim. Bellicastren. 1645, f. 76.
[xliii] Capialbi V., La continuazione dell’Italia Sacra dell’Ughelli per i vescovadi di Calabria, in Archivio Storico della Calabria, II, 1914, p. 198.
[xliv] “In ingressu jam descriptae Cathedralis Ecclesiae super janua majori pneumatica reperiuntur Organa, quae juxta vetustissimum S. R. E. ritum, diebus a novissimo fel. reg. Benedicti PP. XIV Caeremoniale Episcoporum, praescriptis, per idoneum Organarum modulatorem, pulsantur.” ASV, Rel. Lim. Bellicastren. 1758, f. 346v.
[xlv] “Eccl.a habet organum in emin.ti parte intra Chorum collocatum, decentis magnitudinis, et pulchritudinis, emptum redditibus cappellae Sanct.mi Sacram.ti quae quotannis supersunt.” ASV, Rel. Lim. Crotonen. 1640, f. 775r.
[xlvi] “Ebbe parte alla costruzione del magnifico organo, che tuttavia esiste, adorno delle sue armi.” Capialbi V., La continuazione dell’Italia Sacra dell’Ughelli per i vescovadi di Calabria, in Archivio Storico della Calabria, II, 1914, p. 513.
[xlvii] ASCZ, Fondo notarile cart. 859, 1758, ff. 163-169.
The post Maestri di musica e discepoli nel Crotonese (sec. XVI-XVIII) appeared first on Archivio Storico Crotone.
Il convento domenicano di Santa Maria della Consolazione di Zagarise

Sigillo dell’università di Zagarise.
“Zagarisi terra picciola, ma dotata d’ogni cosa necessaria al vitto humano, piacevole, e dilettosa”.[i]
L’erezione del convento domenicano
Costanza d’Avalos ebbe nel 1500 da re Federico, suo cognato, la contea di Belcastro con Cropani e Zagarise; quattro anni dopo seguì la conferma del re Cattolico. La contessa morì nel 1541.[ii] Si deve alla D’Avalos l’erezione in Zagarise del convento dei Domenicani sotto il titolo di Santa Maria della Consolazione.
Secondo quanto è scritto in una relazione della metà del Seicento, il convento, in diocesi di Catanzaro, fu fondato nel 1521 per interessamento della contessa, la quale ottenne dai canonici di San Giovanni in Laterano, proprietari della chiesa, che essa fosse data all’università di Zagarise ed alla contessa. Poi la chiesa passò da questi ai Domenicani. Il tutto è documentato dal breve dell’anno seguente diretto dal vescovo di Marzio e dal vescovo Tuscolano Alessandro Farnese, cardinale e arciprete di San Giovanni in Laterano, al Padre Fra’ Giovanni Leto della Provincia di Calabria dell’ordine dei Predicatori.[iii]
Ben presto i frati entrarono in lite con il clero locale. Con un breve in data 10 giugno 1570 il papa Pio V incaricava il vicario del capitolo di Crotone, chiesa mancante di vescovo per morte di Sebastiano Minturno, di informarsi sulla lite, che verteva su numerosi beni.[iv]
Alla fine del Cinquecento secondo il vescovo di Catanzaro Nicola Degli Orazi nel convento ci sono “fere” quattro sacerdoti e la congregazione del SS.mo Rosario.[v]

Zagarise evidenziata nella carta delle provincie continentali dell’ex Regno di Napoli, realizzata nel periodo tra gli anni 1821-1824. Particolare della Sez-12-Col-IX.
Il convento alla metà del Seicento
Ubbidendo alla Bolla di papa Innocenzo X del 27 dicembre 1649, i frati predicatori il 9 marzo 1650 inviarono la relazione sullo stato del convento. Allora vi abitavano sei sacerdoti (Vincenzo Infusino della Grotteria, Francesco Paterno della Grotteria, Silvestro Lupuleo, Giacinto Venere di Mesoraca, Carolo d’Arena della Grotteria e Agostino Gentile di Zagarise), due conversi (Pietro Lierisano di Placanica e Tomaso Nesci di Soriano) un terziario (Domenico Garcea di Zagarise), un oblato (Paolo Carpampano) e un famulo.
La chiesa, dedicata a Santa Maria della Consolazione, era “capacissima et ornat(issi)ma di bellissime Cappelle dell’una parte et dell’altra”. Attaccato c’era il convento, di forma quadrata con due dormitori per dodici camere, “con tutte l’officine necessarie”; un altro dormitorio era in costruzione. Il convento, attorniato da orti e giardini, era distante sei passi dall’abitato, che era senza mura.
Secondo la relazione firmata dal priore Vincenzo Infusino e dai frati Silvestro Lupuleo e Giacinto Venere, le entrate eguagliavano le uscite. I frati infatti stimavano la rendita annua in 642 scudi a fronte di 635 di spesa. La maggior parte degli introiti proveniva da prestiti in denaro e da censi enfiteutici (scudi 400, 62%), seguiva l’affitto a semina in grano bianco e germano ed a pascolo ed erbaggio in denaro dei numerosi fondi (scudi 205, 32%), poi l’affitto della spezieria del convento (scudi 30, 5%) ed infine, il sale fornito dal fondaco (scudi 7, 1%).
Gli esiti, ammontanti a 635 scudi, riguardavano per la maggior parte (80%) il mantenimento dei frati (vitto scudi 360), (vestiario scudi 97), (scarpe, calzette e pianelle scudi 40) (medici e barbiere scudi 10) per un totale di scudi 507. Vi erano poi le spese per completare e riparare l’edificio (scudi 50 l’anno, 8%). Le spese per il culto (olio, cera ecc. scudi 15, 2%). I rimanenti 63 scudi (10%) erano suddivisi tra collette (del Provinciale, del capitolo Provinciale, per il Capitolo generale, al convento di Catanzaro, ecc.), per censi passivi, per alloggio di ospiti, per mantenere un “giumento” e per bisogni vari.[vi]
Il 15 ottobre 1652 Innocenzo X emanava la Costituzione sulla estinzione e soppressione dei piccoli conventi con meno di sei soggetti o con rendite insufficienti. La Costituzione innocenziana non colpiva il convento di Zagarise, che procederà incolume fino alla Cassa Sacra.
Il terremoto del 1783 non causò gravi danni al convento e all’abitato. Allora nel convento vi erano quattro frati.[vii] Dopo il terremoto del 1783 i frati dovettero lasciare l’edificio ed i beni furono gestiti dalla Cassa Sacra. Dalla “Lista di Carico” compilata nel 1790,[viii] possiamo farci un’idea dei numerosi fondi e rendite dei quali era dotato all’atto della abolizione.
Le Entrate erano costituite da una cinquantina di Fondi rustici, che davano a seconda dell’affitto in pascolo, erbaggio o in semina, denaro o grano e germano, da una quarantina di censi enfiteutici e da più di una ventina di censi bollari. Il tutto era stimato per un introito annuo di circa 463 ducati, a fronte di un’uscita di circa 40 ducati, non essendoci più le spese di mantenimento dei frati. Alle entrate andavano aggiunti poi i tomoli di grano bianco, di germano e di germanella ed i frutti delle numerose piante esistenti negli orti e nei fondi, che a secondo della natura e dei contratti potevano essere inclusi (“compreso il frutto degli alberi”) o esclusi (“escluso il frutto degli alberi, che precedente apprezzo si deve vendere in tempo opportuno per conto della C.S.”) o spartiti in parte con l’affittuario come nel caso del fondo “Volpe”.[ix]
Rendita in denaro
Da Fondi
I fondi affittati a pascolo o ad orto e quindi con pagamento annuo in denaro erano 29: Orto del Convento (duc. 9), Orto di Decio (duc. 3), Orto di Melicuccia (duc 2 gr. 50), Orto di Munda (duc. 2 gr. 10), Giardinello Melito e Perruccio (duc. 16), Calamizano e Macchia (duc. 12 gr. 60), Rotellone (duc. 9), Candila (duc. 4 gr. 20), Melito Grande (duc. 37 gr. 33 cav. 4), Pranchi (duc. 4 gr. 60), Tre Arie (duc. 3), M.o Minico (gr. 60), Misovro Soprano (duc. 3), Volpe (duc. 8), Misovro Sottano (duc. 4), Mandriglie (duc. 1 gr.20), Carrozzino (duc. 83 gr. 33 cav. 4), Mastrio (duc. 44), Medina (duc. 17), Filippello (duc. 7 gr. 75 cav. 4), Scarola (duc. 17 gr. 50), Orticello, Pantana (duc. 60), Crigna di Asino, Lucito (duc. 16), Agostino Grasso (duc. 5), Lucitello di Scoffola, Lucitello di Mangone, Lucitello di Donnemme.
La rendita annua ammontava a duc. 359, grana 72 e cavalli 2. I 29 fondi misuravano tomolate 768 e mezza, di queste solo 309 (40%) erano adatte alla semina per due anni e gli altri tre a pascolo, 421 (55%) erano adatte solo ad erbaggio o erano scoscese, selvose e sterili. Le rimanenti 38 tomolate (5%) erano a vigna (Mastro e Medina) e castagneto (Lucitello di Mangone e Lucitello di Donnemme). I fondi a pascolo erano affittati con pagamento annuo in denaro all’otto di settembre.
I cinque orti (del Convento, di Decio, di Melicuccia, Orticello e di Munda) avevano una estensione complessiva di circa tomolate quattro e mezza ed erano affittati ad uso di giardino e di orto con contratti annui a partire da novembre con pagamento in denaro alla fine di ottobre di ogni anno per una rendita annua di ducati 16 e grana 60. Essi rappresentavano circa il 5% dell’entrata proveniente da fondi. Mentre i primi quattro erano affittati per un triennio, l’orto di Munda era affittato per 29 anni. Tra le piante predominavano i gelsi neri (45), seguivano i fichi (24) e gli ulivi (16), poi i pruni e gli agromoli (13), le querce (6), i ciliegi (6), meli (4), peri (2), un noce, quattro spalliere di viti, un “pergoteco d’uva” e diverse piante di fichi d’india.
Da Case
Il convento possedeva solo una casa, che affittava per un canone annuo di un ducato e grana ottanta. I frati preferivano non gestire direttamente ma dare in enfiteusi le case ed i stabili, che provenivano da lasciti e donazioni.
Da censi enfiteutici
I censi erano 43 per un totale annuo di ducati 48 e grana 69. Essi erano infissi su case (12), orti (4), vigne (12), chiuse (3), pezzi di terra (5), stabili (6) e castagneto (1). Tranne due, gli altri davano una rendita inferiore a due ducati annui. Si trattava di lasciti e donazioni pervenuti al convento e dai frati concessi ad abitanti del luogo.
Da censi bollari
I censi bollari erano 24, dei quali 14 concessi a abitanti di Zagarise e 9 a “naturali” di Sersale ed 1 ad un nobile. La rendita annua era di ducati 35 e grana 8 (ducati 15 e grana 3 da Zagarise e ducati 7 e grana 9 da Sersale e dal nobile ducati 12 e grana 60).
Il capitale che il convento aveva impiegato in prestiti assommava a ducati 706, dei quali 265 ad abitanti di Zagarise, ducati 66 ad abitanti di Sersale e ducati 315 ad un nobile di Soveria. I prestiti variavano da ducati 5 al massimo di ducati 30, tranne uno di ducati 315, al tasso di favore del 4%, che doveva pagare D. Valeriano Asturini di Cicala per Sebastiano Sgambiglia di Soveria. In genere il tasso che i frati applicavano era intorno al 6%. Il pagamento dei censi enfiteutici e di quelli bollari avveniva nel mese di agosto di ciascun anno.
Rendita in genere
Da Fondi in grano bianco alla taglia
Nella maggior parte i fondi sono affittati a semina per un biennio e per tre anni ad uso pascolo. Quelli che si trovavano affittati a semina con pagamento in tomoli di grano bianco al raccolto erano dieci: Serricelle e Serriccie, Cipi, Mezzo Serrone, Cuda, Rovello, Andreone, Orlando, Melessaro, Chiusa di Andrea Elia e Pungeca. Complessivamente i fondi misuravano 493 tomolate, ma solo 84 tomolate (17%) erano adatte alla semina di grano bianco o germano, le rimanenti erano sterili o boscose. Davano una rendita annua di 37 tomoli di grano bianco.
Da Fondi in germanella
Il fondo Cuda era dell’estensione di 90 tomolate, ma solo 16 erano adatte a semina, le altre erano boscose e sterili. Vi erano anche degli alberi di ulivo e di “sovero”. Affittato per tre anni arrecava una rendita di un tomolo e mezzo di grano bianco ed altrettanto di germanella.
Da Fondi in germano
I tre fondi Greco Sottano, Fratta e Piano di San Domenico, ossia della Cruciata, per la loro posizione geografica erano in parte adatti alla semina di grano germano ed in parte composti da terreni petrosi, scoscesi e sterili. Misuravano complessivamente 74 tomolate, ma solo su un terzo era adatto alla semina. Il loro affitto variava dai tre ai cinque anni e rendevano 10 tomoli annui. L’affitto a semina iniziava a settembre con pagamento alla raccolta.
Fondi in Demanio
I quattro fondi Alberina, Greco Soprano, S. Domenica e Mabro non erano affittati e da questi non si percepiva nulla. Trattasi per la maggior parte di terreni sterili, scoscesi e alpestri. Nel fondo Alberina vi era una calcara ed in Mabro un castagneto.
Animali
Il convento possedeva anche 31 Capre, che di solito erano date in affitto (duc. 6 e grana 20)
Situazione economica del convento gestito dalla Cassa Sacra
Rendita ducati 463.20.8/ Pesi 40.68.6/ Avanzi 422.52.2
Elenco delle piante esistenti nei fondi del convento
Querce: Pungeca (6) Agostino Grasso (26), Orto di Decio (6), Filippello (13), Scarola (9), Pantana (56), Lucito Grande (77), Giardinello (1), Melito e Perruccio (72), Calamizzano (170), Candila (53), M.ro Minico (1), Melito Grande (20), Volpone (22), Mastrio (35), Medina (54), per un totale di 621.
Castagni: Mastrio (14), Medina (40), Scarola (10), Pantana (68), Lucitello (62), Lucito Grande (130), Mabro (107 piante), Lucito di Mangone (60), Lucito di Donnemme (26) per un totale di 517 piante.
Fichi: Filippello (7), Scarola (45), Pantana (42), Orto e Orticello (18), Orto di Decio (1), Orto di Melicuccia (5), Mastrio (120), Medina (18) per un totale di 270.
Gelsi neri: Orto e Orticello (18), Orto di Decio (11), Orto di Meliccuccia (8), Orto di Munda (8), Filippello (3), Scarola (8), Pantana (52), Melito e Perruccio (71), Candila (1), M.ro Minoco (1), Mastrio (43), Medina (20), Scarola (16) per un totale di 260.
Ulivi: Volpone (31), Melissaro (34), Mastrio (16), Medina (14), Filippello (28), Scarola (2), Pantana (48), Agosino Grasso (10), Orto e Orticello (15) Orto di Decio (1) per un totale di 199.
Peri: Melito e perruccio (1), Calanizzano (22), Volpone (3) Carozzino (3), Mastrio (5), Medina (6), Agostino Grasso (4), Filippello (5), Scarola (2), Pantana (5), Orto di Decio (2) per un totale di 58.
Ciliegi (Cirieggi): Filippello (5), Scarola (5), Pantana (19), Lucito Grande (3), Orto e Orticello (2), Orto di Melicuccia (2), Orto di Munda (2), Mastrio (5), Medina (10) per un totale di 53.
Pomi (pomi di Està, Poma Amare, Meli d’inverno): Scarola (26), Pantana (4), Mastrio (16), Medina (2) per un totale di 48.
Pruni: Mastrio (2) Medina (4), Filippello (4), Scarola (14), Pantana (1), Orto e Orticello (13) per un totale di 38.
Sorbi: Mabro (4), Agostino Grasso (1) Filippello (1), Scarola (1), Pantana (6), Lucito Grande (5), Melito e Perruccio (1), Candila (1), Mastrio (6)Medina (8) per un totale di 34.
Noci: Orto di Decio (1), Filippello (1), Scarola (2), Pantana (4), Mastrio (4) Medina (9) per un totale di 21.
Gelsi Bianchi: Filippello (2), Scarola (1), Pantana (2), Mastrio (3) per un totale di 8.
Agromoli: Scarola (7)
Amarena: Mastrio (1), Pantana (2) per un totale di 3.
Mandorlo (amendola): Medina (1).
Melograno (granato): Pantana (1).
Pesco (persico): Orto di Melicuccia (1).
Viti: Orto e Orticello, Mastrio, Medina.
Molti Piedi di Ticine (ontano) alberi che non producono frutto (Carozzino).
Fichi d’india (orto e Orticello).
Querce piccole ossia bisciglie: Filippello (15).
Durante il Decennio francese il convento sarà soppresso definitivamente con decreto del 7 agosto 1809.[x]

Il paesaggio costiero visto dai dintorni di Zagarise (CZ).
Il paesaggio
Il territorio dove sono situati i beni appartenenti al convento domenicano è tipico della Presila ionica. Esso si sviluppa dal piano collinare verso la marina alle cime boscose della Sila. I numerosi valloni di Brigliaturo, di Scillotraco, di Perito e di Castoro caratterizzano il suo paesaggio, che è solcato dai torrenti Erbarolo, Lucito, Fratta, Barbaro, Acarri e Manno. Non mancano le fosse (di Gregorio, di Urica) e molte terre sono per la maggior parte alpestri, boscose, cretose, pietrose e sterili.
Parte sono “soggette al comune”, cioè in esse tutti i cittadini di Zagarise hanno il diritto di pascolo. I fondi sui quali vige questo diritto sono Misorvo soprano e sottano, Mandriglie, Carozzino, Cipi, Mezzoserrone, Cuda, Rovello, Andreone, Orlando, Melissaro, Fratta, Piano di San Domenico, Greco Soprano, S. Domenica, Mabro e Pachi; in quest’ultima oltre al diritto di pascolo, poiché vi sono molte querce, i cittadini possono raccoglierne il frutto.
Pochi sono i pianori dove la semina biennale si alterna al pascolo triennale; in molti terreni è possibile solo l’erbaggio. Presso l’abitato ci sono gli orti e le chiuse. Essi sono situati vicino al Piano della Chiesa di San Domenico, alle fabbriche del convento e della chiesa dei domenicani, al Piano del Palazzo Baronale, al casaleno di Rosario di Leonardo, dietro la chiesa di Santa Caterina ecc..
Oltre agli orti dei Domenicani c’è “Il Mondezzaro” della chiesa collegiata e quelli della cappella di San Pancrazio, di Domenicantonio Cristiano, di Giuseppe Scarpino, di Domenico e Antonio Schipani, di Vincenzo Gallello, di Giovanni Scorza nelle Grotte di Muio, di Cassandra Perrone ecc.
Estesa è la coltivazione della vite. Vigne sono segnalate in località Mastrio e Medina (Vigna di Pietro Paolotto, vigna detta Malacise o Malagrise di Giovanni Girolamo di Leonardo), a Scarola (Vigna detta Butundo di Pietro Verrino, del canonico Gagliardo), Soverito (Vincenzo Guerra, Francesco Tulello), Scillina (Leonardo Tallarico, Pancrazio Schipani), Lucitello di Scoppola (Ottavio Elia), Agostino Grasso (canonico Pollinzi), Pantane (Benigno Dragone), Munda (Nicola Puperi), Triscine (Raimondo Mazza), Orlando (Santo Mazza), dietro la chiesa di Santa Caterina, (Cassandra Perrone), Crifoglio dietro le mura del convento (Caterina Schipani) ecc.
La presenza di folti boschi, di molti alberi di quercia e di gelso denota un intenso allevamento di ovini, di maiali e di bachi da seta. Nella parte collinare è ben presente la coltivazione dell’ulivo e della vite. Verso monte vi è un esteso castagneto. Molti sono gli alberi da frutto; oltre ai fichi, predominano i peri, i ciliegi, i pomi ed i pruni e non mancano i sorbi, i noci, gli “agromoli” ecc.

Il paesaggio presso Zagarise (CZ).
Ecclesiastici, nobili e benestanti
La chiesa con le sue molteplici articolazioni mantiene alla fine del Settecento un posto predominante nel possesso della terra in territorio di Zagarise. Tra i luoghi pii di Zagarise oltre ai Domenicani, ci sono anche i fondi della chiesa collegiata di Zagarise dedicata a Santa Maria Assunta (“Terraria”, “Cariglietto”, “Tre Arie”, “La Fossa di Gregorio”, “Cugno Petruso”, “Pezzetti di S. Francesco”,” Invidia”, ecc.), della cappella del SS.mo Sacramento (“Fariano”, “La Petrizia”, “Branche”, “Lucito”) e della cappella del Rosario (“Terre della Pungica”, “Brundello”).
Sempre in territorio di Zagarise hanno proprietà anche la Mensa vescovile di Catanzaro (“S. Pietro”, “Mortelletto”, “Campanaro”), il monastero dell’Annunziata di Taverna (“Trulli”), il monastero di San Lorenzo di Cropani (“Melissaro”) ed i benefici di S. Tommaso d’Aquino (“Aria”) e di S. Giuseppe (“Il Barone”).
Accanto alla proprietà ecclesiastica vi è quella di alcuni nobili e benestanti di Catanzaro: D. Francesco Munizio (“Petruso”), D. Ignazio Alfieri (“Aragazzi”); di Taverna: D. Gregorio Stocco (“Mondile”), D. Giuseppe La Rosa (“Castoro”), Girolamo Veraldi (“Prito”); di Carpanzano: D. Lorenzo Anania (“La Cruciata”, “Tre Arie”) e di altri: D.a Cassandra Perrone (“Mezzo Serrone”, “Vertola”), Vittoria Elia (“Mezzo Serrone”), D. Ottavio Gentile (“Fornace”), D. Giovanni Monizio (“Razzona”), Eredi di Paolo Guerra (“Lombardo”), Tomaso Catanzaro (“Il Boja”),Francesco Mandile (“Silofea”), D.a Lucrezia Lucà (“Stimpata”), D. Gaetano Lucà (“Mandriglie”), D. Domenico Opiparo (“Cortalese”), ecc.
Feudo, chiesa e nobiltà detengono quasi tutti i fondi che compongono il territorio di Zagarise, agli abitanti rimangono alcune vigne e le case, per lo più gravate da censi, ed i diritti sulle terre comuni.

Portale della chiesa del convento di San Domenico a Zagarise (CZ).
Descrizione del convento nei documenti della Cassa Sacra
“Fabbriche, ed edifizi del Convento di S. Domenico
Allo stesso si entra per una porta chiamata di Battere, che quantunque sia con mascatura, e braccio di ferro, pure ha bisogno di riparo. Per la medesima porta si entra al chiostro di detto Convento, il quale è situato in quadro, e composto di ventidue archi all’intorno, e con una gisterna dà conservar acqua piovana.
Dalli lati di detto chiostro per due porte, una sita alla parte di Tramontana si entra al Refettorio antico, oggi ridotto in magazeno per uso della Cassa Sacra, e parimente si entra accanto d.o refettorio in un altro basso dove era il forno, e da ivi scendendo per una scala sotterranea si va in un basso, da cui si entra al Cellaro, dove esistono tre botti vecchie, ed inservibili. Dall’altra porta sita alla parte di occidente si va in un basso dove esiste la pagliera con porta e vi è una finestra tutta aperta, e senza cancella e bisogna accomodarsi per stare riparare il Convento, e specialmente per non poter entrare gente a cagionare danno al magazeno e alla camera dove sta riposto l’olio.
Accanto detta pagliera esiste la stalla vecchia, e senza porta, ed una Cancella di Legno, che ha bisogno di accomodo. E scendendo da detta Stalla più abbasso si entra per una porta di tavole in tre vuoti di magazeno, uno appresso all’altro con due porte framezze anche di tavola.
Dal sopra detto descritto chiostro per una scaletta di fabbrica si al primo dormitorio di detto convento dove esistono nove stanze, otto colle respettive finestre, e porte, e l’ultima è senza porta dove esistono li luoghi Comuni, ed in una di dette stanze, e propriamente in quella che sta situata a man sinistra della scala per cui si saglie al quarto superiore vi è riposto l’olio della Cassa Sacra, la di cui chiave sta presso il passato Regio Procuratore, ed in un altro braccio sito in piano, e detto dormitorio, e dalla parte di occidente, si va in due stanze, una delle quali era refettorio, e l’altra Cucina così ultimamente situata da quei Padri.
In detto descritto dormitorio vi esiste una scala di fabbrica per cui si sale un quarto superiore, che sta attaccato alla chiesa e nello stesso vi esistono sei camere colle respettive porte, e finestre senza mascature, e nelle medesime nellintempiate vi mancano le tavole, e da detto quarto superiore, il quale ha bisogno di riparo, si va a due loggie coperte, le quali anco anno bisogno di accomodo.
Detto convento quasi da pertutto ha bisogno di ripari ne’ ciaramidi, mentre oltre di essere in molte parti cadenti, pure in dette coperture vi sono de’ canali rotti, per cui cascando l’acqua piovana di dentro viene ad infracidire il legname, e specialmente deve ripararsi la copertura delle camere superiori al magazeno, mentre da quelle casca l’acqua e vengono a patire i generi in quello riposti, ed anche con specialità a bisogno di rifazione il pontone del convento della parte d’occidente, che sta in pericolo di cadere, e così precipitarsi maggior parte del convento istesso.
Fabbriche, ed edifizi della chiesa di S. Domenico
E composta di una sola nave, e si entra in quella per una porta grande, che ha bisogno di accomodo avanti di qual porta vi sta un paramento di legname dalla parte di dentro; nella medesima a fondo vi sta l’altare maggiore e dietro il med.o il coro di legname, e sopra detto coro un’orchesta anche di legname depinta col suo organo.
Alla parte destra quando si entra in detta chiesa vi sono tre altari, il primo di S. Pietro Martire e S. Catarina anche depinta su la tela, il secondo della Vergine SS.ma del Carmine sulla tela, ed il terzo di S. Domenico della stessa maniera. Alla parte sinistra vi esistono anche altri tre altari, il primo di S. Maria degli Angioli. Il secondo del nome di Gesù, ed il terzo del SS.mo Rosario tutti e tre quadri respettivamente dipinti sulla tela. Vi esiste nella stessa un’acquasantaro di marmo con un cerchio, e tre piedi di ferro, che lo sostengono, ed una sagrestia con alcuni stipi di tavola voti ed un campanello piccolo sopra la porta della medesima in detta Chiesa vi è attaccato il campanile in cui esistono due campane una grande, ed una piccola; e nella medesima chiesa vi vogliono molti ripari tanto nell’intempiata di tavole che nella copertura de ceramidi per non entrarci acqua che nelle finestre, dove in porzione mancano li vetri.
Della Congregazione del SS.mo Rosario
La stessa viene attaccata con detto Convento, consiste in una picciola nave, dove si entra per una porta di legno con mascatura e vi esiste in quella un solo altare di legno indorato, in cui in una nicchia vi è la statua della Vergine SS.ma con un vestimento di molla turchina, esistendo avanti detta statua la vetrata, ed un panno di molla, che la copra. Accanto a detto altare vi esistono due stipi di legno d’abete, ed attorno detta Congregazione vi sono gli sedili di legno, anche di tavola d’abete, e nella medesima vi è bisogno di molti ripari nell’intempiata.
Convento di S. Domenico
Orto del Convento
Continenza di terra nobile in territorio di Zagarise dell’estensione di tomolate due atte ad uso di giardino. Vi esistono diciasette alberi di fichi di stato, e decadenza, diciotto alberi di gelsi neri, e dodici piante di pruni e di agromoli. Tre piedi di mela, quindici alberi di ulivi, e diverse piante di fichi d’india, e viti spalliere quattro, e cirieggi numero due di decadenza. É circondato da muri di fabbrica, ed in picciola parte di pietre secche. Confina da tramontana colle fabbriche del convento, e della chiesa, e da oriente con altro orto di questo luogo pio, da mezzogiorno con uno stabile dello stesso convento appellato l’Alberina intercendendovi una strada pubblica, ed a oriente una strada pubblica.
Orto, e orticello attaccato
Gelsi neri numero diciotto, dodici di stato, e sei di decadenza. Fichi numero dieci otto, quattro di aumento, cinque di decadenza, e nove di stato, prugni numero tredici di aumento, olivi numero quindici, quattro di decadenza e l’altre di aumento. Poma numero tre; cirieggi numero due, e l’uni e l’altri di decadenza Spalliere di viti quattro. Alcuni piedi di fichi d’india. ASCz. Cassa sacra Lista di Carico. Zagarise. vol. 50 ff. 578-582.

Affresco della chiesa del convento di San Domenico a Zagarise (CZ).
“Copia dell’atto, descrizione, misura e suggellamento de’ quadri de luoghi pii di Cropani, Belcastro e Zagarise.
Zagarise.
Adi die nove Giugno mille settecento ottanta quattro nella Terra di Zagarise.
Certifico col mio giuram.to io qui sottoscritto Canc.re di q.a Terra qualm.e conferitosi qui oggi D. Rafaele Manzi Cadetto del Battaglione Real Ferdinando, ed assistente à D. Giuseppe M.a Gaudiosi Uff.le, principalmente commissionato in questo paraggio per l’abolizione e soppressione de Luoghi Pii, e nell’abbolito Conventino Domenicano e specialmente nella chiesa di esso ha proceduto alla misura e suggilamento dei Quadri in esso esistenti.
Nel primo altare à man dritta sotto il titolo del SS.mo Rosario, in quadro dipinto in oglio in tela, rappresentante la Madonna SS.ma sotto lo stesso titolo, si è trovato dell’altezza palmi dodeci e mezzo, e della larghezza pal. Otto, ed un terzo, coll’Iscrizzione= Michelangelus Napparus ping. 1601. Nel Secondo vi è il quadro della Circoncisione di Giesù Cristo, dell’altezza pal. Dodeci e mezzo, larghezza pal. Otto, ed un terzo, dipinto, anche in tela in oglio senza iscrizzione. Nel Terzo il quadro similmente dipinto in tela rappresentante la figura della Madonna dell’Angioli, altezza palmi dodeci, e mezzo e palmi otto ed un terzo di larghezza senza iscrizzione. Nel Quarto a man sinistra il quadro di S. Domenico di altezza palmi dodeci meno un terzo e larghezza palmi otto, senza iscrizzione, consimilmente dipinto in oglio sopra la tela. Nel Quinto il Quadro della SS.ma Vergine del Carmine consimilm.te dipinto, in cui vi è l’Iscrizzione seg.te Joanne de Simone pingente= e si è trovato dell’altezza palmi nove e larghezza palm. Sette ed un terzo. Nel Sesto vi è il Quadro di S. Pietro martire dell’altezza pal. Diece meno un terzo, e della larghezza pal. Sette e mezzo, consimil.te dipinto sopra tela in oglio, ed in piè è la seguente iscrizzione = Beatrix Politi F.F. P. sua divozione 1652. Sopra il Coro appeso a un muro vi è il quadro di S. Tomaso di Aquino dipinto consimil.te sopra tela in oglio dell’altezza palmi nove ed un terzo e larghezza pal. Sei e mezzo e due oncie senza iscrizzione. Quali Quadri dopo essersino stati misurati col passetto Napolitano, l’uno dopo l’altro dal sud.o Cadetto assistente, sono stati sugellati, con impronto in cera spagna, e se bene in d.a Chiesa vi siano ancora appesi ne respettivi muri di essa altri piccoli quadri nel num.o di nove, rappresentanti diverse figure, per essere vecchi e di puoco momento, non si è stimato descriverli minutam.te, misurarli e suggelarli. E tutti li quadri di sopra numerati ed annotati, inclusi anche d.i nove quadretti senza innovarsi cosa alcuna, rapporto alla consegna di essi altra volta fatta al Benestante Giuseppe Faragò, rimasero similn.te consegnati allo stesso. Quindi in fede del vero ne ho formato il presente sotto la mia propria mano e per maggior legalità autorizato col solito universal sugello di questo luogo ed a fede.
Pasquale Arcip.te Podia fui presente
Antonio Schipano Luog.te fui presente
Giuseppe Franco Sindaco fui presente
Giuseppe Faragò fui presente
Raffaele Manzi Assistente
Pietro Faragò canc.re certifico come sopra.”
ASCz. Fondo Cassa Sacra. Ripartimento di Zagarise. Copia dell’atto, descrizione, misura e suggellamento de’ quadri de luoghi pii di Cropani, Belcastro e Zagarise. Vol. XXI, ff. 8v-9.

Affresco della chiesa del convento di San Domenico a Zagarise (CZ).

Affresco della chiesa del convento di San Domenico a Zagarise (CZ).

Affresco della chiesa del convento di San Domenico a Zagarise (CZ).
Note
[i] Nola Molise G.B., Cronica dell’Antichissima, e Nobilissima Città di Crotone e della Magna Grecia, Napoli 1649, p. 84.
[ii] Alla morte di Costanza D’Avalos il feudo di Zagarise passò al nipote Alfonso D’Avalos, il quale lo vendette nel 1542 al duca di Montalto Ferrante D’Aragona. Le rendite feudali di Zagarise erano costituite dalla Mastrodattia, dalla Bagliva, dal corso seu tenimento di Cariolace, da Censi e rendite e dall’affitto del tenimento di Borda, ASN. RCS. Relevi B. 348, Relevio dello Ill. S.r q. dono Ant.o de Aragonia duca di Montalto, f. 5v e sgg.
[iii] ASV. Relazione dei conventi domenicani della Prov. Di Calabria, 1650, ff. 623-625. Congr. super Statu Regul. 1650. Prov. Calabriae.
[iv] 10 giugno 1570. “Vicario Capitolari ecclesiae Crotonen., sede episcopali vacante, committitur cognitio litis et causae vertentium inter Priorem et fratres domus sive conventus S. Mariae de Consolatione, O.P., terrae Zagarisii, Cathacen., dioc., et clerum ac presbyteros saeculares dictae terrae, super recuperatione, conservatione et restitutione omnium et singulorum bonorum, domorum viridariorum, terrarum aliorumque fructum”, Russo F., Regesto, 22249.
[v] “Oppidum Zagarisii abest Cathanzario passuum decem millia, Domino Bellicastri subiectum, animas continet 1660. Templum Parochiale est collegiatum, habetque tres Dignitates, Archipresbyterum, Cantorem et Thesaurarium, novem praeterea alios presbyteros qui omnes curam habent animarum, inserviunt per hebdomadam, recitant Capitulares divina officia in choro, et sacrum solemne faciunt. Numerantur in eodemTemplo Altaria multa Juris Patronatus laicorum cum sacrorum onere quae ita divisa sunt, ut plura in eo quotidie peragantur. Est etiam Domus Hospitalis ad peregrinos transeuntes excipiendos, sub invocatione Annuntiatae Virginis. In hoc oppido duo visuntur Mendicantium cenobia, alterum ordinis S. Dominici, in quo habent fere quatuor sacerdotes, est societas Rosarii, alterum vero S. Francisci tertii Ordinis, in quo tres tantum versantur fratres, nondum enim absolutum.” 15 giugno 1592. Relatio status ecclesiae Cathacen., facta a Nicolao de Horatiis, in De Girolamo A., Catanzaro e la riforma tridentina, Ed. Parallelo 38, 1975, p. 206.
[vi] Relatione del Convento di S.ta M.a della Consolatione dell’ord.ne di Predicatori situato nella terra di Zagarise Diocesi della Città di Catanzaro Calabria Ultra nel Regno di Napoli in Conformità della Bolla di S.a S. Innocentio X sotto li 27 di xbre 1649. Il d.o Convento fu eretto l’anno 1521 à richiesta di Donna Costanza d’Avolos Aquino duchessa di Francavilla e Padrona della sopradetta terra e perche la Chiesa di d.o Monasterio era delli Canonici di S. Gio. Laterano li quali la diedero all’Università et alla Padrona della terra et unitamente poi alla Religione com’appare per breve delli 1522 dà Mons.r Vescovo di Marzio et dell’Emin.mo Vescovo Tusculano Alexandro Farnese Card.le et Arcipreite di S. Gio. Laterano diretto al P.re frà Giovanni Leto della Prov.a di Calabria dell’ord.ne di Predicatori. La Chiesa ha il titulo di S.ta M.a della Consolatione capacissima et ornat.ma di Bellissime Cappelle dell’una parte et dell’altra. Il Monasterio è in forma quadra attachato con la Chiesa distante dell’habitato da sei passi essendo la terra aperta senza muraglia. Ha dui Dormitorii nelli quali vi sono dodeci Cammere de frati con tutte l’officine necessarie. Vi è un altro Dormitorio di già coperto ne vi manchano se non le sparteture delle cammere che in sei anni si potrà finire. Nel pred.to conv.to non si trova assegnato numero de frati che costi per scrittura ma vi sogliono stare dodeci frati cioè cinque sacerdoti quatro clerici studenti e dui fratelli laici; al presente non vi sono studenti per la penuria che vi hà la provincia ma vi sono l’infratti Padri e frati vd sei sacerdoti cioè il P.re fra Vincenzo Infusino della GrotteriaLett.e e Priore al presente del Conv.to. frà fran.co Paterno della Grotteria sottopriore. fra silvestro Lupuleo lett.re fra Giacinto Venere di Musuraca lett.re fra Carolo d’Arena della Grotteria lett.re fra Agostino Gentile di Zagarese sacerd.te fra Pietro Lierisano di Placanica fratello converso fra Tomaso Nesci di Soriano converso fra Domenico Garcea di Zagarese tertiario Paolo Carpampano oblato claustrale et un famulo. Il d.o Monasterio esige ogn’anno di Censi Bullali scudi quattrocento – 400. Di più tiene una possessione alborata con vigne dalla quale ne percipe d’affitto anno quolibet scudi venti -20. Possiede un’altra possessione consistente in vigne et altr’albori dalla quale ne percipe d’affitto annui scudi quindeci-15. Item possiede un giardino di celsi dal quale ne percipe ogn’anno dedutte le spese scudi cento cinquanta-150. Possiede di più terre aratorie in più parti delli quali ne può percipere un anno per l’altro tumola vinti di grano tra bianco e germano che si calculano scudi vinti-20. Item tiene nel convento una spetiaria dalla quale ne percipe d’affitto scudi trenta-30. Riceve dal fondaco del sale un cantaro che si calcula scudi sette-7. Elemosine manuali non riceve niente ma le messe quando ne fossero si pagano un carlino l’una di Regno.All’incontro. D.o Monasterio ha peso d’una messa cantata il giorno per l’anima delli fondatori. Item quattro messe sette il giorno quali sin’adesso tutte sono sodisfatte. Item pagha di censi passivi scudi nove ogn’anno-9. Item al Convento di Catanzaro scudi deceotto l’anno-18. Item pagha per la colletta del Provinciale e Compagni del p.re Rev.mo P.reProcuratore dell’ord.ne et altre necessità scudi quatro e mezzo -4-2-10. Ogni due anni per la Colletta del Capitolo Provinciale scudi quatro-4. Ogni tre anni per il Capitolo Generale scudi tre più o meno secondo la distanza del luogho ove si celebra-3. Per la sagristia o sacri suppellettili come oglio cere et altre necessità scudi quindeci-15. Item ha spesa ordinaria di vitto comprendendo il grano vino et altre cose raccolte ne beni del monasterio à raggione di scudi trenta per ciascheduna bocca che non più se ne spende per la fertilità del Paese scudi trecento sessanta- 360. Item vestiario de Religiosi e serviente à raggione di scudi sette per ciaschedun Religioso che fanno la somma di scudi ottanta sette e dieci per il famulo che sono tutti scudi novantasette-97. Per scarpe calzette e pianelli de frati scudi quaranta – 40. Per medici scudi cinque l’anno e cinque altri per il Barbiere – 10. Le medicine son franche della speziaria. Per viatichi per occasione del Capitolo et altri bisogni un anno per l’altro scudi cinque -5. Per spesa d’un giumento che tiene il Convento per suoi bisogni scudi sei – 6. Per alloggi d’ospidi così de Religiosi come forastieri scudi quatro -4. Per biancherie letti et altri mobili di casa scudi -10. Per fabrica scudi cinquanta l’anno -50. Noi Infra.tti con il mezzo del nostro giuram.to attestiamo d’haver fatto diligente inquisizione dello stato del monasterio sud.o e che tutte le cose espresse di sopra et ciascheduna d’esse sono vere e reali et che non habiamo tralasciato d’esprimere alcuna entrata ò uscita ò peso del medesimo monasterio che sia pervenuta alla nostra notitia et in fede habbiamo sottoscritta la presente di nostra propria mano e signata col solito soggillo di 9 Marzo 1650. Io fra’ Vincenzo Infusino della Grott.a lett.e Aud.e Gen.le Priore dico come sop.a. Io fra Silvestro Lupuleo di Zagarise lett.re deputato dico come di sop.a. Io fra Giacinto Venere di Musuraca lett.re e deputato dico come di sop.a., ASV. Relazione dei conventi domenicani della Prov. Di Calabria. 1650, ff. 623-625. Congr. super Statu Regul. 1650. Prov. Calabriae.
[vii] “Zagarise – Poche case cadute, molte altre lesionate popolazione 967 – Domenicani 4”. Vivenzio G., Istoria e teoria de’ tremuoti, Napoli 1783.
[viii] Oltre a quelli del Convento Domenicano furono gestiti dalla Cassa Sacra anche i beni delle cappelle del SS.mo Sacramento, di S. Nicola, di S. Pancrazio, della chiesa di S. Maria degli Angeli e della Congregazione dell’Immacolata, ASCz. Cassa sacra Lista di Carico. Zagarise. vol. 50 ff. 578-582.
[ix] “Volpe. Continenza di terre nobili di tomolate 14 delle quali 11 atte a semina di grano bianco per due anni e per un triennio ad uso pascolo, e tomolate tre solo ad erbaggio. Vi sono 31 alberi di ulivi e 22 alberi di querce, tre alberi di peri e diverse piante di piraini. Il frutto delle querce, ed olivi deve farsi apprezzare a suo tempo, e rilasciarsi allo stesso fittuario per metà quello delle querce, restando l’altra metà per conto della C. S. la quale dovrà farne la vendita, l’altro delle olive deve raccogliersi anche dal medesimo Fittuario, il quale ha l’obligazione di trituralo a sue spese, e consegnare alla Cassa Sacra tre quarte parti del prodotto in olio, ritraendosi l’altra quarta parte in compenso delle spese sud.e a seconda dell’uso del Paese per cui ogni tomolo di ulive, deve il Fittuario corrispondere tre quarti di olio dentro il Trappeto del peso di oncie sessanta per ogni quarta e perciò il Regio Amministratore averà cura di far fare l’apprezzo di detto frutto inteso il fittuario”. ASCz. Cassa sacra cit., f. 457.
[x] Caldora U., Calabria napoleonica, (1806-1815), Cosenza 1985, p. 222.
The post Il convento domenicano di Santa Maria della Consolazione di Zagarise appeared first on Archivio Storico Crotone.
Descrizione e toponomastica della città antica di Cerenzia

Veduta aerea di Cerenzia Vecchia.
“Città antichissima detta Cerenthia anticamente chiamata Pumento fabricata sovra un sasso, e circondata da profondi precipitii”.[i]
“Gerentia … posita in quodam Monte, et saxo praecipiti undique ingentibus rupibus cincto, quae ob insalubrem aerem et fere pestilentem, quasi in solitudinem redacta est”.[ii]
“Sebbene molto antica sia questa Città è poco abitata sì per l’aria cattiva, che vi si respira, e come per la Pestilenza, che l’ingombrò nell’anno 1528”.[iii]
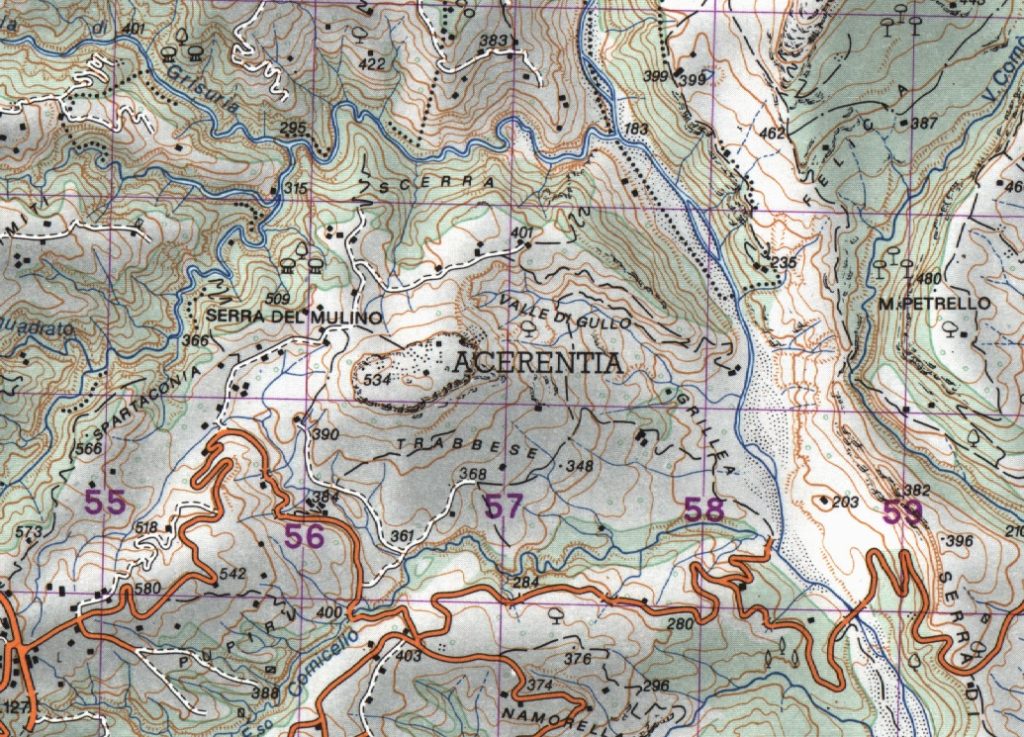
Cerenzia Vecchia. topografia della località di “ACERENTIA” (particolare del foglio N. 561 S. Giovanni in Fiore 1:50.000 dell’IGM).
La città di Cerenzia alla metà del Settecento si presentava spopolata ed in abbandono. Abitata solo in parte e con alcune abitazioni in rovina poteva essere suddivisa in tre rioni, tra loro separati da ampi spazi coperti di orti e giardini, con gelsi neri e alberi di fichi. In luogo dominante svettava l’antica cattedrale di San Teodoro, circondata dal suo ampio giardino. Dalla parte opposta l’area dell’antico castello feudale. Di esso rimaneva solo il ricordo nel toponimo, che copriva un’ampia estensione in parte incolta, e nei censi di “ius soli inefrancabbili” dovuti alla Camera baronale.
Di fronte ad essi verso la Sila l’ampio rione “Falarocca” o “Palarocca”, dove era situata la maggior parte dell’abitato e dove si apriva la porta principale della città. All’esterno ed intorno alle mura i numerosi orti e giardini alberati di gelsi neri e di alberi da frutto rendevano meno aspro il paesaggio primaverile.
Le mura
È del 12 ottobre 1491 una supplica dell’Università di Cerenzia al Re Ferdinando per ottenere i mezzi per poter riparare le mura della città: “… dicta Città et districto de mura … Concederli che li prati et defese in quillo modo essi citatini se le gaudeno senza contradictione alcune lo possano vendere, et la utilita et lucro perveniente da quilli ponerle a la reparatione dele mura de dicta Cita, et ad fare una cisterna per comodo de dicta universita …”.[iv]
Le mura della città sono anche richiamate in un atto del notaio Marcello Santoro di Santa Severina. Il 17 aprile 1577 in Santa Severina. Ligorius Gamuti e la sorella Armenia di Cerenzia donano al Reverendo Vincenzo Strati di Caccuri, abitante in Cerenzia, alcuni loro beni: “duas arbores sicomorum sitas ante portam magnam Civitatis Cerentiae jux.a ortale Laurentii Faguente viam publicam et muros dictae Civitatis ac alios fines nec non aliam alborem sicomorum situm in eodem loco” (gli alberi sono gravati di un censo di grana uno e mezzo dovuti alla curia baronale). La donazione è per “amore Dei et per remissione suorum peccatorum et ad hoc ut p.tus R. Vinc. Possit comodius vivere et rogare Deus”.[v]
Il documento evidenzia che, vicino alle mura ed appena fuori la Porta Magna della città, vi erano alcuni piccoli orti, alberati di gelsi neri e di alberi fruttiferi.
Le porte della città
Si entrava nella città attraverso le porte. Dall’analisi dell’aerofotografia e delle carte topografiche si può ipotizzare che vi erano almeno tre porte. Esse erano situate una dalla parte della chiesa cattedrale, un’altra verso la marina dalla parte del castello e la terza verso la Sila, dove era situata la maggior parte dell’abitato.
Una di esse è richiamata in una visita pastorale della metà del Cinquecento. Dopo aver invocato il nome della Santissima ed Indivisibile Trinità, il 13 gennaio 1560, accompagnato da D. Nicola Gulli, pubblico notaio per apostolica autorità e giudice ordinario ed anche mastro d’atti ordinario della Curia arcivescovile di Santa Severina e della sua diocesi e provincia, il Reverendo Joanne Thomasio Cerasia, cantore della chiesa di Mileto e vicario generale metropolitano per parte dell’Ill.mo e R.mo D. Joanne Baptista Ursini, arcivescovo di Santa Severina, dopo aver visitato nei mesi passati la chiesa metropolita di Santa Severina e la sua diocesi, volendo continuare e completare la visita per tutta la provincia, lasciò la chiesa metropolitana di Santa Severina e si recò nella città di Cerenzia e nel vescovato di detta città, suffraganeo di detto arcivescovato di Santa Severina.
Come arrivò presso la porta di detta città (“pervenisse prope portam dictae Civitatis”), gli andò incontro il Reverendo D. Angelo Macri, vicario generale di detto vescovato, assieme, come al solito, a molti altri preti di detta città di Cerenzia, al capitolo ed al clero. Il 15 gennaio 1560 lasciata la città di Cerenzia giunse nella terra di Caccuri.
Un documento successivo documenta l’esistenza della “Porta Magna”. Il 17 aprile 1577 in Santa Severina. Ligorius Gamuti e la sorella Armenia di Cerenzia donano al Reverendo Vincenzo Strati di Caccuri, abitante in Cerenzia, alcuni loro beni: “duas arbores sicomorum sitas ante portam magnam Civitatis Cerentiae jux.a ortale Laurentii Faguente viam publicam et muros dictae Civitatis ac alios fines nec non aliam alborem sicomorum situm in eodem loco” (gli alberi sono gravati di un censo di grana uno e mezzo dovuti alla curia baronale).[vi]
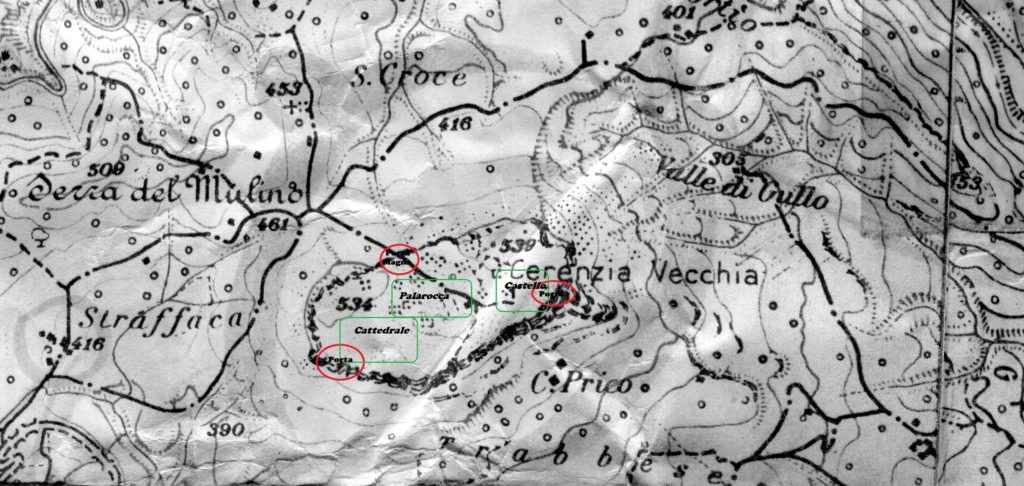
“Cerenzia Vecchia”. In evidenza le porte, il castello, la cattedrale ed il luogo detto Palarocca.
La “Porta Grande” è presente anche nei documenti settecenteschi. Appena dentro e vicino ad essa vi erano degli “orticelli” e delle case palaziate e terrane. Sappiamo che il custode di porci Carlo Mauro, originario della terra di Savelli, possedeva “un orticello nel luogo detto La Porta Grande alberato di celzi negri, confinante con i beni di Tomaso Oliverio”[vii] ed il Rev.do Can(oni)co Don Donato Quattromani, prete secolare, vi aveva “una casa palaziata ed un’altra terrana al piede di essa nel luogo dove si dice la Porta Grande”.[viii]
Il rione Porta Grande” è citato anche in seguito negli atti del notaio di Cerenzia Massimino Caligiuri (1810-1818).

Sigillo del notaio Massimino Caligiuri di Cerenzia.
La cattedrale dedicata a San Teodoro (Vescovado) (dentro le mura)
Nel gennaio 1560 la cattedrale manca di campanile. Il visitatore ordinò che entro due anni fosse costruito. Nella relazione del vescovo Propertio Resta del novembre 1589, così è descritta la Chiesa Cattedrale “è fuora della habitatione in loco eminente et mal seguro per i banditi et ladri … Le campane sono dentro la chiesa da sessanta anni cascò il campanile senza esser mai refabricato”.[ix]
Il napoletano Carlo Ronchi (1732-1764) trovò che nella cattedrale erano erette le due confraternite del SS.mo Rosario e dei Sette Dolori di Maria Vergine. Situata in un promontorio, fuori e dominante l’abitato, che contava circa 400 abitanti, ad essa era unito il piccolo palazzo vescovile.[x]
Alla metà del Settecento vi erano le cappelle di San Francesco di Paola,[xi] di San Giacinto[xii] e del SS.mo Sacramento.[xiii]
Il rione Vescovado Vecchio è citato anche negli atti del notaio di Cerenzia Massimino Caligiuri (1810-1818).
Palazzo Vescovile (dentro le mura)
Il “Palatio episcopale” era vicino alla Cattedrale (1560). Era formato da una “habitatione pess(im)a con due stantiole in terreno fabricate di creta, recetto di sorci et formiche senza comodità di acqua ne di cosa alc(un)a”.[xiv]
Il giardino della Mensa Vescovile (dentro le mura)
Il Giardino della Mensa Vescovile si estendeva verso il luogo Palarocca. In una donazione fatta a titolo di patrimonio sacro al nipote dal canonico Candido Caligiuri, tra i vari beni vi è “un palazzo di più stanze tutte con loro rispettivi bassi, camere e tavolati, sito e posto nel luogo detto Palarocca tutto isolato vicino il luogo detto il Giardino della Mensa Vescovile, franco e libero di ogni peso, censo e servitù, ne ad altri donato, ipotecato, né soggetto a fedecommesso, dentro del quale vi è una stanza grande detta l’ultima camera con un camerino attaccato ad essa, l’una e l’altro palaziati come sopra, la quale camera, e camerino tali quali avendoli fatti estimare, ed apprezzare dal mastro muratore ed esperto aprezzattore delle fabbriche Bernardo Oliverio di questa Città di Cerenzia …”.[xv]
Il “Giardino” apparteneva alla Mensa vescovile ed era un comprensorio di terre di dodici tomolate alberate di gelsi neri. Confinava con i beni della chiesa cattedrale, con l’orto alberato di gelsi neri e con le mura della chiesa di Santa Maria delle Grazie e con un orticello appartenente al Capitolo della Cattedrale. Alla metà del Settecento è descritto come “detoriorato”.[xvi]

Ruderi della cattedrale di Cerenzia Vecchia.
Il castello (dentro le mura)
Dell’antico castello medievale alla metà del Settecento rimaneva solo il ricordo nella toponomastica, che indicava una vasta area, in parte disabitata, all’interno della città, dove il principe di Cerenzia, Vincenzo Rota, conservava tra i beni feudali “la vigna del Castello”[xvii] ed alcuni censi su case ed orti.
Nel luogo detto il Castello vi erano alcune case palaziate e terrane con accanto orti ed orticelli alberati di gelsi neri, fichi ed alberi da frutto. Tra queste quella di Domenico Venneri della città di Cariati, che aveva un orto alberato di gelsi neri e fichi “d’estensione un tom.o”, il quale confinava con la Principal Camera e via publica[xviii] e quella di Rosalbo Benincasa, nobile vivente di S. Giovanni in Fiore, il quale possedeva nel luogo detto il Castello “una casa palaziata chiusa in più membri con un orticello adiacente alla d(ett)a casa alberato con piedi celzi neri inaffittata per mancanza d’habitanti, al presente abitata gratis dalla vidua Innocenzia Marulli”.[xix]
Il luogo, situato dal lato opposto alla cattedrale di San Teodoro, era presso la porta della città rivolta verso la marina ed è richiamato più volte negli atti dei primi anni dell’Ottocento del notaio di Cerenzia Massimino Caligiuri.
Da questi documenti sappiamo che nel rione “il Castello” vi era l’abitazione di Vincenzo Bisciglia,[xx] quella promessa alla futura sposa Maria Talarico dalla zia Portia Curto, la quale “per affetto e benevolenza che dice aver portato”, promette che alla sua morte possa ereditare “la sua casa ove al presente abita, sita in questa città luogo detto il Castello, confine quella di Carlo Mauro e via pubblica. Franca e libera d’ogni peso, quale casa dovrà intendersi il solo membro superiore”.[xxi]
Vi era poi il “continente di case” che il nobile Fortunato de Lucro vende nel 1808 ad Andrea Marrajeni. Questo insieme di abitazioni, gravato da un censo per “jus soli” dovuto al barone, era “sito in questa sudetta Città, luogo detto il Castello, confine la casa di Vitaliano Ursia, e quella degli eredi del quondam D. Domenico Bonavia, consistente in tre camere a piede piano, ed una grotta propriamente sotto le sudette case per franche e libere, ma solamente soggette ad un’annualità censuale di carlini due per cadauna camera, dovuta alla Camera Baronale di questa sudetta Città, per il di loro capitale di docati diciotto censo ineffrancabile per il jus soli. Come pure un magazzino confine alla stalla di Giovanni Fabiano.”[xxii]
Da ultimo ricordiamo che Francesco Laratta possedeva “una casa a piede piano confine la casa del canonico D. Giuseppe Spina, e l’orto dello stesso, strada publica, per franca e libera, pervenutala dall’eredità paterna, e sita e posta la sudetta casa entro questa sudetta Città, luogo detto il Castello”. La casa, valutata dal mastro muratore Bernardo Lignanetti di San Giovanni in Fiore per ducati 18 e grana 50, è venduta a Giuseppe Frontera.[xxiii]
La piazza (dentro le mura)
Nel luogo detto “la Piazza” vi sono alcuni piccoli orti alberati di gelsi neri. Tra questi quello del bracciale Francesco Macri che possiede un piccolo orto di capacità un quarto di moggio,[xxiv] del massaro Francesco di Domenico, che ha un orto “nel luogo d.o la Piazza, seu Grotta”,[xxv] del sarto Salvadore Mangone, che vi possiede un piede di celzo nero[xxvi] e di Domenico Venneri della Città di Cariati, che oltre a “due piedi di celzi neri” vi ha anche “un trappeto”.[xxvii]
Nella piazza c’erano alcune case palaziate, delle botteghe e dei trappeti. La vedova Costanza Spina, vedova di Francesco Papaleo, porta in dote a D. Leonardo Aragona della città di Cariati “la presente camera, ove al presente abita col suo rispettivo basso, e propriamente quella con vignano, e finestra, confine quella di Agnesa Scarpino, via publica … Una bottega sita nella Piazza, e proprio sotto la casa dell’eredi del fu Francesco Basile.[xxviii]
Anche Elisabetta Grande promette alla figlia Anna Maria Greco, che sposa Antonio Fabiano, “una casa col suo basso ove attualmente abita e proprio quella di mezzo col focone e la terza parte della terza parte del trappido, che possiede entro questa Città, e proprio nella Piazza”.[xxix]
Falarocca – Palarocca (dentro le mura)
Il rione Falarocca o Palarocca era situato vicino ed appena dentro la Porta principale della città. Alla metà del Settecento comprendeva la maggior parte delle abitazioni.
Oltre alle numerose “casette a piede piano” dei braccianti, che costituivano la parte dominante, vi erano anche le case palaziate di alcuni nobili e di massari, come quella del mag.co Francesco Scafoglio, nobile vivente di anni 43, che abita nel luogo detto “Falarocca” in “una casa palaziata consistente in due membri con orto contiguo, che serve per proprio uso”. Accanto ha un basso, che serve per uso di stalla e adiacente un orto di piccola estensione alberato di celzi neri. Il nobile inoltre possiede un altro orto dentro la Città alberato di celzi neri ed un altro orticello alberato di celzi neri confinante con la casa di Domenico Matino.[xxx]
Nei primi anni dell’Ottocento nel luogo “Palarocca” c’è l’abitazione di Agostino de Fazio con accanto una sua casetta “quasi diruta” per uso di stalla colla sua rispettiva pagliera, confinante con la casa di Rosa Cavallo.[xxxi] Sempre nella stessa località vi sono le casette “a piede piano” di Serafina Noce, vedova di Giuseppe Mauro, e di Maria Mangone. Le due proprietarie decidono nel dicembre del 1805 di permutare le loro abitazioni. La Noce ha una “casa a piede piano”, confinante con la casa di Agostino di Fazio e la Mangone pure una “casa a piede piano”, confinante con la casa del Reverendo sacerdote D. Domenico Quattromani.[xxxii]
Vi sono anche alcune case palaziate composte da un alto ed un basso come quella descritta nei capitoli matrimoniali di Vito d’Urso e Teresa Talarico. Tra i beni dotali vi è “una casa dove al presente abita la Talarico ad esclusione del suo basso. La casa confina con quella di Francesco Marino e la via pubblica”.[xxxiii]
Oltre alle numerose casette terranee ed a quelle palaziate vi sono anche alcuni palazzi. Nella donazione fatta a titolo di patrimonio sacro dal canonico Don. Candido Caligiuri al suo nipote Don Luigi, vi è “un palazzo di più stanze tutte con loro rispettivi bassi, camere e tavolati, sito e posto nel luogo detto Palarocca, tutto isolato vicino il luogo detto il Giardino della Mensa Vescovile. Nel palazzo “c’è una stanza grande detta l’ultima camera con un camerino attaccato ad essa, l’una e l’altro palaziati”.[xxxiv]
Chiesa e convento domenicano di Santa Maria delle Grazie (dentro le mura)
Il convento domenicano di Santa Maria delle Grazie di Cerenzia era situato dentro le mura della città, “in strada publica che delle case dell’habitanti è distante dal d(ett)o monasterio passi nove in circa”. Alla metà del Seicento la famiglia del convento era composta dal sacerdote e vicario Francesco Asturino di Verzino, dal sacerdote Marco Imbriaco di Caccuri e dal frate “serviente” Francesco Gallo di Caccuri; tutti i frati quindi provenivano da luoghi vicini.
Gli edifici che costituivano il piccolo convento, si riducevano ad una piccola casa accanto alla chiesa. Quest’ultima copriva un’area lunga palmi 72 e larga 32. Aveva sacrestia ed alcune cappelle e altari. Sono ricordate le cappelle delle famiglie Gugliemo e Russo, e l’altare dello SS.mo Rosario.
L’abitazione dei frati, detta “il dormitorio”, era lunga 94 palmi e larga 27, ed era formata da sei camere con quattro officine sottostanti. Circondava il piccolo complesso religioso un orto dell’estensione di circa una tomolata di terra, chiuso e coltivato a giardino per uso degli stessi frati. In esso crescevano numerosi alberi da frutto, tra cui alcuni fichi, e dei gelsi. Soppresso alla metà del Seicento, rimase la chiesa dedicata a Santa Maria delle Grazie.[xxxv] Alla metà del Settecento la “Cappella di Santa Maria delle Grazie sotto titolo di Rettoria”[xxxvi] possedeva “un orto alberato di celzi neri nel luogo d.o il Giardino confinante con le mura di d(ett)a Cappella”.[xxxvii]
La cisterna (dentro le mura)
Sempre nella supplica a re Ferdinando del 12 ottobre 1491 l’università chiede oltre di per poter riparare le mura della città di costruire una cisterna in quanto “… dicta Città et districto de mura, la estate multo pate de acqua …”.[xxxviii]
La Noce (dentro le mura)
Paolo Corroccio, massaro di anni 42, ha “un orto dentro la Città alborato di celzi neri” nel luogo detto “la Noce”. L’orto confinava da ogni parte con la via pubblica.[xxxix]
Palazzo (dentro le mura)
La Cappella del SS.mo Sacramento possiede “due piedi di celzi neri siti e posti dentro d(ett)a Città nel luogo d(ett)o innanzi al Palazzo”.[xl]
Grotte (dentro le mura)
Il luogo detto “la Grotta” o “le Grotte” era situato presso la piazza e vi erano alcuni piccoli orti alberati di gelsi neri; tra questi quello del massaro Francesco di Domenico[xli] e quello del Capitolo della cattedrale.[xlii]
Jocaturo (dentro le mura)
Alla metà del Settecento nel luogo detto “Jocaturo” vi era l’orticello del massaro Giuseppe Grande.[xliii] Nello stesso luogo il nobile di San Giovanni in Fiore Rosalbo Benincasa vi aveva una casetta, due casaleni ed un piccolo orto, alberato di gelsi neri e fichi. La casetta, che confinava con la casa del canonico Arietta, era affittata come “bottega di Pignatajo” al mastro Andrea Greco di Cariati.[xliv]
Le chiese Parrocchiali
Secondo le testimonianze dei suoi vescovi, all’inizio del Cinquecento, la città di Cerenzia era popolosa e florida, ma fu distrutta al tempo della peste nel 1528. In quel frangente molte scritture della chiesa furono bruciate ed altre, furtivamente sottratte, andarono perdute. I superstiti fuggirono dalla città, numerose case rovinarono e cadde anche il campanile della cattedrale.
La città allora era divisa nelle cinque parrocchie di S. Martino, S. Maria de Plateis, S. Marina, S. Dominica e S. Nicolò. A causa dello spopolamento e della povertà si cercò dapprima di unirne le rendite, poi le chiese vennero abbandonate e decaddero.
I parrocchiani “per familias” di ognuna delle chiese curate, furono assegnati alle quattro dignità della cattedrale (decanato, arcidiaconato, cantorato e tesorerato) ed ad un canonico. Così il decanato ebbe annessa la cura delle anime della chiesa parrocchiale di San Martino, il tesorerato quelle di San Nicola, il canonicato quelle di Santa Maria de Plateis e l’arcidiacono ed il cantore quelle di Santa Marina e Santa Dominica.
Ad essi furono anche assegnate le rispettive rendite. L’anno, in cui avvenne questa riorganizzazione, rimane sconosciuto, in quanto “non vi è archivio né scrittura alcuna”; nel 1560 esse esistevano ancora, ma certamente l’evento è collocabile pochi anni dopo.
Chiesa di Santa Maria della Piazza (dentro le mura)
La chiesa parrocchiale di Santa Maria de Plateis è già richiamata in un breve di papa Clemente VII del 10 novembre 1530. Col Breve il Papa nominava Pignerio Protopapa, rettore della chiesa, che era unita con la chiesa parrocchiale di Santa Domenica della stessa città di Cerenzia.[xlv]
Alla metà del Settecento la chiesa parrocchiale di Santa Maria della Piazza è sotto la cura del Rev.do D. Carlo La Macchia canonico curato della cattedrale.[xlvi] La chiesa è richiamata anche all’inizio dell’Ottocento nel testamento di Elisabetta Iaquinta, figlia del fu Bernardo, domiciliata in Cerenzia, che abita in una casa sita nel rione detto Palarocca. La Iaquinta vuole essere seppellita nella chiesa di Santa Maria della Piazza.[xlvii]
Chiesa di Santa Dominica (parrocchiale dentro le mura)
10 novembre 1530. (Clemente VII) “Ad futuram rei memoriam. Pro Pignerio Protopapa, rectore parochialis ecclesiae S. Mariae de Plateis, Gerentin. Civ., unio parochialis ecclesiae S. Dominicae, eiusdem civ., dictae parochiali ecclesiae S. Mariae, ad eius vitam seu in casu dimissionis”.[xlviii]
Chiesa di San Martino (parrocchiale dentro le mura)
Chiesa Parrocchiale (1560). Luglio 1662 (Alessandro VII) De Decanatu, qui inibi est dignitas post pontificalem maior, in ecclesia Geruntin., cui cura animarum parochialis ecclesiae S. Martini annexa est, cuius fructus X duc., vac. per dimissionem Petri Ant. (de) Paterno, in manibus Ordinarii de mense Iulii 1661 factam et admissam, providetur Caesari Benincasa, pbro dictae dioc., cum decreto dimittendi canonicatum, quem obtinet in eadem ecclesia.”[xlix] Cappella di San Martino sotto la cura del Decano D. Arcangelo Oliverio curato di essa.[l]
Chiesa di Santa Marina (parrocchiale dentro le mura)
Chiesa parrocchiale di Santa Marina (1560).[li]
Chiesa di Santo Nicola (parrocchiale dentro le mura)
Chiesa parrocchiale di Santo Nicolò (1560).[lii] Alla metà del Settecento erano ancora visibili i ruderi. Domenico Venneri della Città di Cariati possiede “una casa palaziata sita dentro d.a Città consistente in sei membri, tre di essa superiori e tre inferiori, confina con un giardino del med(esimo) Venneri, e la Chiesa diruta di S. Nicola e via publica, quale serve per propria quando suol portarsi in d.a Città.”[liii] Cappella di San Nicola sotto la cura del Rev.do Tesoriero D. Giuseppe Cavallo.[liv]
Le abitazioni
Nel rione Palarocca abita la maggior parte della popolazione, che è composta da braccianti. Quasi tutte le abitazioni sono costituite da casette “a piede piano”, ma non mancano alti e bassi.
Nel catasto onciario, le casette “a piede piano” raramente sono descritte; il compilatore si limita a scrivere: “bracciale … possiede la casa ove abita”. Le casette “a piede piano” compaiono in alcuni atti notarili dei primi anni dell’Ottocento. Serafina Noce, vedova di Giuseppe Mauro, e Maria Mangone decidono nel dicembre del 1805 di permutare le loro case. La Noce ha una “casa a piede piano”, confinante con la casa di Agostino di Fazio e la Mangone pure una “casa a piede piano”, confinante con la casa del Reverendo sacerdote D. Domenico Quattromani.[lv]
Tra le case composte da un alto e basso c’è quella del massaro Paolo Corroccio (“due casette con un basso”),[lvi] quelle possedute dalla Cappella del SS. Sacramento (“una casetta col basso. La stanza soprana sta affittata ad Antonio Pantusano. Più una casa seu casaleno diruta”),[lvii] di Antonio Guarasci di S. Giovanni in Fiore (“una casa consistente due stanze superiori ed un basso”),[lviii] di Bernardo Iaquinto di S. Giovanni in Fiore (“una casetta bassa”),[lix] della mag.ca Costanza Spina, vedova del fu Francesco Papaleo di Cerenzia (“la presente camera, ove al presente abita col suo rispettivo basso, e propriamente quella con vignano, e finestra, confine quella di Agnesa Scarpino, via publica … . Una bottega sita nella Piazza, e proprio sotto la casa dell’eredi del fu Francesco Basile),[lx] di Maria Spina (“Una casa con logetta escluso però il basso solo di detta casa perché legitimamente vien posseduto da altri per franca e libera”).[lxi]
Le case palaziate
I bracciali, che compongono la maggior parte della popolazione attiva, abitano in casette basse; gli ecclesiastici, i nobili ed i massari in case palaziate, composte da uno o più alti con i rispettivi bassi, con stalla, orto, trappeto, forno, ecc.
Il canonico Domenico Arietta ha “una casa palaziata, un basso seu trappeto per macinar olive confinante con un suo basso per comodo di stalla, un orto adiacente alla casa”;[lxii] Antonio Oliverio della Terra di San Giovanni in Fiore, “una casa palaziata consistente in due membri superiori ed un basso”;[lxiii] il reverendo Giuseppe Aloe “una stalla confinante con un orticello” e “una casa palaziata confinante la casa del Rev. Arcidiacono Mascari ed un orticello confinante la stalla alborato di fichi ed altri alberi fruttiferi”;[lxiv] Domenico Venneri della Città di Cariati “una casa palaziata sita dentro d(ett)a Città consistente in sei membri, tre di essa superiori e tre inferiori, confina con un giardino del med(esimo) Venneri, e la Chiesa diruta di S. Nicola e via publica, quale serve per propria abitazione quando suol portarsi in d.a Città”;[lxv] l’ arcidiacono Francesco Mascari “una casa per sua abitazione consistente in tre camere e tre bassi”;[lxvi] il sacerdote Donato Calogiuri “una casa dove abita consistente in quattro membri”;[lxvii] ecc.
I magazzini
All’interno della città ci sono dei magazzini, alcuni sotto le abitazioni, tra i quali quello del nobile vivente Gennaro Vencia,[lxviii] della vedova Isabella Gentile (“un magazeno sotto la sua casa”),[lxix] di Gio. Battista Marra, mastro di casa dell’Ill.re Principe di Cerenzia, (un magazzino affittato a Tomaso Oliverio),[lxx] del nobile vivente Matteo Grande di Savelli,[lxxi] i due dotali di Francesca Spina, figlia del fu Tomaso Spina e di Felice Bufona, che va sposa a Donato Caligiuri,[lxxii] ecc.
Le stalle
Per uso di stalla si usa il basso della casa o una costruzione accanto ad essa. Tra i proprietari di stalle ricordiamo il massaro Domenico Susanna (“una stalla, seu basso”),[lxxiii] la vedova Porzia Pugliese,[lxxiv] il reverendo Giuseppe Aloe (“una stalla confinante con un orticello” e “una casa palaziata confinante la casa del Rev. Arcidiacono Mascari ed un orticello confinante la stalla alborato di fichi ed altri alberi fruttiferi”),[lxxv] il canonico Domenico Arietta (“una casa palaziata, un basso seu trappeto per macinar olive confinante con un suo basso per comodo di stalla, un orto adiacente alla casa”),[lxxvi] ecc.
Gli orti
All’interno della città esistevano numerosi orti e orticelli accanto alle abitazioni. Gasparo Caligiuri bracciale, possiede “un orto dentro il ristretto, seu abitazione un moggio alberato con celzi neri circondato da vie publiche”.[lxxvii] Giuseppe Pugliese bracciale, un orticello.[lxxviii] Tomaso Oliverio nobile vivente, “un orto alberato di celzi neri e fichi d’estenzione un’ottava di terra”.[lxxix] Giulio Marulli nobile vivente, un orticello vicino la casa di sua abitazione con un piede di fichi.[lxxx] I coniugi Giovanni d’Urzo e Dorotea Caligiuri, “una casetta bassa con furno diruto al di fuori” attaccata alla casa di Giovanni Spina, e “quella di detti costit(ut)i D’Urzo e Caligiuri” poiché minaccia rovina e per altri motivi ,è venduta per ducati otto a Vincenzo Pugliese.[lxxxi]
I trappeti
Elisabetta Grande promette alla figlia Anna Maria Greco, che sposa Antonio Fabiano, “una casa col suo basso ove attualmente abita e proprio quella di mezzo col focone e la terza parte della terza parte del trappido, che possiede entro questa Città, e proprio nella Piazza”.[lxxxii] Il canonico Domenico Arietta possiede “una casa palaziata, un basso seu trappeto per macinar olive confinante con un suo basso per comodo di stalla, un orto adiacente alla casa”).[lxxxiii] Domenico Venneri della Città di Cariati, oltre a “due piedi di celzi neri”, ha anche “un trappeto”.[lxxxiv] Il massaro Paolo Corroccio possiede un trappeto da macinar olive.[lxxxv]
La forgia
Il Tesoriere della Cattedrale Don. Giuseppe Gallo possiede una casa per uso e comodo di sua abitazione nella quale vi è una forgia per lavorar ferro.[lxxxvi]
La Rupicella (fuori le mura)
Sotto le timpe della città vi è il luogo detto “la Rupicella” attraversato dalla via pubblica. Ci sono l’orticello del bracciante Filippo Greco, che confina con le “due ottave di terra arbustata di fiche selvatiche” del nobile Giulio Marulli, e la proprietà di Filippo Greco.[lxxxvii]
Le Pesche (fuori mura)
Gennaro Fazio bracciante di anni 60 possedeva un orticello nel luogo detto Le Pesche d’estensione un quarto di tomolata confinante coll’orto di Cesare Dramis.[lxxxviii]
Milio (fuori le mura)
Antonio Talarico Apprezzatore di anni 50, possedeva un orticello sotto la timpa di Milio.[lxxxix]
Sant’Angelo (fuori le mura)
Orti con alberi fruttiferi e querce erano situati anche in località Sant’Angelo. Il massaro Giuseppe Marulli vi possedeva un orticello,[xc] il Capitolo “un ortale d’estensione due ottave di moggio alberato di quercie”,[xci] la Cappella di San Giovanni Battista “un ortale di estensione due ottave di terra alberato di pochi alberi fruttiferi”, confinante con i beni di Onofrio Longo.[xcii]
Racimuci-Rasimuti (fuori le mura)
Alla metà del Settecento la più vasta area ortiva della città di Cerenzia era situata in località “Racimuci”. In questo luogo erano situati molti orti ed orticelli, alberati di gelsi neri e fichi, e piccole vigne. Vi era, o vi era stata, una cisterna.
Il massaro Francesco di Domenico aveva una vigna di poca estensione,[xciii] il massaro Giuseppe Grande un orto”di minima capacità”,[xciv] il sarto “un piede di celzo nero”,[xcv] il canonico D. Pietro Domenico Pergulo un orticello,[xcvi] il Capitolo “un ortale d’estensione mezzo moggio nomato La Cisterna o sia Racimuci” ed un orto di “picciola estensione alberato di celzi neri”,[xcvii] Domenico Venneri della città di Cariati “un orticello alborato con pochi piedi di celzi neri e fichi”,[xcviii] il Cantorato un orticello,[xcix] la Cappella di San Giovanni Battista “un ortale alberato di celzi neri”,[c]( la Cappella di Sant’Agostino “un ortale alborato con pochi pedi di celzi neri”.[ci]
Marcorizzo (fuori le mura)
Tomaso Oliverio nobile vivente di anni 30 possedeva un orto detto di Marcorizzo alberato di celzi negri d’estensione mezzo tomolo confinante da ogni parte con la via publica.[cii]
Annunziata
Gennaro Vencia, nobile vivente di anni 18, possedeva un orticello nel luogo detto “avanti l’Annunciata”, confine la via pubblica.[ciii]
San Biase (fuori le mura)
Onofrio Longo bracciale di a. 48 possiede un orto nel luogo detto S. Biase, alberato di celzi neri confinante con i beni del Rev. Capitolo di questa Città, e Giuseppe La Portella.[civ] Il Capitolo della città di Cerenzia possiede un ortale d’estensione mezzo moggio alberato di celzi neri nel luogo detto S. Biase confinante con i beni della Principale Camera e D. Onofrio Longo.[cv]
La Cotria (fuori le mura)
Il Capitolo della città di Cerenzia possiede un ortale d’estensione ottave sei di moggio nel luogo detto la Cotria alberato con piedi di celzi neri confinante con i beni della Principale Camera e via publica.[cvi]
Chiese, cappelle e luoghi pii della Città di Cerenzia (1753)
Capitolo della Chiesa sotto il titolo di S. Teodoro. Mensa Vescovile. Cappella di S. Rocco. Cappella di S. Martino. Cappella di S. Nicola. Cappella di S. Giacinto (dentro la Cattedrale). Cappella del SS.mo Sacramento (dentro la Cattedrale). Cappella di San Francesco di Paola (dentro la Cattedrale). Cappella di Santa Maria della Piazza. Cappella di Santa Maria delle Grazie. Cappella di S. Lorenzo. Arcidiacono della Cattedrale. Cantorato. Cappella di S. Andrea. Cappella di S. Antonio Abate. Cappella di S. Giovanni Battista. Congregazione della S. Croce. Cappella di S. Agostino.[cvii]
Note
[i] Marafioti G., 203v.
[ii] ASV, SCC, Rel. Lim. Cariaten. et Geruntin. 1725.
[iii] Alfano G. M., Istorica, 80.
[iv] Trinchera F., Codice aragonese, Vol. III, pp. 222-223.
[v] AASS, prot. Santoro, VI, 226.
[vi] AASS, prot. Santoro, VI, 226.
[vii] ASN, R.C.S. Catasti Onciari, B. 6964, Cerenzia 1753, f. 41.
[viii] ASN, Catasto cit. 1753, f. 58r.
[ix] ASV, SCC. Relatio status ecclesiae Geruntin. et Cariaten., facta a Propertio Resta episcopo, 1589.
[x] “Ecclesia Cathedralis sub titulo S. Theodori Martiris aedificata in promontorio extra Civitatem, est coniuncta Palatio Episcopali”. ASV, SCC, Rel. Lim. Cariaten. et Geruntin. 1733.
[xi] ASN, Catasto cit. 1753, f. 64v.
[xii] ASN, Catasto cit. 1753, f. 65v.
[xiii] ASN, Catasto cit. 1753, f. 66r.
[xiv] ASV, SCC. Relatio cit. 1589.
[xv] ASCZ, Notaio Caligiuri M., 1805, f. 52.
[xvi] ASN, Catasto cit. 1753, ff. 60v, 62r, 69r.
[xvii] ASN, Catasto cit. 1753, f. 92r.
[xviii] ASN, Catasto cit. 1753, f. 75v.
[xix] ASN, Catasto cit. 1753, f. 78v.
[xx] ASCZ, Notaio Caligiuri M., 1804, f. 14.
[xxi] ASCZ, Notaio Caligiuri M., 1805, f. 23.
[xxii] ASCZ, Notaio Caligiuri M., 1808, f. 15.
[xxiii] ASCZ, Notaio Caligiuri M., 1809, f. 26.
[xxiv] ASN, Catasto cit. 1753, f. 6v.
[xxv] ASN, Catasto cit. 1753, f. 7v
[xxvi] ASN, Catasto cit. 1753, f. 20r.
[xxvii] ASN, Catasto cit. 1753, f. 75v
[xxviii] ASCZ, Notaio Caligiuri M., 1804, ff. 12-14.
[xxix] ASCZ, Notaio Caligiuri M., 1806, f. 48.
[xxx] ASN, Catasto cit. 1753, f. 3v-4r.
[xxxi] ASCZ, Notaio Caligiuri M., 1803, f. 10.
[xxxii] ASCZ, Notaio Caligiuri M., 1805, ff. 15-17.
[xxxiii] ASCZ, Notaio Caligiuri M., 1808, f. 9.
[xxxiv] ASCZ, Notaio Caligiuri M., 1805, f. 52
[xxxv] Pesavento A., Il convento domenicano di Santa Maria delle Grazie di Cerenzia, www.archiviostoricocrotone.it
[xxxvi] ASN, Catasto cit. 1753, 68r.
[xxxvii] ASN, Catasto cit. 1753, f. 69r.
[xxxviii] Trinchera F., Codice cit.
[xxxix] ASN, Catasto cit. 1753, f. 53.
[xl] ASN, Catasto cit. 1753, f. 66r.
[xli] ASN, Catasto cit. 1753, f. 7v.
[xlii] ASN, Catasto cit. 1753, f. 60v.
[xliii] ASN, Catasto cit. 1753, f. 9r.
[xliv] ASN, Catasto cit. 1753, f. 78v.
[xlv] “Ad futuram rei memoriam. Pro Pignerio Protopapa, rectore parochialis ecclesiae S. Mariae de Plateis, Gerentin. Civ., unio parochialis ecclesiae S. Dominicae, eiusdem civ., dictae parochiali ecclesiae S. Mariae, ad eius vitam seu in casu dimissionis”, Russo F., Regesto, 16924.
[xlvi] ASN, Catasto cit. 1753, f. 67r.
[xlvii] ASCZ, Notaio Caligiuri M., 1813, f. 10.
[xlviii] Russo F., Regesto, 16924.
[xlix] Russo F., Regesto, 39620.
[l] ASN, Catasto cit. 1753, f. 64v.
[li] AASS, 16B. Pesavento A., La cattedrale e le chiese di Cerenzia in una visita del 1560, www.archiviostoricocrotone.it
[lii] AASS, 16B. Pesavento A., La cattedrale e le chiese di Cerenzia in una visita del 1560, www.archiviostoricocrotone.it
[liii] ASN, Catasto cit. 1753, f. 75r.
[liv] ASN, Catasto cit. 1753, f. 65r.
[lv] ASCZ, Notaio Caligiuri M., 1805, ff. 15-17.
[lvi] ASN, Catasto cit. 1753, f. 53r.
[lvii] ASN, Catasto cit. 1753, f. 66r.
[lviii] ASN, Catasto cit. 1753, f. 72v.
[lix] ASN, Catasto cit. 1753, f. 73v.
[lx] ASCZ, Notaio Caligiuri M., 1804, ff. 12-14.
[lxi] ASCZ, Notaio Caligiuri M., 1805, f. 37.
[lxii] ASN, Catasto cit. 1753, f. 57r.
[lxiii] ASN, Catasto cit. 1753, f. 72r.
[lxiv] ASN, Catasto cit. 1753, f. 54v.
[lxv] ASN, Catasto cit. 1753, f. 75r.
[lxvi] ASN, Catasto cit. 1753, f. 56r.
[lxvii] ASN, Catasto cit. 1753, f. 58v.
[lxviii] ASN, Catasto cit. 1753, 15v.
[lxix] ASN, Catasto cit. 1753, f. 24r.
[lxx] ASN, Catasto cit. 1753, f. 34v.
[lxxi] ASN, Catasto cit. 1753, f. 37r.
[lxxii] ASCZ, Notaio Caligiuri M., 1807, f. 10.
[lxxiii] ASN, Catasto cit. 1753, f. 1v.
[lxxiv] ASN, Catasto cit. 1753, f. 26r.
[lxxv] ASN, Catasto cit. 1753, f. 54v.
[lxxvi] ASN, Catasto cit. 1753, f. 57r.
[lxxvii] ASN, Catasto cit. 1753, f. 12r.
[lxxviii] ASN, Catasto cit. 1753, f.13v.
[lxxix] ASN, Catasto cit. 1753, f. 21r.
[lxxx] ASN, Catasto cit. 1753, f. 50v.
[lxxxi] ASCZ, Notaio Caligiuri M., 1803, ff. 1-2.
[lxxxii] ASCZ, Notaio Caligiuri M., 1806, f. 48.
[lxxxiii] ASN, Catasto cit. 1753, f. 57r.
[lxxxiv] ASN, Catasto cit. 1753, f. 75v.
[lxxxv] ASN, Catasto cit. 1753, f. 53r.
[lxxxvi] ASN, Catasto cit. 1753, f. 54r.
[lxxxvii] ASN, Catasto cit. 1753, ff. 42r, 51.
[lxxxviii] ASN, Catasto cit. 1753, f. 51v.
[lxxxix] ASN, Catasto cit. 1753, f. 49r.
[xc] ASN, Catasto cit. 1753, f. 49v.
[xci] ASN, Catasto cit. 1753, f. 60.
[xcii] ASN, Catasto cit. 1753, f. 84v.
[xciii] ASN, Catasto cit. 1753, f. 7v.
[xciv] ASN, Catasto cit. 1753, f. 9r.
[xcv] ASN, Catasto cit. 1753, f. 20r.
[xcvi] ASN, Catasto cit. 1753, f. 55r.
[xcvii] ASN, Catasto cit. 1753, f. 60.
[xcviii] ASN, Catasto cit. 1753, f. 75v.
[xcix] ASN, Catasto cit. 1753, f. 83v.
[c] ASN, Catasto cit. 1753, f. 84v.
[ci] ASN, Catasto cit. 1753, f. 86r.
[cii] ASN, Catasto cit. 1753, f. 21.
[ciii] ASN, Catasto cit. 1753, f. 15v.
[civ] ASN, Catasto cit. 1753, f. 18v.
[cv] ASN, Catasto cit. 1753, f. 60.
[cvi] ASN, Catasto cit. 1753, f. 60.
[cvii] ASN, R.C.S. Catasti Onciari, B. 6964, Cerenzia 1753.
The post Descrizione e toponomastica della città antica di Cerenzia appeared first on Archivio Storico Crotone.
La famiglia Lilio nella Cirò del XVI secolo

La tavola della biccherna, n. 72. Archivio di Stato Siena. Tempera su tavola, cm 52,4×67,8. Il dipinto, di autore sconosciuto, rappresenta Gregorio XIII che, assiso in trono, presiede la commissione del calendario. Intorno al tavolo, sul lato destro, diverse personalità del clero, laici e lo studioso orientale Ignazio Nehemet, sono ritratte mentre sono impegnati in una vivace discussione. Il personaggio in piedi, potrebbe trattarsi di Antonio Lilio oppure di Cristoforo Clavio, indica con una bacchetta l’arco inferiore della sezione di un diagramma corrispondente all’anno tropico, mentre l’arco superiore rappresenta un segmento dell’anno calendariale diviso in giorni. In corrispondenza dei segni zodiacali della Bilancia e dello Scorpione sono indicati i dieci giorni, compresi tra il 5 e il 15 ottobre dell’anno solare, che furono tolti dal calendario.
Luigi Lilio
A Luigi Lilio di Cirò, medico, matematico e astronomo del XVI secolo, dobbiamo una svolta fondamentale nella storia del computo del tempo, quella legata all’introduzione del calendario gregoriano, che dal 1582 in poi ha radicalmente cambiato il nostro modo di scandire giorni, mesi e anni. Il calendario da lui elaborato è quello che ancora adoperiamo dopo circa mezzo millennio e permette di determinare senza incertezze e per sempre le date della Pasqua.
Nel corso dei secoli la discordanza tra le date del calendario giuliano, in vigore dal 46 a.C., e l’equinozio di primavera, impone la necessità di correggere le regole adottate per registrare il computo del tempo. Di questo problema soffre in particolare la Chiesa Cattolica che già dal Concilio di Nicea del 325 aveva legato al novilunio e all’equinozio di primavera il suo mistero fondamentale: la Resurrezione di Cristo.
I Padri del Concilio di Nicea avevano stabilito che la Pasqua di Resurrezione doveva essere celebrata nella domenica seguente alla XIV Luna (plenilunio) del primo mese dopo l’equinozio di primavera. Ma, nella metà del 1500, il calendario giuliano aveva segnato come giorno dell’equinozio il 21 marzo, ma gli astri l’avevano segnato l’11 marzo cioè circa 10 giorni prima. In considerazione di ciò la Pasqua veniva celebrata nel periodo astronomicamente non corretto. Si trattava quindi di correggere le regole adottate per registrare il tempo e contemporaneamente evitare che l’equinozio astronomico di primavera rimanesse indietro, rispetto al calendario civile, com’era successo nel corso dei secoli. Appare ormai improcrastinabile la riformulazione del calendario, ma è un compito arduo da svolgere.
Papa Gregorio XIII subito dopo il suo insediamento, al fine di mantenere in tutte le nazioni cristiane l’armonia nella celebrazione della Pasqua, e di tutte le feste mobili che ne discendono, nominò una Commissione col mandato specifico di valutare e approvare un progetto di riforma del Calendario.
La Commissione valutò diverse proposte, ma l’attenzione si concentrò su un ingegnoso progetto di riforma che era stato elaborato da Luigi Lilio. Il progetto, presentato dal fratello Antonio, permetteva di mantenere l’equinozio di primavera in una data fissa e certa, il 21 marzo, e consentiva di determinare con precisione la data della Pasqua. La Commissione accettò definitivamente il lavoro di Lilio che il 5 gennaio 1578 venne stampato in forma di Compendium e inviato alla comunità scientifica e a tutti i Principi cristiani, affinché esprimessero un preciso parere. Nel 1582, con la bolla papale “Inter gravissimas”, Gregorio XIII impose al mondo l’adozione del Calendario elaborato da Lilio.
La grandezza dell’astronomo di Cirò appare evidente se si considera che nel Cinquecento mancavano le leggi dei modelli planetari, i metodi della fisica e gli strumenti della matematica. Essi vedranno la luce non molti anni dopo grazie a Brahe, Keplero, Galileo e Newton, ma al momento non erano disponibili. Le frazioni decimali non erano ancora in uso, ma per una strana coincidenza lo saranno dal 1582 in poi, e solo a partire dal 1593 viene progressivamente introdotto un simbolo come la virgola per indicare i numeri decimali. Nonostante queste limitazioni, Lilio ebbe il merito di essere giunto alla soluzione di un problema, quello del calendario, che sembrava irrisolvibile e che per molti secoli aveva tenuto occupati insigni astronomi e studiosi come Copernico, senza riuscire a venirne a capo.
Mediante due equazioni accorda i due cicli, solare e lunare, e propone un originale ed efficace ciclo delle epatte che permette di stabilire la data della Pasqua di qualsiasi anno. I suoi calcoli offrono al contempo un potentissimo strumento di calcolo che permette di adattare il calendario alla variazione della durata dell’anno tropico che si verifica nel corso dei secoli, mentre le date della Pasqua sono sincronizzate all’equinozio di primavera per altri 5 miliardi di anni. Il Calendario di Lilio si accorda con l’inclinazione esatta dell’asse terrestre rispetto al sole e di conseguenza con i cicli delle stagioni.
Per i suoi conti Lilio si affida a dati astronomici approssimati, contenuti in tavole compilative ormai vecchie di tre secoli. Le difficoltà astronomiche da risolvere riguardavano sia il moto apparente del Sole, sia il moto relativo della Luna. Si trattava di sincronizzare il tempo civile con gli indicatori celesti, mantenendo un vincolo inamovibile: la data dell’equinozio di primavera, convenzionalmente fissata in modo perenne il 21 marzo. Luigi Lilio riuscì in questa difficile impresa elaborando un calendario così perfetto da sfidare i secoli.
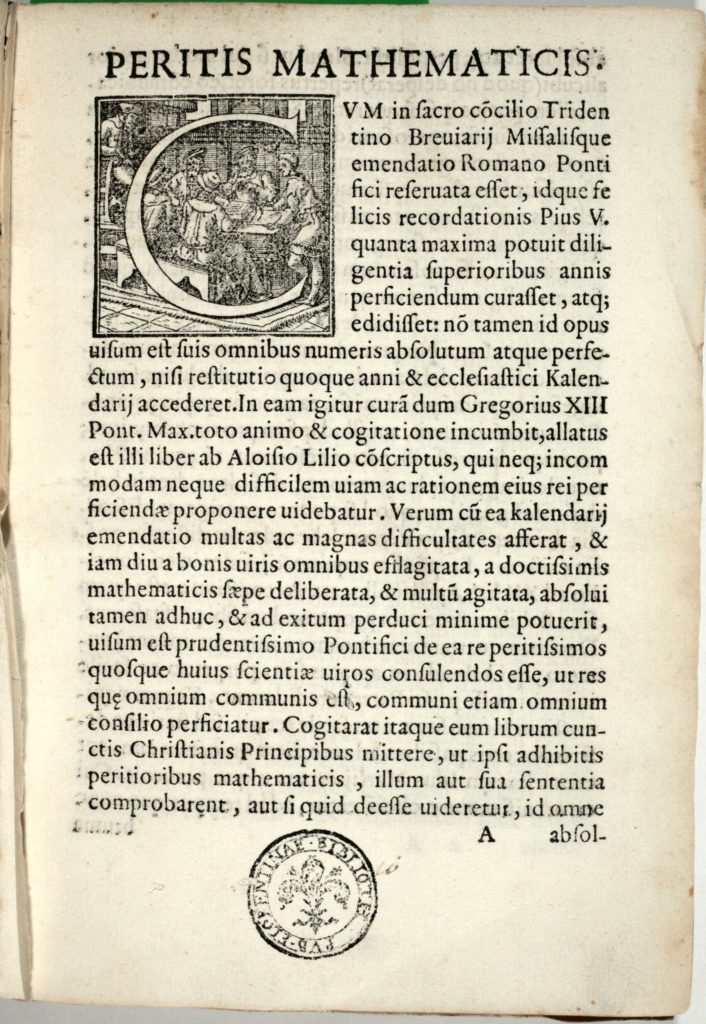
Compendium novae rationis restituendi Kaledarium. Romae Apud haeredes Antonij Bladij impressores camerales, 1577. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, MAGL.12.6.59 Il raro documento, ritrovato per la prima volta dallo storico Gordon Moyer nel 1981, su indicazione di Thomas Settle del Polytechnic Institute of New York, è conservato presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. L’opera, si trova anche nella biblioteca Marucelliana di Firenze, nella biblioteca degli Intronati di Siena e nella Biblioteca Vaticana.
Brevi cenni biografici
Lilio nacque presumibilmente nel 1510 a Psycrò, oggi Cirò, un ricco feudo che faceva parte della Calabria Citeriore. Cirò, nel XVI secolo, fu signoria della potente famiglia dei Carafa della Spina che nel 1496 comprarono il feudo dalla famiglia Ruffo.[1]
I dati biografici di Luigi Lilio sono incerti perché i registri anagrafici dell’archivio comunale di Cirò risalgono ai primi anni del 1800, mentre quelli parrocchiali, che sono i più antichi, risalgono al Seicento.[2]
Luigi Lilio ebbe almeno un fratello, Antonio, con cui condivise l’interesse per gli studi scientifici. Sono poche le vicende note della sua esistenza, tanto che in passato ne è stata persino messa in dubbio l’origine calabrese. Il Cardinale Arrigo Noris (1631-1704), l’astronomo Francesco Levera (1681-1694 e Jean-Étienne Montucla (Histoire des Mathématiques 1759) lo confondono con il veronese Lilio Gregorio. L’astronomo Delambre in Histoire de l’Astronomie moderne del 1812, lo equivoca con Luigi Lilio Giraldi di Ferrara, autore di De Annis et Mensibus scritto nel 1541. Norbert Elias, una delle più grandi figure della sociologia del secolo scorso, autore del Saggio sul tempo (1986), lo vuole napoletano. Secondo Bartolomeo da Fano (1582) era perugino. Qualcuno era convinto che fosse romano, secondo altri di Strongoli, mentre lo storico e drammaturgo Scipione Maffei (1675-1755) lo dice di Umbriatico, che in realtà era la curia vescovile in cui allora insisteva Cirò; poiché nella corrispondenza gli ecclesiastici usavano l’indirizzo generico diocesano, era facile che un cittadino di Cirò venisse equivocato come nativo di Umbriatico. A dissipare ogni dubbio, che Cirò dette i natali a Luigi Lilio, è sufficiente leggere quanto scrisse nel 1603 il gesuita tedesco Cristoforo Clavio, matematico e membro della Commissione istituita da Gregorio XIII per studiare la riforma del calendario:
“E magari fosse ancora vivo Aloysius Lilius di Cirò uomo più che degno di immortalità, che fu il principale autore di una correzione tanto valida e risplendette sugli altri grazie alle cose da lui scoperte.”[3]
Altra prova inconfutabile che Cirò dette i natali a Lilio è fornita dall’umanista Giano Teseo Casopero, che in una lettera inviata allo stesso Luigi Lilio lo prega di porgere un saluto ai compaesani che dimoravano in Napoli: “nostratibus omnibus qui Neapoli degunt ex me salutem dica”.[4] Nulla era noto delle condizioni sociali della sua famiglia di origine di cui sembrava essersi persa ogni traccia. Secondo alcuni era nato da modesti genitori, secondo altri da modesti genitori non privi di una certa agiatezza o da nobile e ricca famiglia. Supposizioni non suffragate da alcuna evidenza documentaria.
L’unico documento di cui disponevamo sulla presenza della famiglia Lilio a Cirò era una lettera datata 1535 che il poeta Casopero scrisse all’amico Girolamo Tegano. Casopero nella lettera segnalò trentaquattro famiglie primarie di Cirò, tra cui quella dei Gigli (Lilÿs nel testo)[5] la famiglia appunto di Antonio e Luigi Lilio. Da allora la famiglia Lilio sembrava essere scomparsa nel nulla.
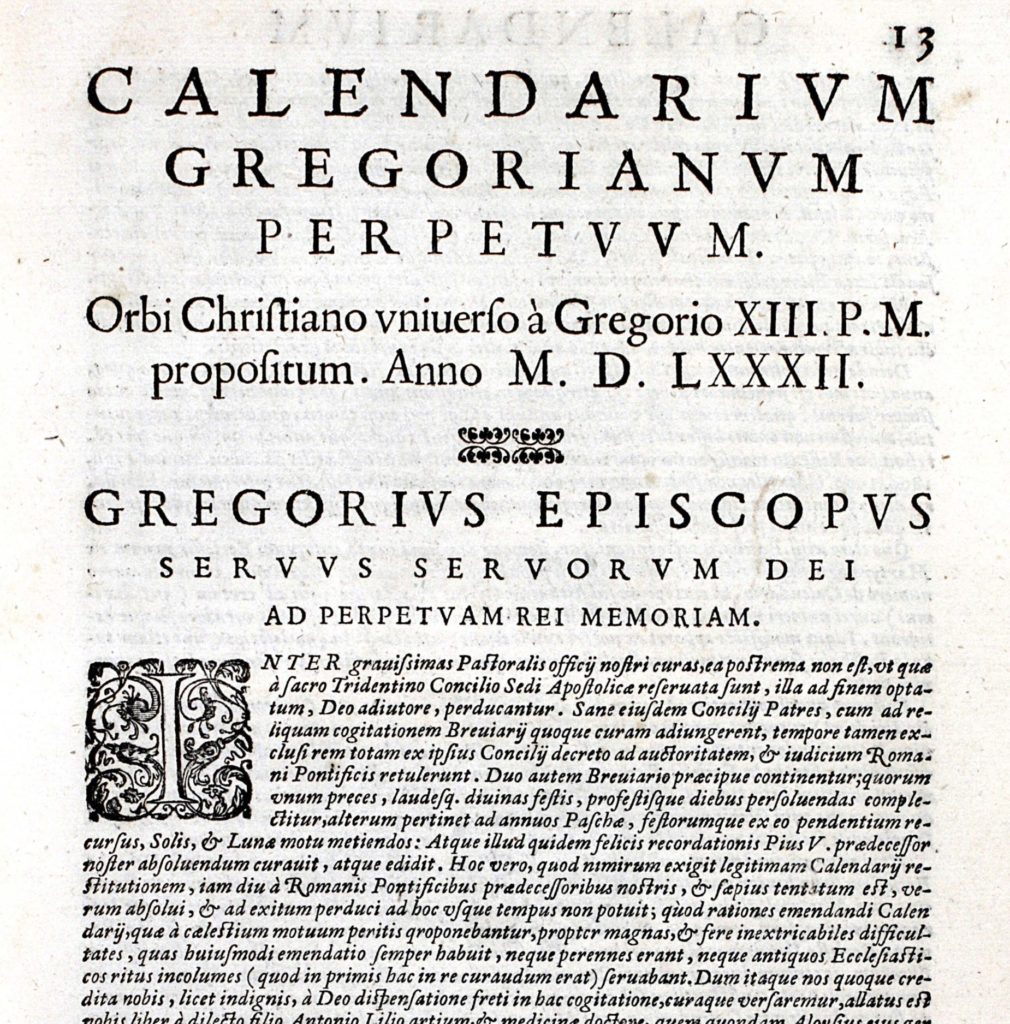
Bolla Inter gravissimas. Viene riportata la copia della bolla stampata contenuta nell’opera di Cristoforo Clavio Romani calendarij a Gregorio XIII P.M. restituti explicatio. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, MAGL.5.1.117. La bozza della bolla è stata scritta nell’autunno del 1581 da Pedro Chacòn. La stesura finale è stata completata dal cardinale Vincenzo di Lauro, da Antonio Lilio e dai collaboratori di papa Gregorio XIII. Il giorno Sexto Calend. Martij Anno Incarnationis Dominae M.D.LXXXI, corrispondente al 24 febbraio 1582 del nostro calendario, Gregorio XIII nella Villa Mondragone firmò la bolla Inter gravissimas. Il 1° marzo 1582 il testo venne affisso alle porte della Basilica di S. Pietro, alle porte della Cancelleria Vaticana e nella piazza Campo dei Fiori.
Atti del notaio Baldo Consulo
Riferimenti ben precisi sulla famiglia Lilio a Cirò sono emersi recentemente da alcuni atti del notaio Baldo Consulo e del notaio Giovanni Alboccino, depositati presso l’Archivio di Stato di Catanzaro e rinvenuti da Pino Rende.[6]
Uno di questi atti notarili datato 3 settembre1574 riguarda un passaggio di denaro (120 ducati) tra il nobile Ferdinando Puglisio di Corigliano da una parte, e il nobile Gio: Battista de Amato e Joanne Susanna di Cirò dall’altra. L’atto è sottoscritto da Ant.no de liljo.[7] Un altro atto del notaio Consulo (8 luglio 1574) riguarda il matrimonio tra Actilio Papaioannes di Cirò e Laudonia Glisara figlia della m.ca Deca Glisara della città di Rossano. L’atto è sottoscritto da Ant.no de Liljo e Matteo de Liljo.[8] Questi due documenti rinvenuti dallo scrivente, attesterebbero la presenza della famiglia de Liljo a Cirò, ma non ci consentono di affermare con certezza se i due de Liljo: Antonio e Matteo, appartenessero alla famiglia di Luigi Lilio.
Altri documenti rinvenuti potrebbero aiutare a fugare questi dubbi. Un atto dello stesso notaio Consulo del 1573, riporta integralmente: “Il giorno 2 del mese di gennaio prima indizione 1573, nella terra di Cirò, innanzi a noi, per lettera, è costituito Antonino de Lilio della detta terra, che asserisce di dover conseguire da D. Petro Bordono, vescovo di Umbriatico, venti ducati che gli erano stati tutti mutuati in Roma per mano di Cesare de Lilio suo cugino. Il detto Antonino fa quietanza al detto vescovo poiché, innanzi a noi, riceve materialmente i venti ducati dal detto vescovo, e per esso, dal Reverendo Antonino Galeoto vicario generale che è presente. Sottoscrivono il giudice ed alcuni testi”.[9]
Il documento testimonia che Cesare Lilio, in quel periodo si trovava a Roma ed era ben inserito nelle alte sfere ecclesiastiche. Egli è impegnato in un passaggio di danaro tra la curia di Cirò e la curia di Roma per mezzo di Antonino, suo cugino. Quest’ultimo riceve il danaro dal vicario generale Antonino Galeoto e lo consegnerà a Cesare Lilio.
Un atto redatto dal notaio Consulo il 24 febbraio 1573 riporta: “Sylvester de Lilio, in relazione alla dote di donna Nicolae de Lilio sua sorella, promette “more graecorum” a Octavio Orifex, due casalini “sotto lo castello”, confinanti con il casalino di Cicco de Loysio, il casalino di Renzo Labalestra, le vie pubbliche da due lati ed altri fini”.[10]
Il matrimonio di tipo more graecorum era diffuso nei ceti sociali più alti: l’alienazione di dote e dotario era proibita. In caso di premorienza della moglie senza figli la dote veniva restituita alla famiglia della donna, mentre in caso di premorienza dell’uomo, alla vedova spettava la dote e il dotario.
Un altro atto notarile del 25 gennaio del 1573, tratta di Fran.co Bisantio che giunto ad un accordo con Ant.nus de lilio di Cirò, gli retrocede “la possessione loco detto s.to Blasio” che aveva acquistato all’incanto nel passato.[11]
Dal notaio Consolo apprendiamo pure che il 5 novembre 1576, Ant.o Abbas vendeva al magnifico Ant.o de Martino “hyspanus”, un “hortale” arborato con fichi sito in “loco dicto fulcuni sub rupe rictusae”, confinante da due lati, con gli “hortalia” dei magnifici de Liliis, il “vallonem dela rictusa” ed altri fini.[12]
I documenti sopra citati mostrano per la prima volta dopo quasi cinquecento anni la presenza della famiglia Lilio a Cirò nella seconda metà del Cinquecento. Una famiglia certamente agiata e di elevato rango sociale, da meritare l’appellativo di “magnifico”, termine che nel XVI e XVII secolo aveva perso il significato originario, ma che denotava comunque una superiore dignità della persona titolata.
I documenti sopra citati testimoniano la presenza di cinque membri della famiglia de Liljo o de Lilio: Antonino de liljo e Matteo De liljo, Cesare de Liljo cugino di Antonino de Lilio, Sylvester de lilio e sua sorella donna Nicolae de liljo.

Lunario Novo secondo la nuova riforma dell’anno. Il “Lunario Novo secondo la nuova riforma” è uno dei primi esemplari di calendari stampati in Roma dopo la riforma gregoriana. E’ custodito nell’Archivio Segreto del Vaticano A.A., Arm. I-XVIII, 5506, f. 362r. Si osservano nel calendario la mancanza dei giorni dal 5 al 14 del mese di ottobre, la firma autografa che riteniamo essere quella di Antonio Lilio ed in calce l’autorizzazione pontificia alla stampa Con licentia delli Superiori… et permissu Ant(onii) Lilij.
Variazioni del cognome Lilio
Una questione fondamentale ai fini della nostra indagine è quella di accertare se il cognome de Liljo, o de Lilio, di cui parlano gli atti del notaio Consulo, coincida col cognome Lilio-Lilius citato nei documenti ufficiali della riforma del calendario gregoriano.
Bisogna considerare che i moderni nomi di famiglia, o cognomi in senso stretto, si consolidarono diffusamente in tutti gli strati sociali a partire dai secoli XII e XIII. In Italia, come nel resto d’Europa, essi possono avere avuto un’origine “antroponomastica” (dal nome di un antenato, maschio o femmina); “toponomastica” (luogo di provenienza, aggettivo etnico, etc.); “soprannominale” (nome di mestiere o professione, soprannome scherzoso o allusivo a caratteristiche fisiche o morali, etc.).[13]
I notai nei documenti ufficiali in latino, specialmente quelli di età tardomedievale e moderna, generalizzavano per i cognomi (benché non esclusivamente) una marcatura di tipo sintattico: “de + toponimo, antroponimo o soprannome in ablativo”.[14] L’omissione della preposizione “de” (eccetto alcune sopravvivenze) ha dato origine alle forme dei cognomi odierni.
Accanto a questa costruzione con “de” convive il trattamento del cognome come termine aggettivale, o comunque appositivo, e perciò, per lo più, in “-us” per soggetti maschili e in “-a” per soggetti femminili.[15]
Ne consegue che “de Lilio” per oscillazione morfosintattica diventa Lilius, ed è ragionevole supporre che nei documenti ufficiali della riforma del calendario il cognome de Lilio abbia subito l’eliminazione della particella patronimica “de”.

Busto di Luigi Lilio presente nel Museo di Cirò. Realizzato da Giuseppe Capoano nel 2013.
Atti del notaio Giovanni Alboccino
L’ipotesi sopra esposta ha trovato conferma in 4 atti notarili, redatti in italiano, del notaio Giovanni Alboccino, rinvenuti nel 2018 da Pino Rende nell’Archivio di Stato di Catanzaro.
Nel primo documento si legge: “21 dicembre del 1586. Il no: Antoninus de giglio della terra di Cirò, vende al nobilis Francesco Aligia, un ortale con siccomis che deteneva in comune ed indiviso con gli eredi del quondam Sante Natale della terra di Crucoli, posto in territorio di Cirò loco detto yustra, confine i “siccomis” del detto “no:” Francesco, la possessione ed i “siccomis” degli eredi del quondam m.co Alfonso Susanna, la via pubblica “per quam itur ad eclesiam dive annunciate” ed altri fini.[16]
La nobile famiglia de giglio aveva dei terreni agricoli nella zona ora detta “la yusta”.
Un altro atto notarile di Giovanni Alboccino riporta che Antonino de giglio possedeva dei terreni nella località di “santi biasi”,[17] mentre altri due atti notarili riportano l’ubicazione di vecchie abitazioni della famiglia di giglio nella zona della rittusa: “18.12.1588. Libertino Papandro di Cirò vende al m.co Joannes Maria Casopero di Cirò, una casa palaciata dentro la terra di Cirò, loco detto “la rittusa”, confine con i “casalena que fuerunt m.corum giglis”;[18] “l’onorabile Petro Antonio Curto, vende al m.co Joannes Maria Casoppero di Cirò, la casa posta dentro la terra di Cirò, loco detto “la rittusa”, confine la casa palaziata di donna Marina Cadea, la casa degli eredi di Joannes De Luca, vinella mediante, la via pubblica ed altri confini, oltre un casalinello, confine con la casa di Jo. Matteo di Rossano, “li casalini foro dili m.ci gigli” ed altri fini.[19]
Possiamo concludere affermando che il cognome Lilio in latino (dativo e ablativo) diventa de Lilio, de lilio, de liljo, Lilius (con funzione di soggetto), oppure di giglio/de giglio in italiano (atti notarili G. Alboccino), oppure Gilio, Giglio, Gigli (con oscillazioni grafiche e fonetiche), come da documenti ufficiali della riforma del calendario.
I documenti sopra riportati mostrano la presenza di un piccolo nucleo della famiglia Giglio/Lilio nella Cirò del XVI secolo. La famiglia Giglio possedeva il titolo di “nobile”, dei terreni nelle zone “Fraccuni, Yusta e Santi Biasi” e delle abitazioni sotto “lo castello” e nella località detta “la rittusa”.
Note
[1] NICASTRI R., Cirò, patria del riformatore del calendario, Catanzaro, 1920, p. 25.
[2] MEZZI E, VIZZA F., Luigi Lilio Medico Astronomo e Matematico di Cirò, Laruffa Editore, Reggio Calabria, 2010, p. 14.
[3] Vizza F. “Vita e opera di Luigi Lilio, principali documenti rinvenuti”, in Atti del Convegno Aloysius Lilius, Cirò 22 Ottobre 2010, Centro Stampa, Cirò Marina 2011, pp. 25-63.
[4] JANI THESEI CASOPERI PSYCHRONAEI, Epistolarum Liber duo, Venetiis MDXXXV, Liber primus, c. 24 bis.
[5] JANI THESEI CASOPERI PSYCHRONAEI, Epistolarum Liber duo, Venetiis MDXXXV, c. 38 bis.
[6] http://www.archiviostoricocrotone.it.
[7] ASCZ, Notaio Consulo B., f. 72.
[8] ASCZ, Notaio Consulo B., busta 8, ff. 59-59v. Regesto, 08.07.1574. La m.ca Deca Glisara alias Malena della città di Rossano, moglie del m.co Nicolai Papaioannes promette alla m.ca Laudonia Glisara sua figlia, che andava sposa al m.co Actilio Papaioannes, la dote more nobilium. Il “palazzo” con i suoi “membri” del detto m.co Nicolai Papaioannes posto “al convicinio de s.to petro loco dicto girifalco”, confine la casa dotale di Camillo Caputo, la casa di Minico e Jacobo dele Castelle, “le mura dela t(er)ra” ed altri fini.
[9] ASCZ, Notaio Consulo B., busta 8, f. 5. Il documento è stato gentilmente fornito da Pino Rende.
[10] ASCZ, Notaio Consulo B., busta 8, f. 14. Il documento è stato gentilmente fornito da Pino Rende.
[11] ASCZ, Notaio Consulo B., busta 8, f. 8v. Il documento è stato gentilmente fornito da Pino Rende. Regesto, 25.01.1573. Cirò. Fran.co Bisantio, giunto ad un accordo con “Ant.nus de lilio” di Cirò, gli retrocede la possessione loco detto “s.to Blasio” che aveva acquistato all’incanto nel passato.
[12] ASCZ, Notaio Consulo B., busta 8, f. 194v. Il documento è stato gentilmente fornito da Pino Rende. Regesto, 1576. 05.11.1576. Cirò. Ant.o Abbas di Cirò, vende al m.co Ant.o de Martino “hyspanus”, un “hortale” arborato con fichi, sito in “loco dicto fulcuni sub rupe rictusae”, confine con gli “hortalia ex duobus lateribus m.corum de liliis”, il “vallonem dela riptusa” ed altri fini.
[13] GIULIO MAURO PACCHETTI, Alcune note sull’evoluzione storica del nome di famiglia in italia, Alessandria 2007, p. 137.
[14] IBIDEM, Alcune note sull’evoluzione storica del nome di famiglia in Italia, Alessandria 2007, p. 162.
[15] IBIDEM.
[16] ASCZ, Notaio Alboccino G., busta 13, ff. 425-426. Il documento è stato gentilmente fornito da Pino Rende.
[17] 17. ASCZ, Notaio Alboccino G., busta 13, ff. 525-526. Regesto, 07.10.1588 Petro Antonio Calvo di Cirò, figlio ed erede del quondam Divico Calvo, trasferisce a Francesco e Cesare Calvo di Cirò, suoi nipoti, figli del suo quondam fratello Saladino Calvo ed agenti anche per parte delle loro sorelle Framinia e Cassandria, la possessione arborata con diversi alberi posta nel territorio di Cirò, in loco “dove se dice santi biasi”, confine la possessione del “no: antonino di giglio”, la possessione degli eredi del quondam Cesare Basili, la possessione di Francesco Lalice ed altri fini”. Il documento è stato gentilmente fornito da Pino Rende.
[18] 18. ASCZ, Notaio Alboccino G., busta 13, ff. 533v-534. Il documento è stato gentilmente fornito da Pino Rende. Regesto, 18.12.1588. Libertino Papandro di Cirò vende al m.co Joannes Maria Casoppero di Cirò, “una sua airo di casa palaciata” lasciatogli dalla quondam Laurenza Scurco sua moglie, figlia di Laurenzo Scurco e donna Maria di Liotta di Melissa, posta dentro la terra di Cirò, loco detto “la rittusa”, confine “lo catogio de ditto airo” di Petro Antonio Curto di Melissa, “puro dotale”, la domus di donna Marina Cadea, la via pubblica ed altri fini, nonché “la ragione” che detiene sopra “un casalinello nello medesimo loco”, confine la domus di Joannes Matteo de Rossano, i “casalena que fuerunt m.corum giglis”, la via pubblica ed altri fini.
[19] 19. ASCZ, Notaio Alboccino G., busta 13, ff. 531-531v. Il documento è stato gentilmente fornito da Pino Rende. Regesto, 18.12.1588. Libertino Papandro di Cirò vende al m.co Joannes Maria Casoppero di Cirò, “una sua airo di casa palaciata” lasciatogli dalla quondam Laurenza Scurco sua moglie, figlia di Laurenzo Scurco e donna Maria di Liotta di Melissa, posta dentro la terra di Cirò, loco detto “la rittusa”, confine “lo catogio de ditto airo” di Petro Antonio Curto di Melissa, “puro dotale”, la domus di donna Marina Cadea, la via pubblica ed altri fini, nonché “la ragione” che detiene sopra “un casalinello nello medesimo loco”, confine la domus di Joannes Matteo de Rossano, i “casalena que fuerunt m.corum giglis”, la via pubblica ed altri fini.
The post La famiglia Lilio nella Cirò del XVI secolo appeared first on Archivio Storico Crotone.
I luoghi pii di Belcastro, Cropani e Zagarise, attraverso gli atti della Cassa Sacra dell’Archivio di Stato di Catanzaro

Panorama di Cropani (CZ).
Ripartimento di Zagarise 1784
Belcastro
Copia dell’atti dell’aboliz.ne e sigil.ne de libri ed altre carte, annotazione e consegna degli Argenti, e vasi sacri, mobili, sacre supelletili ed altro come dentro.
Convento dei Domenicani
A dì Ventisette Maggio millesettecento ottanta quattro. Belcastro.
Certifico con giuramento io qui sott.o Cancell.re di questa Uni.tà di Belcastro, qualmente q.a mattina convocati il mag.co Gov.e e Giud.e D. Gregorio Torchia, D. Saverio Arcip.te Cavarretta persona Ecclesiastica di maggior dignità dep.ta da Mons.r Vic.rio Capitolare, il mag.co Pasquale Totino Sind.co di q.a Città, D. Dom.co Galati de Diano persona onesta, probba, e facoltosa, io inffr.tto Cancell.re Salvadore Totino, ed uffiziale destinato in q.o Diparto per la ricorrente incombenza dello ritiro dei religiosi, coll’assistenza di D. Rafaele Manzi cadetto, anche a tal scopo destinato, si è fatto accesso nel Convento dei PP. Domenicani di q.o luogo, e convocati i monaci di d.o convento consistente nel numero di tre.
P. Fra Domenico Poerio da Taverna Priore e Proc.re di d.o Convento.
P. Fra Dom.co Gallo da Cenadi.
Fra Tomaso Prodoti Laico professo.
A quali da d.o Sig.r Uffiziale destinato letti i reali ordini circa al pred.o ritiro dei religiosi, ha prevenito d.o Priore, che faccia munire di tutto ciò ch’è loro necessario per lo viaggio, avertendolo di essersi permesso di portarsi ogni genere di di loro immediato uso, come il letto, i bagalli colle vesti, biancherie, libri, e carte proprie, ma non della comunità, e che stessero allestiti ad ogni ord.e per la partenza pred.a, colla prevenzione che esso Priore, e Proc.re dovrà rimanervi sino a tanto che ne darà il conto di d.o Convento, e se ne faranno le debbite consegne delli averi di esso, tutto a norma delle gnli istruzzioni sull’assunto approvate da S.M.
In seguela il sud.o D. Saverio Arcip.te Cavarretta persona Ecclesiastica di maggior dignità, in presenza di tutte le persone convocate e del Priore e Superiore di d.o Convento, presente ad ogni atto si è esplorata la volontà di d.o laico professo Fra Tomaso Prodoti, se mai voleva secolarizzarsi, il medesimo ha risposto di nò, e voler continuare nella religione, esser pronto per la partenza cogli altri.
Doppo di ciò si è imposto all’espressati monaci di esibire la Platea delle Possessioni, i Libri Maestri d’introito, ed esito, il Registro, il Giornale e tutte le rimanenti scritture riguardanti gli Averi, li obblighi e i Privileggi del Monastero, e dal pred.o Priore e Superiore si sono esibiti li seguenti Libri e Carte
Un Libro delle Congreghe e Consiglo di d.o Convento in Carte scritte, ed abbacate n.o cinquantasei
Un manuale delli anni 1780 e 1781 in Carte scritte ed abbacate num.o settantauna.
Il Libro maestrale d’introito di carte scritte ed abbacate num.o settantaquattro dico 174.
Il Libro maestrale di esito in carte scritte ed abbacate num.o cinquantanove.
Il manuale dell’anno 1782 e 1783 in carte scritte ed abbacate num.o quarantaquattro.
Il Manuale ossia giornale delle messe in carte scritte ed abbacate num.o ventisette.
Il Libro delli obblighi delle messe perpetue in fogli scritti ed abbacati num.o ventitre.
Due Platee di d.o Convento, l’una che porta l’epoca dell’anno 1701 in carte scritte ed abbacate num.o ventuna.
L’altra che porta l’epoca del 1617 in carte scritte ed abbacate num.o sedici.
Più altra Plateola senza epoca di tempo, in carte scritte ed abbacate num.o trentuno.
Altri manuali vecchi num.o quarantacinque.
Carte pergamene continenti diverse scritture num.o cinquantaotto.
Quattro mazzetti di diverse scritture in carta bambacina.
Più un altro mazzetto di simili scritture.
Più un altro mazzetto di processuoli.
Quali Libri e Carte tutte numerate, chiuse e suggellate entro un fangotto di tela, a tenore delle istruzzioni generali, si sono consegnati al mag.co D. Dom.co Galati de Diano, uomo facoltoso, onesto e probbo di q.a Città per esibirli ad ogni ord.e di d.i uffiziali comm.ti.
Indi si sono fatti esibire tutte le argenterie di d.o Convento, consistenti in una Pisside col piede di ottone dorato, un calice con sola coppa d’argento, e piede di ottone dorato, altra coppa di argento senza piede perché di essa se ne servivano i Monaci del piede dell’ospensorio, due patene d’argento dorate, un ostensorio, osia sfera coll’intiero piede d’argento, che consiste in due pezzi, vasi sacri, quali pesati in presenza delle sopradette persone convocate, e del Superiore del Convento, il quale è presente ad ogni atto, si sono trovati del peso, de detto l’ottone di libbre quattro, colla spiega, che in detto peso vanno inclusi i tre cristalli incrastati nelli ostensori, quali vasi sacri a tenore delle reali istruzzioni, si sono consegnati al R.do Arciprete e Parroco D. Saverio Cavarretta persona ecclesiastica di maggior didnità destinata da monsignor Vicario Capitolare per tenerli a disposizione di S. M.
Più l’altre argenterie di d.o Convento, consistenti in una Croce d’argento, osia colla sola piastra di argento, e l’anima di ferro coll’istrizzione = J.H.R.j = di ottone, pomo e manico di rame dorata e due buttini di argento incrastati in d.o pomo.
Uno incensiere con sua navetta e cocchiavino di argento, colla spiega che porzione delle catiniglie di d.o incensiero sono di ferro filato. L’incensiero ha l’iscrizzione = Civitatis Bellicastri Anno D.ni 1659=.
Una Corona e Coroncina della SS.ma Vergine del Rosario anche d’argento, con poche pietre false contorniate, che pesati d.i argenti, una col ferro della Croce, iscrizzione di essa di ottone, pomo e manico di rame dorato, e porzione di catiniglie di ferro delli incensieri, si sono trovate del peso di libre undici, che restano oltre li vasi sacri, come sopra consegnati in potere dell’infr.tto Uff.le Comm.to Sott.te D. Giuseppe M.a Gaudiosi per rimetterle in Cotrone alla persona ivi da S. M. destinata.
E come coll’intervento di d.e persone convocate a tal uopo, e di d.o Superiore e Priore del Convento, diligenziatosi l’officina del med.o, non si sono ritrovato generi, mobili, o derrate di qualunque genere di pertinenza di esso Monistero, né libri, ma solamente pochi libri logorati dal tempo situati nel lo stiglio della camera, ove solea essere la spezeria, ed altri libri usati, di cui n’è piena una cassa di poggio dentro d.a camera, de quali domandato il Superiore pred.o, se vi era indice, o inventario, rispose non esservi, a tenore delle reali istruzzioni e serrata con chiave d.a camera, e da me infr.tto Cancell.re si è suggellata la porta di essa, coll’intervento di tutti i convocati, la di cui chiave si è consegnata al pred.to D. Dom.co Galati uomo onesto, probbo e facoltoso.
E solamente ancora da circa un tt.o grano dentro un cistone, e da circa rotola sei oglio, che si sono lasciati per equità per comodo di d.i monaci fino alla di loro partenza e da quattro, o cinque barili di vino che anche si sono lasciati per la stessa causa.
Perciò si è susseguentemente proceduto anche coll’espressata legalità nell’annotazione delli utensili e comodi.
Si sono trovati pezze nove rame, consistenti in una caldara, un caldarone, due stagnati grandi ad uso di conchetta, un de quali è perforato per uso di percolare, uno stagnato piccolo col manico lungo di ferro, una cassarola col coperchio, una tijella senza coperchio e un trombone di rame, che pesati insieme col ferro delli loro respettivi manichi ascendono a libri sessanta uno.
Più nella camera della Procura giarrotte piccole vacue per uso di stipe di olio della caputa di otto litre l’una num.o quattro.
Una Cassa di castagna con tre mascature vacua.
Tre botti per uso di vino della caputa, l’una di trenta barili, l’altra di barili ventisette, la quale è rotta in una doga, e l’altra della caputa di barili venticinque, tutte vacue, a riserba di una di esse, in cui vi è quel poco di vino annotato di sopra, più un altro barilazzo vacuo della caputa di tre barili.
Nella Chiesa si sono ritrovati li seguenti utensili.
Una Pianeta con corrispondente stola, e manipolo color bronzo, guarnita con galloncino di oro, a riserba della stola, e manipolo che anno il collo pizzetto d’oro.
Un’altra di drappo in seta di diversi colori, campo bianco, attorniata di gallone di seta giallo.
Un’altra di molla undata nera guarnita di gallone falso nero.
Un’altra di diversi colori con gallone falso in oro.
Un’altra anche di seta di diversi colori, con gallone di seta color bruno e rosso.
Un’altra anche di seta color verde, e blò guarnita di gallone e frangette di seta color arangino, e blò.
Un’altra di damasco color blò, con frangia e galloncino di seta color mischio.
Un’altra di damasco in seta bianca, con frangetta e gallone in seta gialla.
Un’altra di velluto nero, parte della quale è spilata del pelo con gallone e frangietta in seta diversi colori.
Un’altra assai vecchia con più pezze di lama in argento con pizzilletto in oro e con porzione falso.
Due tonicelle di drappo in seta di diversi colori, campo color rossa, con frangietta di seta gialla, e galloni falsi.
Due tonicelle di damasco in seta color bruno con frangietta, e galloni in seta diversi colori.
Un’altra pianeta di velluto nero assai vecchia.
Una Cappa osia Pluviale di drappo di diversi colori col campo bianco lamato in argento con gallone falso nero.
Due tonicelle di damasco bianco con gallone e francietta in seta gialla.
Un umerale di damasco bianco con francia e gallone in seta gialla.
Un pallio vecchio di drappo in seta color celeste con bandoniere anche di drappo in seta di diversi colori.
Una tovaglia di seta anche vecchia.
Veli di Calici di diversi colori num.o sette.
Borse di Corporali in seta di diversi colori num.o sette, in sei dei quali vi sono i corporali quali utensili sono tutti vecchi ed altri usati.
Un apparato nuovo di drappo in seta color rosa pallada con gallone in seta gialla foderato di tela rogana color rosa, e consiste in una pianeta con stola e manopole, due tonicelle con solo manipolo.
Due camici di tela usati con rispettivi cingoli ed amitti.
Due cotte anche di tela usate.
Due veli di croce di seta di diversi colori in uno dei quali vi è l’effiggie del Patriarca S. Domenico.
E perché l’ora fu tarda s’è sospeso l’ulteriore inventario.
Quali sud.e robbe, come sopra annotate si sono consegnate a riserba delli argenti e di quei pochi viveri lasciati per comodo di detti monaci al mag.co Domenico Galati , uomo probo onesto e facoltoso per tenerli presso di se ed esibirli ad ogni ordine come appresso più diffusamente si spiegherà.
Saverio Arcip.te Cavarretta fui presente e ho ricevuto come sopra.
Gregorio Torchia Gov.re e Giud.ce fui presente.
Fra Dom.co Poerio P.re e Superiore fui presente.
Pasquale Totino Sindaco fui presente.
Dom.co Galati de Diano fui presente e ho ricevuto come s.a.
Salvad.re Folino Cancelliere fui presente.
Raffaele Manzi
Giuseppe M.a Gaudiosi. Sott.e Com.to.
Nel dì medesimo, il giorno continuandosi lanzidetta annotazione dell’espressato Conventino Domenicani, colla legalità di tutte l’espressate persone, Priore e Proc.re di esso. In oltre nella Chiesa del med.o si sono ritrovate le seguenti robbe.
Un Salmista legato in pergamena.
Un antifonario di Canto Gregoriano.
Un Breviario di Coro del di loro ordine.
Tre Messali grandi, e due Messaletti di Requie.
Un altro Breviario in foglio del di loro ord.e
Il Martirologgio del di loro ordine.
Un organetto col suo orchesto.
L’Altare Maggiore con due tovaglie, Carta Gloria, Lavabo ed in Principio con cornici di legno indorato con dodeci candelieri di legno inverniciati anche in oro e quattro di legno dipinti, con quattordici frasche di carta, due cocini assai logorati di felba cremes e d.o altare è di stucco.
L’Altare del Rosario anche di stucco, coll’immagine dipinta in oglio, e mesteri della Passione a lato, con velo di mezzo carangà, cinque fiori di carta, e sei di agrobello, e carta, sei candelieri di legno inverniciati verdi, carta Gloria, Inprincipio, e Lavabo di legno dello stesso colore, due coscini vecchi di drappo di seta, ed una tovaglia, con ferro che sostiene d.o velo.
L’Altare di S(an) Dom(eni)co anche di stucco coll’Imagine dello stesso dipinto in oglio, velo di seta color pronzo, con fodera di tela rogana e corrispondente ferro, che lo sostiene, frasche di calco num.o sei, sei candelieri, carta di Gloria, In principio, e Lavabo di legno, Crocefisso di carta pesta, con croce di legno, una tovaglia e due coscini di seta logorati.
La Cappella di San Gio.e Batt.a col semplice quadro.
La Cappella della Madonna del Carmine anche di stucco con quadro dipinto in oglio, velo di calamo e seta, , vecchio color celeste, corrispondente ferro, che lo sostiene, quattro candelieri di legno vecchio, una tovaglia con due coscini vecchi.
L’Altare di S. Rosa con quadro dipinto in oglio velo di tabbiello in seta giallo.
L’Altare di S. Vincenzo Ferreri anche di stucco con quadro dipinto in oglio, cornice indorata, con velo di seta verde, coll’armi della famiglia Diano, e l’iscrizze sopra che dimostra essere stato eretto da D. Carlo de Diano, e D. Felice Anania congnati, sei candelieri di legno inverniciati in oro, ed argento, una tovaglia, due coscini di lana durante con tre pezzi di marmo verde di Gimigliano per gradino.
La Cappella di S. Tomaso anche di stucco col quadro di esso Santo dipinto in oglio,sei candelieri vecchi di legno, e una tovaglia di tela.
L’Altare del Bambino Gesù, con quadro in oglio lacero, con velo di mezzo carangà, e ferro che lo sostiene, una tovaglia di tela vecchia.
Un’acquasantaro di marmo con cerchio, e bastonello di ferro che lo sostengono.
Un lampierino di rame giallo.
Un Pulpito ed una catredetta di legno.
Un sicchietto di piombo.
Un Campanello di bronzo per uso di sacristia
Un altro Campanello di bronzo per uso di sacristia.
Un altro anche di bronzo per uso di sacristia.
La Chiesa con intempiata di tavole abbete.
Due Campane, che non si sono possute scendere, l’una senza iscrizze ed epoca, perché logorata, e non si può leggere, l’altra con la seguente iscrizze = IHS MCCCCLXXVI; con respettivi battagli di ferro.
Un Stipe grande di abbete, con ivi dentro l’imagine della Beatis.a Vergine del Rosario, con vestito di drappo francia usato, con ricamo in oro ed argento.
Il Convento di fabrica in più membri, e dormitori, con orto in esso attaccato della capacità di due tt.e circa, con celzi mori, ed altri alberi fruttiferi.
Due barracche, cioè una nella terra di Sanmarco, fondo di esso Convento, che si deve descrivere nell’Inventario Generale, e l’altra dentro d.o orto.
Quali sopr.tti Beni si sono similmente consegnati al mag.co D. Dom.co Galati de Diano persona probba e facoltosa , a cui si è incaricato a nome di S.M. di usare la massima attenzione possibile, nella conservazione di tutto ciò alla di lui cura si è affidato, e di esibirlo come si è obbligato ad ogni ordine della m.S. all’amministratori della Cassa Sacra, onde a fede del vero e della legalità a tenore delle regali istruzzioni sull’assunto, ne ho formato io qui sott.o Cancelliere il presente solenne atto.
Saverio Arcip.te Cavarretta fui presente.
D. Dom.co Poerio P.re Superiore fui presente.
Greg.o Torchia Gov.e e Giud.e fui presente.
Pasquale Totino Sindaco fui presente.
Dom.co Galati de Diano fui presente e ho ricevuto come sopra.
Salvadore Tolino Cancell.e fui presente ed ho form.to il presente atto.
Rafaele Manzi Ass.te Com.to. Gius.e M.a Gaudiosi Sott.e Com.to.
Adest Sigillum.

Insegna dell’università di Belcastro.
Belcastro 16 giugno 1784
(…) annotazione e sequestro de’ beni e mobili esistentino nelle stanze del fu Priore Padre Fra Domenico Poerio e del P.re Fra Domenico M.a Gallo, religiosi sacerdoti e del laico fra Tomaso Prodoti e nella stanza del sud.to fu Padre Priore furono ritrovati li seguenti mobili cioè un letto consistente in un pagliaccio lettiera e piedistalli di legno, un boffettino con due tiraturi usati, un picciol scannetto di tavole di abbete, tre sedie di paglia usate, un sigillo con manico di legno coll’impressa in rame quella che figura l’immagine della Vergine del SS. Rosario, un breviario con una figura nel suo frontespizio ed in esso lepigrafo dictante breviur.e sacri ordinis pudicatorum. Quali mobili sono stati suggellati, cioè il sud.o fattone col suggello (…)
Ripartimento di Zagarise 1784
Atto della descrizione numero e peso delle campane.
BELCASTRO
A di diecennove Novembre 178 quattro nella Città di Belcastro.
Convento dei Domenicani
Abbolito conventino Domenicani – Certifico col mio giuramento io qui sotto Cancelliere della Città di Belcastro, qualmente da D. ottavio Gentile Fiscale di questo Stato, per incombenza avuta dal Sig.r Ufficiale del Ripartimento D. Giuseppe M.a Gaudiosi, oggi med.o dopo aver convocate le infr.tte Persone, si è proceduto coll’assistenza, ed intervento di esse e di me infr.tto Cancell.re alla numerazione, peso e descrizzione di tutte le campane aboliti Luoghi Pii, e Conventino di questa Città, e ciò a tenore delle recenti disposizioni di S. E. il S.r Vicario G.nle D. Francesco Pignatelli, ed in primo luogo conferiteni nell’abolito conventino Domenicani di q.a Città, e fattesi scendere le due campane, una grande, ed una piccola, ch’esistevano nel Campanile di esso abolito Conventino; la grande si è ritrovata, che da una parte tiene effiggiato il S. Nome di Gesù, dall’altyra una Croce, ed ha l’Epoca dell’anno 1476, che pesato al trentatre, si è trovata del peso rotola cinquantacinque – 55.
La piccola sotto la Corona della medesima tiene l’Iscrizzione colle seguenti lettere =
Del peso al trentatre rotola trentacinque – 35

L’iscrizione della campana di Cropani riportata dal documento.
Chiesa della Pietà
Pietà – Successivamente ci siamo conferiti nella abolita Chiesa della Pietà, e fatta scendere la Campana, che esisteva nel Campanarino di essa, si è trovata che tiene la presente iscrizzione = S. Maria mater Pietatis ora pro nobis Anno D.ni 1749; e del peso al trenta tre rotola cinquanta sette – 57.
Chiesa dell’Annunziata
Annunciata – Indi ci semo conferiti nell’abolita Chiesa e Confraternita sotto il titolo dell’Annunciata, e fatte scendere dal Campanile di essa le tre Campane, che in esso esistevano cioè una grande, una mezzana ed una piccola. La grande si è trovata con la seguente iscizzione “Sub Postulatu Ill.mi Re.mi D. Ioannis Emblavita E.pi Bellicastren Anno D.ni 1710 + tempore Pr. V. I.J. D. Lucae Pisani, et mag.co Thomae Buccia= vi è l’effiggie che rapp.ta l’Annunciata A.G.P. = Gio. Ant.o Almieri F: il di cui bronzo al peso del trentatre, si è trovato di rotola duecento – 200.
La mezzana si è trovata coll’Epoca del 1614, che ha una effiggie dell’Im.ta, il peso di quella al trentatre si è trovato di rotola ottanta – 80.
La piccola , colla seguente iscrizz.e Tempore Prioratus mag.ci Thomae Mazzei, et Procu Paschalis Totino= S.A.N.L.L. coll’effiggie della Vergine e Bambino, con quattro Puttini a torno, e coll’Epoca del 1780, il di cui bronzo è del peso, rotola quaranta – 40.
Chiesa della Sanità
Sanità – E finalmente ci siamo conferiti nell’abolita chiesa della Sanità e fattasi scendere l’unica Campana, che nel Campanaretto di essa esisteva, si è trovata coll’impressa di un fioretto, e coll’Epoca del 1695, il di cui bronzo pesato al trentatre, si è osservato che sia di rotola novantasei – 96.
Quali campane, come sopra descritte, pesate e numerate rimasero individualmente consegnate a D. Dom.o Galati de Diano di questa Città uomo probbo e facoltoso, coll’incarico in n(om)e di S. M. di usare la massima diligenza nella conservazione di esse, e di esibirle nel med.o peso, num.o e qualità ad ogni ordine di S. M., o del Sig.r Vicar.o Gen.le D. Fran.co Pignatelli.
Che però da me qui sott.o Cancell.re si è formato il presente atto solenne, che va sott.o da tutte le persone, che v’intervennero, robborato di mia firma, ed autorizzato col suggello un.le di questa Città.
Dom. Galati de Diano ho ricevuto e mi obligo.
Saverio Arcip.te Cavarretta intervenni.
Vincenzo Nicoletta sind.co intervenni.
Pietro Pollinzi Gov.e e Giud.e intervenni.
Ottavio M.a Gentile Tiscale intervenni.
Giovanni Laudari Cancell.o intervenni e certifico come sopra.
Ripartimento di Zagarise
Copia dell’Atto, descrizzione, misura e suggelam.to de’ Quadri dei Luoghi Pii di Cropani, Belcastro e Zagarise.
CROPANI
Cropani il di Venti Giugno Mille Settecento Ottanta Quattro.
Certifico col mio giuram.to Io qui sott.o Canc.re di questa Uni.ta di Cropane, come l’Ill.mo Sig.r D.r Gius.e M.a Gaudiosi col suo Cadetto Assistente D. Rafaele Manzi, conferitesi qui oggi sopr.tto giorno e convocati l’infr.tte persone ha proceduto alla dimens.e e suggellam.to e descriz.e di tutti li Quadri esistenti nelle chiese dell’aboliti e soppressi Luoghi pii di questa Terra altra volta inventariata ed annotati e su tale assunto an fatto ed operato ciò che siegue.

Sigillo dell’università di Cropani.
Chiesa del sospeso Convento Cappuccini
In primo luogo ci semo conferiti nella Chiesa del sospeso Convento Cappuccini e nell’Altare Maggiore di essa si è trovato esistente un Quadro sulla tela dipinto in oglio che rappresenta l’effiggie della Madonna degli Angeli, che misurato si è trovato della larghezza palmi sette meno un’oncia e mezza, dell’altezza o sia lunghezza palmi undeci oncie due, senza iscrizzione.
Nel primo altare a man dritta nell’entrarvi a d.a Chiesa vi è la Cappella del Crocefisso, il quale è di legno con due quadri vecchi a fianchi, che rappresentano dipinti sulle tele in oglio l’effiggie di S. Gio. e l’altro quello di Maria SS.ma e sono egualm.te dell’altezza o sia Lunghezza palmi sette e mezzo l’uno e larghi palmi tre meno un quarto, l’uno e l’altro senza iscrizzione.
Nel secondo altare a man dritta vi è il Quadro similmente dipinto sulla tela in oglio rappresentante l’Effiggie di S. Antonio de Padova, che si è trovato dell’altezza, o sia lunghezza palmi sette meno tre oncie e della Larghezza palmi quattro e mezza oncia, coll’Iscrizz.e= Cristopharus S. Anna pinxit 1762=.
Il primo altare a man sinistra nell’entrare a detta Chiesa vi è l’altare della Sanità con un quadro dipinto sulla tela in oglio rappresentante l’Effiggie della Madonna sotto lo stesso titolo, che misurato si è riconosciuto dell’altezza o sia lunghezza palmi sette onc. una largo palmi cinque oncie tre e mezza colla seg.te iscrizz.e = D. P. Politi pinxit=.
Nel secondo Altare a man sinistra vi è un Quadro similm.te sulla tela in oglio che rappresenta l’Effiggie della Madonna e di S. Francesco Assisi, lungo palmi sette largo palmi cinque oncie due e mezza in calce del quale vi è la seg.te iscrizz.e = C. Romei F.=.
Nel terzo e ultimo Altare a man sinistra vi è il Quadro anche dipinto sulla tela in oglio rappresentante l’effiggie della R.ma Vergine Immacolata e misuratosi si è trovato alto o sia lungo palmi sei oncie due e mezza, e largo palmi quattro oncie due senza iscrizz.e.
Nel Sunto Lateram di d.a Chiesa ai muri dello stesso ai si sono trovati appesi Quadri vecchi dipinti sulle tele in oglio e con respettive cornici di legno in rustico num.o otto, il primo rappresentante l’effiggie della Beata Lucrezia dei Duchi di Ferrara, il secondo la Beata Blanca dei Re di Castiglia, il terzo di S. Ludovico Vescovo,, il quarto il quale è senza iscrizzione nella cornice, una S. Monaca, il quinto l’effiggie d’un’altra monaca, perché senza iscrizzione nella cornice, il sesto S. Nicola Martire, il settimo S. Samuele Martire, e l’ottavo S. Daniele, tutti otto della respettiva lunghezza palmi tre e mezzo e larghezza palmi due e mezzo l’uno.
Più altro quadretto senza cornice coll’Effiggie di un monaco dipinto in tela in oglio, lungo palmi tre meno tre oncie, largo palmi due onc. tre senza iscrizz.e.
Altro quadretto con cornice di legno rappresentante l’Effiggie di un altro monaco, dipinto in tela in oglio lungo palmi due onc. una e dell’istessa larghezza situato a man destra dell’altare maggiore ma senza iscrizzione.
Altro Quadretto a man sinistra di d.o Altare con cornice di legno, che rappresenta l’effiggie di altro monaco, dipinto in tela in oglio, ma senza iscrizzione, lungo palmi due e mezzo, largho palmi due ed un quarto.
Altro Quadretto a man sinistra, senza cornice, in cui vi è dipinta in tela in oglio l’effiggie di Maria SS.ma, lungho palmi due ed un quarto e largho palmi uno e due terzi, senza iscrizzione.
Altro Quadretto con cornice di legno dipinta, anche in tela in oglio rappresentante similm.te l’effiggie di Maria SS.ma lungo palmi due meno due oncie, largo palmi uno e oncie quattro senza iscrizzione.
Nei muri laterali del Vaso di d.a Chiesa vi sono appesi li seguenti quadri.
Un Quadro dipinto sulla tela in oglio rappresentante S. Antonio de Padova lungho palmi sei oncie tre largho palmi quattro onc. Mezza, senza iscrizzione.
Altro Quadro similm.te dipinto in oglio rappr.te l’effiggie del Purgatorio dell’altezza o sia lunghezza palmi sei oncie tre, largo palmi quattro e mezzo meno un oncia, senza iscrizzione e senza cornice.
In d.i muri laterali altri sedici quadri appesi della lunghezza respettiv.te palmi tre e mezzo e larghezza palmi due e mezzo l’uno, tutti con cornicie di legno vecchi e laceri e senza iscrizzione del Autore rappresentanti l’effiggie dipinte sulla tela in oglio, l’uno S. Golino,, il secondo la B. Isabella dei Re di Francia, il terzo a B. Giovanna dei re di Navarra, il quarto la B. Elena dei Re di Castiglia, il quinto la B. Costanza dei Re di Aragona, il sesto la B. Beatrice dei Re di Navarra, il settimo la B. Sangia dei Re di Napoli, l’ottavo S. Pietro Martire, il nono la B. Borromea dei Re di Polonia, il decimo il B. Berardino Martire, l’undecimo S. Apulfio Martire, il duodecimo S. Cantone Martire, il decimo terzo S. Adiceto Martire, il decimo quarto S. Elisabetta, il decimo quinto S. Angelo Martire, il decimo sesto S. Bonaventura e tutti senza iscrizzione del Autore.

Cropani (CZ), chiesa e convento dei Cappuccini.
Quadri nel Coro della Chiesa.
L’Effiggie dipinta in oglio sulla tela di S. Michele arcangelo lungo palmi cinque ed oncie quattro e mezza, larga palmi tre e mezzo ed una oncia, quadro vecchio senza iscrizzione.
Altro Quadro vecchio rappr.te l’effiggie di S. Anna, dipinto similmente in tela in oglio, della larghezza palmi quattro oncie cinque e della lunghezza palmi sei meno oncie tre e mezza, senza iscrizzione.
Altro Quadretto similm.te dipinto in oglio sulla tela rappresentante l’effiggie di S. Francesco di Assisi, lungo palmi due onc.quattro e largo palmi uno e due terzi, senza iscrizzione.
Altro Quadretto nel scendere della scala coll’effiggie del SS.mo Eccehomo dipinta pure sulla tela in oglio, lungo palmi due e mezzo meno un oncia e largo palmi due, senza iscrizzione.
Che furono tutti l’uno dopo l’altro suggellati in cera Spagna.

Cropani, chiesa dei Cappuccini (foto Gal Valle del Crocchio).
Chiesa de Minori Osservanti
Nel primo Altare a man dritta, entrandovi alla porta di d.a Chiesa, vi è un quadro vecchio dipinto sulla tela in oglio, che dimostra la morte del Serafico S. Francesco, della lunghezza o sia altezza palmi otto ed un terzo, e della larghezza palmi sei meno un terzo con due iscrizzioni l’una distante = V.J.D.r Gregorius Gentile pro se haeredibus suis, de familia Cosentino= L’altra dimostra di essere stato l’autore Francesco Carbone.
Nel secondo Altare a man dritta vi è anche un dipinto sulla tela in oglio un quadro che dimostra l’effiggie di S. Diego, che misurato si è trovato dell’altezza, o sia lunghezza palmi sei meno un oncia e della larghezza palmi quattro e mezzo, senza iscrizzione alcuna.
Nel terzo Altare a man dritta vi è il Quadro di S. Pasquale dipinto similmente sulla tela in oglio, dell’altezza palmi sei e mezzo ed oncia una e della larghezza palmi quattro oncie quattro e mezza senza iscrizione.
Primo Altare a man sinistra nell’entrarvi come sopra vi è similm.e dipinto sulla tela in oglio un Quadro vecchio che dimostra Lo Spirito S. nel Cenacolo e Maria SS.ma cogli Ap.li, lungo palmi otto e mezzo e largo palmi sei senza iscrizzione.
Nel Secondo ed ultimo Altare a man sinistra vi è il Quadro di S. Antonio di Padova dipinto pure sulla tela in oglio, lungo o sia alto palmi sette meno onc. Due e largo palmi cinque meno un oncia, senza iscrizzione.
Nell’Altare maggiore di essa Chiesa, oltre di esservi nella nicchia l’Immagine di Maria Immacolata di marmo bianco ai lati di essa vi sono due quadri dipinti similmente sulle tele in oglio, l’uno rappresentante S. Rocco, e l’altro S. Francesco, che misurati si sono trovati ogn’uno di essi della lunghezza osia altezza palmi sei e mezzo, meno un oncia e mezza, e della larghezza palmi due e mezzo ed un oncia, coll’iscrizzione solamente in quello di S. Rocco dittante = R.dus P.re Joanuarius Migliarina vesatis diste fecit pro sua divozione Anno Domini 1755=.
Che tutti sono stati similmente suggellati.

Sigillo della collegiata di Santa Maria Assunta di Cropani.
Chiesa di S. Giovanni Battista
Nell’altare Maggiore vi è un Speciosissimo Quadro dipinto sulla tela in oglio rappresentante l’effiggie di S. Gio. Battista nel fiume giordano pennellato da Ecc.ma mano, lungo palmi duodeci meno un terzo, e largo palmi otto, ed oncie sette colla iscrizzione nel q.le essere rotta la pittura, solo si legge bene = Politi.
Primo Altare a man destra col quadro che dimostra l’effiggie di S. Vincenzo Ferreri dipinto sulla tela in oglio, lungo o sia alto palmi sette e mezzo e largo palmi cinque meno oncie due, senza iscrizzione.
Secondo Altare a man destra col Quadro che dimostra l’Addolorata dipinta sulla tela in oglio dell’istessa lunghezza e larghezza senza iscrizzione.
Terzo Altare a man destra dipinto sulle tele in oglio esiste in esso il Quadro di S. Paolo dell’istessa lunghezza e larghezza senza iscrizzione.
Nel primo Altare a man sinistra il Quadro dipinto in oglio sulla tela, che dimostra la Decollazione di San Giovanni Battista dell’istessa lunghezza e larghezza senza iscrizzione.
Nel secondo Altare a man sinistra, vi è il Quadro dipinto similm.te sulla tela in oglio che dimostra che dimostra l’effiggie della SS.ma Vergine Im.ta dell’istessa lunghezza e larghezza senza iscrizzione.
Terzo ed ultimo Altare a man sinistra in esso vi è il quadro anche dipinto sulla tela in oglio, che dimostra La Madonna del Carmine dell’istessa lunghezza e larghezza, senza iscizzione.
Che tutti l’un dopo l’altro coll’istesso suggello furono suggellati

Cropani (CZ), tela della chiesa di San Giovanni Battista (foto Gal Valle del Crocchio).
Confraternita di S. Giovanni Battista
Nell’Oratorio di questa Confraternita vi è una Cappella nella quale, o sia nella nicchia di essa, vi esiste anche dipinto in tela in oglio rappresentante Maria Addolorata ò sia La Pietà, che sostiene Cristo morto tra le braccia un quadro della lunghezza palmi sette oncie due e della larghezza palmi quattro e oncie tre e mezza, senza iscrizzione, similmente suggellato.

Cropani (CZ), chiesa di San Giovanni Battista (foto Gal Valle del Crocchio).
Chiesa di Santa Caterina
Nella prima Cappella a man dritta vi è il Quadro dipinto sulla tela in oglio, dimostrante l’Effiggie di S. Gennaro, lungo palmi otto meno un quarto, e largo palmi sei meno un quarto, colla iscrizzione = C. Romei=.
Nel secondo Altare a man dritta esiste il Quadro dipinto sulla tela in oglio rappresentante San Michele Arcangelo dell’istessa lunghezza e larghezza senza iscizzione.
Nel terzo Altare a man dritta vi è il quadro di S. Francesco di Paola similmente dipinto sulla tela in oglio, dell’istessa lunghezza e larghezza senza iscrizzione.
Nel primo Altare a man sinistra il Quadro di S. Agostino dipinto sulla tela in oglio dell’istessa lunghezza e larghezza senza iscrizzione.
Nel secondo Altare a man sinistra vi esiste la nicchia ma senza Quadro.
Nel terzo Altare a man sinistra esiste il Quadro di Maria SS.ma sotto il titolo della Sanità dipinto anche in tela in oglio, dell’istessa lunghezza e larghezza senza iscrizzione.
Appeso al muro sinistro dell’Altare Maggiore vi è il quadro dipinto in tela in oglio, rappresentante l’effiggie dell’Immacolata Concezzione, lungo palmi sei e un quarto, e largo palmi cinque senza iscrizzione.
Nella Sacristia di detta Chiesa vi esistono otto quadri dipinti anche sulla tela in oglio sebbene vecchi, l’uno che rappresenta Lo Sposalizio di S. Caterina lungo cinque palmi e quarti tre, largo palmi quattro e mezzo colla cornicie verniciata in oro senza iscrizzione.
L’altro il Quadro dell’Immacolata con cornicie verniciata in oro, lungo palmi due meno un oncia e mezza.
L’altri con cornice di legno dipinta rappresentanti l’uno S. Giacinto, l’altro S. Giuseppe, l’altro Cristo resuscitato, l’altro la Madonna del Carmine, l’altro S. Michele Arcangelo e l’altro S. Barbara, tutti dell’uguale altezza palmi quattro meno oncie due e mezza e della larghezza palmi tre meno un oncia e mezza senza iscrizzione.
E si sono tutti l’uno dopo l’altro immediatamente sugellati.
Quali Quadri di sopra descritti ed annotati misurati e suggellati tutti in cera Spagna a tenore dell’ultimi ordini di S. E. il Sig.r Vicario Generale D. Fran.co Pignatelli e senza innovarsi cosa alcuna repporto alla consegna di essi, come dall’aoi delle ….. ragioni, altra volta fatta respettivamente al benestante D. Saverio Uccello ed alli P.ri respettivi della Chiesa di S. Giovanni Can.co D. Gio. Batt.a Colucci e del Convento Cappuccini e Convento Minori Osservanti D. Saverio Uccello pred.o e della Chiesa di S. Caterina D. Leonardo Cantore Nicotera
Giambat.a Tes.re Corabi Vic.rio for. Deleg. Fui presente.
Francesco Colucci Sind.co fui presente.
Saverio Uccello intervenni.
D.r Vincenzo Monizio log.te intervenni.
Rafaele Manzi Assistente
Giuseppe M.a Gaudiosi sotto Ten.e Com.rio
Fran.co Durile Cancell.re intervenni e certifico come sopra.

Cropani (CZ), chiesa di Santa Caterina (Foto Gal Valle del Crocchio).
BELCASTRO
Adi trenta Giugno Mille Settecento Ottanta Quattro nella Città di Belcastro.
Certifico col mio giuram.to il qui sott.tto Cancelliere di questa Città qualmente oggi sopradetto giorno fattosi acceso qui dal Sig.r D. Rafaele Manzi Cadetto del Battaglione Real Ferdinando ed assistente all’Ill.mo Sig.re D. Giuseppe M.a Gaudiosi Uff.le principalmente Comm.o in questo paraggio per l’abbolizione e sospenzione de Luoghi Pii coll’intervento di me infr.tto Cancelliere e dell’altre infr.tte persone convocate ha proceduto alla misura e suggelam.to dell’infr.tti Quadri esistenti nell’infr.tti Luoghi pii di questa Città.
Chiesa de Domenicani
Nell’Altare del Rosario vi è dipinto in tela in oglio il Quadro sotto l’istesso titolo che misurato col passetto Napolitano, oltre le cornici, si è trovato dell’altezza, o sia lunghezza, pal. Otto, oncie tre, largo pal. Sette oncie tre senza veruna iscrizzione.
Nell’Altare di S. Domenico il Quadro anche dipinto in tela in oglio dell’istesso Santo è dell’altezza o sia lunghezza pal. Cinque e mezzo largo pal. Tre oncia una e mezza senza iscrizzione.
Nell’Altare di S. Gio. Battista il Quadro similm.te dipinto in tela in oglio rappresentante l’istesso Santo si è trovato dell’altezza o sia lunghezza palmi sette e mezzo largo palmi cinque e mezzo e tiene in piedi del med.o la seguente iscrizzione = Xaverius S. Croce ping. anno Domini 1748=.
Nell’Altare del Carmine vi è il Quadro anche dipinto in oglio in tela, rappresentante la Beatissima Vergine sotto lo stesso titolo, che si è trovato dell’altezza, o sia lunghezza, pal. Dieci onc. Tre e della larghezza pal. N otto oncie nove coll’iscizzione in calce di esso = Xaverius S. Croce ping. A.D. 1748=.
Nell’Altare di S. Rosa in cui vi è il Quadro dipinto anche in tela in oglio dell’Effiggie di essa Santa lungo pal. Diece onc. Tre e largo pal. Otto meno oncie tre senza iscrizzione.
Nell’Altare di S. Vincenzo Ferreri il quadro rappresenta l’effiggie di d.o Santo dell’altezza o sia lunghezza pal. Nove meno oncie tre e della larghezza palmi sette e mezzo senza iscrizzione in esso Quadro ma colla seguente iscrizzione in d.o Altare = Dicatum sub invocatione Divi Vincentii Ferrerià D. Carlo de Diano et Felicia Anania coniugibus propriis sumptibus de accepta filia erectum pari divotione in elegantiorem sane forma derigendum curarunt Joseph Spadea ping. A.D. 1772=.
Nell’Altare di S. Tomaso vi è anche dipinta in tela in oglio in un Quadro l’effiggie di questo Santo, il quadro predetto è della lunghezza, o sia altezza, palmi nove oncia una e mezza, e della larghezza palmi otto e mezzo, colla seguente iscrizzione = Xaverius S. Croce ping. A. D. 1748=.
Nell’Altare finalmente del nome di Giesù, vi è anche un quadro rappresentante l’effiggie di Giesù Bambino, dipinto in tela in oglio, vecchio e semi lacero dell’altezza, o sia lunghezza pal. Sette e larghezza pal. Cinque , senza iscrizzione.
Che furono di propria mano dall’espressato Sig.r Cadetto Manzi, li quadri predetti immediatamente suggellati in cera Spagna.
Chiesa della Pietà
Nell’Altare del Carmine vi è il quadro dipinto sulla tela in oglio, rappresentante l’effiggie della sud.a Madonna, che si è trovato dell’altezza, o sia lunghezza, pal. Otto e mezzo e della larghezza pal. Cinque oncie nove, il quadro predetto è vecchio in pie del quale vi è la seguente iscrizzione = Sacellum Per R. dum D. Franciscum Casiggoae Cant. J.V.D. editum A. 1659=.
Nell’Altare del Purgatorio vi è il quadro corrispondente è dipinto sulla tela in oglio, lungo palmi nove onc. Una e mezza, largo pal. Sei onc. Quattro e mezza in pie di esso vi è la seguente iscrizzione= Franciscus Ciminus ping.=.
Nell’Altare in legname senza Cappella vi è il quadro di S. Pietro dipinto in oglio sulla tela attaccato al muro della lunghezza o sia altezza pal. Sei e mezzo e della larghezza pal. Quattro onc. Tre senza iscrizzione.
Vi è ancora in detta chiesa dipinto sulla tela in oglio un Quadro dell’Immacolata, dell’altezza o sia altezza pal. Nove e della larghezza pal. Sette meno oncie tre senza iscrizzione.
Che furono similmente li quadri pred.i sugellati; in detta chiesa non vi sono altri quadri dipinti in oglio sulla tela, ma vi è inoltre dentro la nicchia dell’altare maggiore dipinta à sguazzo al muro di d.a nicchia l’Effiggie della Pietà, che per essere pittata troppo rozza e rustica, non si è stimato misurarla.
Chiesa dell’Annunciata
Indi ci semo conferiiti nella Chiesa dell’Annunciata nella quale si sono ritrovati li seguenti Quadri.
Nell’Altare Maggiore vi è dipinto in oglio sulla tavola l’effiggie della SS.ma Annunciata, la quale è della larghezza palmi sei meno un oncia e mezza e della lunghezza palmi otto oncie tre senza iscrizzione.
Nell’Altare della Nascita di Giesù Bambino vi è il Quadro rappresentante d.a nascita, dipinto sulla tela in oglio dell’altezza o sia lunghezza pèal. Sette e mezzo e della larghezza pal. Cinque onc. Tre senza iscrizzione in d.o quadro.
Nell’Altare del Carmine vi è il Quadro dipinto anche sulla tela in oglio rappresentante l’effiggie della B.ma Vergine sotto lo stesso titolo, ed è della lunghezza o sia altezza pal. Nove meno onc.tre, e della larghezza pal. Cinque oncie tre senza iscrizzione.
Nell’Altare della Visitazione vi è il quadro similmente dipinto sulla tela in oglio della lunghezza pal. Otto onc. Tre, larghezza pal. Sei meno un oncia e mezza in pie di questo quadro vi è la seguente iscrizzione = Sacellum de Jure Patronatus Familiae de Tacina Pr. D. Jo. Vincentium Tacina Cantorem editam A.D. 1630 Ad presensio D. Franciscus Antonius Marescalco S. Mauri, qui propriis expensis hanc Iconem construere fecit A,D. 1646=.
Nella cappella o sia Altare di S. Anna vi è il Quadro della medesima dipinto altresi sulla tela in oglio lungo palmi sei, largo pal. Quattro senza iscrizzione.
Nella Cappella della Beata Vergine di Trapani vi è il quadro rappresentante l’istessa madonna dipinto sulla tela in oglio, che misurato si è trovato della lunghezza o sia altezza pal. Sette onc. Tre e della larghezza pal. Quattro onc. Tre senza iscrizzione.
E li quadri anzi detti si sono similm.e sugellati.
Chiesa della Sanità
E finalmente ci semo conferiti nella Chiesa della Sanità nella quale in una sola Cappella, ,che in essa si trova, vi è dipinta in rustico, ed a sguasso, l’effiggie della Madonna sotto lo stesso titolo al muro della nicchia di essa cappella che non si è stimato misurare per essere pittura troppo vile e rustica.
In un Altare diruto dentro d.a Chiesa che si disse era sotto il titolo di S. Michele arcangelo non si è trovato quadro, ma si è trovato appeso in altra parte dentro essa chiesa in dipinto lo quadro di S. Michele Arcangelo pred.o similm.te sulla tela in oglio ed essendosi in seguito misurato si è trovato della lunghezza pal. Sei e della larghezza pal. Quattro senza iscrizzione.
ZAGARISE
Adi die nove Giugno mille settecento ottanta quattro nella Terra di Zagarise.
Certifico col mio giuram.to io qui sottoscritto Canc.re di q.a Terra qualm.e conferitosi qui oggi D. Rafaele Manzi Cadetto del Battaglione Real Ferdinando, ed assistente à D. Giuseppe M.a Gaudiosi Uff.le, principalmente commissionato in questo paraggio per l’abolizione e soppressione de Luoghi Pii, e nell’abbolito Conventino Domenicano e specialmente nella chiesa di esso ha proceduto alla misura e suggilamento dei Quadri in esso esistenti.
Nel primo altare à man dritta sotto il titolo del SS.mo Rosario, in quadro dipinto in oglio in tela, rappresentante la Madonna SS.ma sotto lo stesso titolo, si è trovato dell’altezza palmi dodeci e mezzo, e della larghezza pal. Otto, ed un terzo, coll’Iscrizzione= Michelangelus Napparus ping. 1601. Nel Secondo vi è il quadro della Circoncisione di Giesù Cristo, dell’altezza pal. Dodeci e mezzo, larghezza pal. Otto, ed un terzo, dipinto, anche in tela in oglio senza iscrizzione. Nel Terzo il quadro similmente dipinto in tela rappresentante la figura della Madonna dell’Angioli, altezza palmi dodeci, e mezzo e palmi otto ed un terzo di larghezza senza iscrizzione. Nel Quarto a man sinistra il quadro di S. Domenico di altezza palmi dodeci meno un terzo e larghezza palmi otto, senza iscrizzione, consimilmente dipinto in oglio sopra la tela. Nel Quinto il Quadro della SS.ma Vergine del Carmine consimilm.te dipinto, in cui vi è l’Iscrizzione seg.te Joanne de Simone pingente= e si è trovato dell’altezza palmi nove e larghezza palm. Sette ed un terzo. Nel Sesto vi è il Quadro di S. Pietro martire dell’altezza pal. Diece meno un terzo, e della larghezza pal. Sette e mezzo, consimil.te dipinto sopra tela in oglio, ed in piè è la seguente iscrizzione = Beatrix Politi F.F. P. sua divozione 1652. Sopra il Coro appeso a un muro vi è il quadro di S. Tomaso di Aquino dipinto consimil.te sopra tela in oglio dell’altezza palmi nove ed un terzo e larghezza pal. Sei e mezzo e due oncie senza iscrizzione. Quali Quadri dopo essersino stati misurati col passetto Napolitano, l’uno dopo l’altro dal sud.o Cadetto assistente, sono stati sugellati, con impronto in cera spagna, e se bene in d.a Chiesa vi siano ancora appesi ne respettivi muri di essa altri piccoli quadri nel num.o di nove, rappresentanti diverse figure, per essere vecchi e di puoco momento, non si è stimato descriverli minutam.te, misurarli e suggelarli. E tutti li quadri di sopra numerati ed annotati, inclusi anche d.i nove quadretti senza innovarsi cosa alcuna, rapporto alla consegna di essi altra volta fatta al Benestante Giuseppe Faragò, rimasero similn.te consegnati allo stesso. Quindi in fede del vero ne ho formato il presente sotto la mia propria mano e per maggior legalità autorizato col solito universal sugello di questo luogo ed a fede.
Pasquale Arcip.te Podia fui presente
Antonio Schipano Luog.te fui presente
Giuseppe Franco Sindaco fui presente
Giuseppe Faragò fui presente
Raffaele Manzi Assistente
Pietro Faragò canc.re certifico come sopra
(ASCz. Fondo Cassa Sacra. Ripartimento di Zagarise. Copia dell’atto, descrizione, misura e suggellamento de’ quadri de luoghi pii di Cropani, Belcastro e Zagarise. Vol. XXI, ff. 8v-9.)

Sigillo dell’università di Zagarise.
The post I luoghi pii di Belcastro, Cropani e Zagarise, attraverso gli atti della Cassa Sacra dell’Archivio di Stato di Catanzaro appeared first on Archivio Storico Crotone.
La chiesa di Santa Maria della Scala in territorio di Belvedere Spinello

La statua della Madonna della Scala di Belvedere Spinello (KR).
La natura del luogo per la sua posizione geografica ci indica l’antichità dell’edificio sacro, resa evidente anche dal titolo della chiesa detta Santa Maria della Scala e dai toponomi: “le Ripe di Santa Maria” e “le Timpe di Santa Maria”. È posto sulla sommità del timpone, un vero e proprio passo e valico, che mette in comunicazione la bassa con la media vallata del Neto. Sul luogo dove è situata la chiesa si incrociano le vie provenienti dalla marina con quelle dalla Sila. Alla fine della “Scala” si unisce quella che risale a destra la vallata e per Santa Severina, passato il fiume, sale sul timpone, con quella che sale al timpone venendo da sinistra del fiume. Dal luogo sacro poi si diparte una via che per gli abitati di Monte Spinello e di Belvedere discende il timpone per la Sila.

In evidenza la chiesa di Santa Maria della Scala (part. della Carta austriaca del Regno di Napoli Sez. 12 – Col. IX).
Possiamo quindi ipotizzare che su questo antico luogo di culto dopo che Ferrante Spinelli (1523-1547) aveva ripopolato con gente albanese il casale, che da lui prese il nome di Montespinello, come in altre situazioni simili, il feudatario o i suoi successori, favorirono la venuta degli Agostiniani, che attorno alla preesistente chiesa costruirono il loro convento.
Il vescovo di Cerenzia Maurizio Ricci (1619-1626) all’inizio del Seicento, in una sua relazione, trattando delle due terre di Belvedere e Montespinello, casali ripopolati da Albanesi, così si esprime: “Queste due terre l’una dall’altra circa meczo miglio, nel meczo delle q(ua)li vi è un principio di Monasterio della Congreg(atio)ne di S.to August(in)o … Haveva detta Relig(io)ne un altro Monasterio buono discosto un miglio. L’hanno lasciato rovinare, et credo che p(rim)a fosse recetto di ladri”.[i]
Il monastero situato tra Belvedere e Montespinello sotto il titolo di Santa Venera detto di Belvedere di Levante, in quanto situato nel territorio del casale di Belvedere, sarà soppresso nel 1652 per bolla di papa Innocenzo X. Dell’altro monastero sempre degli Agostiniani, posto nel territorio di Montespinello, sappiamo che, secondo quanto scrive il vescovo Ricci, esso fu abbandonato perché era divenuto rifugio di ricercati dalla giustizia.
Da queste considerazioni possiamo affermare che durante il Cinquecento, la chiesa di Santa Maria della Scala è stata parte del monastero degli Eremitani agostiniani. Ordine che si sviluppò in Calabria durante quel secolo e che fu particolarmente presente nei paesi abitati da gente albanese. Andato in rovina il convento, rimase la chiesa con le sue rendite, che troviamo citata nel conferimento di un beneficio a favore del prete di Isola Gio. Michele (o Vincenzo) Stazzi o Stozzi. Il Papa Paolo V nell’agosto 1616, prendendo atto che fin dal 1614 era morto il prete Gregorio Miele, possessore della chiesa senza cura di anime di Santa Maria della Scala del casale di Montespinello, nominava lo Stozzi. La chiesa poteva contare su una rendita annua di dodici ducati.[ii] Pochi giorni dopo tuttavia il Papa, ritornando sulle sue decisioni, conferirà il beneficio a Gio. Antonio Livani, un prete della diocesi di Cerenzia.[iii] Da allora in poi la chiesa, ormai ridotta a chiesa rurale ed eremitorio, con le sue rendite verrà aggregata ad uno dei canonicati della cattedrale di Cerenzia.

La via che “va alla Salina” presso il fiume Neto in una vecchia carta.
Canonicato della Chiesa di Cerenzia
Alla metà del Seicento la chiesa senza cura di Santa Maria della Scala è ormai uno dei canonicati della chiesa di Cerenzia. Il papa Innocenzo X nel giugno 1654, essendo il canonicato con i beni della chiesa di Santa Maria delle Scala rimasto vacante per morte di Marcello Baiani (o Baucci), conferisce il beneficio, che ha una rendita di 12 ducati annui, al chierico di Cerenzia Leonardo Menza.[iv] Non passano molti anni che il 19 aprile 1663 il Papa Alessandro VII concede il decanato della cattedrale di Cerenzia a Cesare Benincasa, il quale per assumere la dignità lascia il canonicato di Santa Maria della Scala.[v] Pochi mesi dopo lo stesso Papa lo concede al prete di Cerenzia Georgio Drammis.[vi]
Passano diversi anni e ritroviamo il canonicato all’inizio del Settecento. Sappiamo che nell’ottobre 1716 il prete Donato Quattromani aveva lasciato il canonicato di San Lorenzo della cattedrale di Cerenzia per assumere il nuovo canonicato.[vii]

Santa Maria della Scala a Belvedere-Spinello (KR).
Il canonicato alla metà del Settecento
“Io D. Donato Quattromani Canonico della Chiesa Catedrale di questa Città di Cerenzia[viii] sotto il titolo di Santa Maria della Scala in esecuzione del Concordato fatto tra Sua Beatitudine e la Maestà del Re N.ro Sig.re Dio Guardi con giuramento e sotto le pene in quelle contenuta, rivelo che detto Canonico possiede le seguenti rendite ed esser d’anni 62”. Inizia così la Rivela fatta in Montespinello il 9 agosto 1742 dal canonico per la compilazione del Catasto Onciario di Montespinello.
Dalla testimonianza del prete secolare di Cerenzia sappiamo che la rendita del canonicato stimata in circa dodici ducati annui proveniva dall’affitto per due anni a semina e tre a pascolo, del vignale di Laino, situato in territorio di Montespinello in località Sorriace, confinante con una proprietà feudale, e da quasi una decina di piccoli censi che annualmente pagavano alcuni abitanti di Montespinello su case e chiuse; beni che erano appartenuti alla chiesa e che erano stati poi concessi in enfiteusi ad abitanti di Montespinello.[ix]
I censuari di Santa Maria della Scala riportati dal catasto sono il mastro calzolaio Antonio Gabriele (grana 45 sopra la sua casa), il bracciante Aloisio Grippa (carlini 16), il nobile Domenico Tornicchia (d.ti 1.20 sopra la Chiusa del Molino), la vedova Domenica Caputo (grana 40 sopra la vigna), la vedova Lucrezia Basile (grana 46 sopra la casa), il bracciante Francesco Antonio Russo (sopra la vigna nel luogo detto Chiatretto grana 40).
Dalla descrizione degli obblighi che deve assolvere il canonico di Santa Maria della Scala risulta che annualmente la rendita netta oscillava attorno ai cinque ducati. Oltre a pagare ogni anno quattordici carlini al barone per il vignale di Laino, deve far celebrare numerose messe nella chiesa di Santa Maria della Scala: “Tiene obligo detto Canonico di celebrare due messe nella Chiesa prescritta di S. Maria delle Scala 0.40. Deve fare celebrare una eddomada di messe e di celebrasino nei giorni di mercordì e sabbato in detta chiesa quali messe fanno al numero di 50, che si pagano à grana dodeci, e mezzo lasciate da devoti, che fanno la somma di D.ti 6.25.[x]

Santa Maria della Scala a Belvedere-Spinello (KR).
L’eremitorio di Santa Maria della Scala
Alla morte di Donato Quattromani il canonicato fu concesso a Gennaro Quattromani e morto costui nel gennaio 1802, il beneficio fu concesso al prete di Cerenzia Bernardo de Fazio, “pbr oriundo 50 an., in cantu gregoriano versato”.[xi] Per dimissione del Fazio nel marzo 1822 il canonicato pervenne al prete di 42 anni Agostino Pugliese. La rendita del canonicato era allora valutata in 24 ducati annui, ai quali, a seconda delle annate, potevano essere aggiunti altri 30 ducati.[xii] In seguito al Pugliese fu concessa la dignità di arcidiacono ed il canonicato di Santa Maria della Scala passò al chierico di Santa Severina Marco Antonio Rossi.[xiii]
Francesco Adilardi trattando nel 1847 delle chiese di Montespinello così le descrive: “Colà si noverano le chiese della Trasfigurazione del Signore, arcipretale curata e della Vergine della Scala rurale, amministrata dal capitolo di Gerenzia. A quest’ultima chiesa si unisce un eremitorio il cui titolare vive di elemosina.[xiv]

Santa Maria della Scala a Belvedere-Spinello (KR).
Note
[i] ASV, Rel. Lim. Cariati e Cerenzia, Vescovo Maurizio Ricci, 1621.
[ii] Paolo V. Agosto 1616 (27799) De s.c. ecclesia seu cappella, sub invocatione S. Mariae della Scala, loci casalis Montispinelli, Cariaten. dioc., cuius fructus XII duc., vac. per ob. Gregorii Miele, de an. 1614 def., providetur Io. Michaeli Stazzi (o Stozzi), pbro Insulan. Paolo V. Settembre 1616. (27814) De s.c. ecclesia seu cappella, sub invocatione S. Mariae della Scala, loci casalis Montispinelli, Cariaten. dioc., cuius fructus XII duc., vac. per ob. Gregorii Mida (o Miele), de an. 1614 def., providetur Io. Vincenti Stazzi Insulan.
[iii] Paolo V. Settembre 1616. (27817) De ecclesia, sub invocatione B. Mariae della Scala, loci Montispinelli, Gerentin. dioc., vac. per ob. ultimi possessoris de an. 1614, cuius fructus X duc., providetur Io. Antonio Livari, diacono dictae dioc.; Antonio Livani, parroco di Belvedere Malapezza morirà nel maggio 1637 ed a lui seguirà nel luglio dello stesso anno Gio. Battista Bruno (Russo F., Regesto, 32433).
[iv] Russo F., Regesto, 37322.
[v] Russo F., Regesto, 39852.
[vi] Russo F., Regesto, 39914.
[vii] Russo F., Regesto, 53126.
[viii] D. Donato Quattromani prete secolare di Cerenzia tra i pesi aveva “Alla Ven.le Cappella di S. Agostino di detta Città per censo carlini undici l’anno”. ASN, Catasto Onciario di Cerenzia 1753, n. 6964, f. 58.
[ix] Possede un pezzetto di terre in territorio della Terra di M(ont)e Spinelli, nom.to il Vignale di Laino (in Sorriace), confine li Beni della Cam.ra P(rincipa)le, d’una parte el Vallone dell’altra parte d’estenz.ne di tum.te quattro, q.le dogni cinqu’anni, è solito sementarsi dui,, che coarcerbati l’anni pieni colli vacui, rende annui 1. 64. Sopra alcune case di d.a Terra di M.e Spinelli ne percepisce a d.o Can.co di cenzi annui 5. Sopra alcune chiuse di d.a Terra di M.e Spinelli d.o Can.co ne percipisce annui di cenzo 5.50.
[x] ASN, Catasto Onciario Montespinello 1743, n. 6010. f. 75.
[xi] Russo F., Regesto, 69629.
[xii] Russo F., Regesto, 71878.
[xiii] Russo F., Regesto, 75542.
[xiv] Adilardi F. Del già vescovado di Gerenzia, in Siberene p. 306.
The post La chiesa di Santa Maria della Scala in territorio di Belvedere Spinello appeared first on Archivio Storico Crotone.
La costruzione delle fortificazioni della città di Lipari (settembre 1549 – giugno 1550) e del castello “novo” di Reggio

L’arcipelago delle Eolie rappresentato dal musulmano Piri Reis nella prima metà del Cinquecento.
Nel 1544 il capitano Ariodeno Barbarossa con una forte flotta, assedia e mette a ferro e fuoco la città di Cariati, facendo numerosi schiavi tra i quali anche il vescovo Giovanni Carmuto, o Canuto, che morirà in schiavitù[i] e nel luglio dello stesso anno 1544 anche la città di Lipari fu messa a ferro e fuoco.[ii]
L’anno precedente 1543 c’era stata la devastazione di Reggio.[iii] Nel maggio del 1545, continuando il pericolo, il viceré Don Pedro de Toledo dava ordine al barone Gian Giacomo dela Caya, commissario generale delle regie fabbriche di vedere e provvedere alle fortificazioni, che si dovevano fare nei luoghi costieri ed a dare inizio alla fortificazione di Reggio.

La presa e l’incendio della città di Lipari (1544), rappresentati da una moderna incisione sulla porta bronzea della sua cattedrale.
Il “castello novo” di Reggio
Nonostante la decisione del Toledo, che incarica nel 1545 Giovan Giacomo di Acaia, (il 9 dicembre 1545 il baron dela Caya lascia Reggio per Crotone, da dove poi riparte per la Puglia) commissario per le fabbriche del Regno, di ricostruire la località ed il castello, distrutti dai Turchi due anni prima, Reggio rimane priva di una valida difesa. L’erezione, nel 1547, di un nuovo castello, detto Castel Nuovo o forte a mare, nel lato meridionale della città, in posizione tale da difendere le porte della Dogana e di S. Filippo, determina la deviazione del corso del torrente Calopinace fino al promontorio di Calamizzi. Nonostante la spesa, cui concorre l’università reggina di 7722 scudi e l’iniziale alacrità, i lavori sono sospesi e non più ripresi …”.[iv]

In evidenza il “castello novo” in una carta della “Città di Riggio” (1675). Mafrici M. cit., p. 104
Dopo le devastazioni causate dalla flotta turca il vicerè Don Pedro de Toledo, essendo imperatore Carlo V, decise di esentare dalle tasse ordinarie e straordinarie la città di Reggio e di potenziare le fortificazioni di Reggio e di Lipari. Un ordine del vicerè Don Pedro de Toledo del 9 novembre 1543 diretto alla Regia Camera ordinava “non molestandi dictam uni.tem tam de or.iis q. de exor.iis sed servetur immunis … attenta ruina distructione et dishabitatione ipsius Civ.tis per classem turcarum commissa”.
Tre anni dopo il primo agosto 1546 da Ratisbona, l’imperatore Carlo V inviava una lettera al vicerè con la quale concedeva all’università di Reggio l’immunità dalle funzioni fiscali ordinarie e straordinarie per lo spazio di venti anni “stante ruina depredatione et dispopulatione passa per ipsam Civitatem à classe turcarum a pirata barbarossa”.[v]
Nel settembre 1549 a Reggio si sta costruendo il castello nuovo. I lavori procedono sotto la vigilanza di Baldassar Conill (Coniglio) (1548 – 1550), regio tesoriere della Provincia di Calabria Ultra e tesoriere delle regie fabriche delle città di Crotone, Reggio e Lipari, che fornisce il denaro, mentre Petro Germudes de Santi de Santisso è castellano e generale comissario della regia fabrica della città e del castello nuovo.
Fanno parte della struttura amministrativa della nuova opera lo scrivano de razione Alexandro Scaglione, “deputato per lo Ill.mo duca di Monteleone per hordini di sua Ex.tia”, il luogotenente e pagatore del tesoriere Michel de Proxeta (al quale poi subentrerà Antonio Barbaro), mentre il mastro Aniballe Baliche (Balici), agli ordini dell’architetto Barone dela Caya, è addetto a misurare l’avanzamento dell’opera.
A questi si aggiungerà nel luglio 1550 con uno stipendio di ducati tre al mese Jo. Maria Campelloni “monicioneri et ajutante del scrivano de ratione posto per hordine del S.or Duca per hordine di sua Ex.a” (nel mese dopo troviamo Angelo Mactio Severino). I lavori al castello nuovo di Reggio si prolungheranno fino all’estate dell’anno seguente. È incaricato ad eseguire con i suoi mastri e manipoli la costruzione della fortificazione, eseguendo il progetto del Baron dela Caya, il capomastro della regia fabbrica Vangelista de Mengna. Nell’autunno del 1549 i lavori sono concentrati nel cavamento ed a fare la “impalizzata “dentro l’acqua del spontone di Santo Jacopo. Il “capo mastro de axia” Bastiano Faxali (Faciali) è impegnato con altri mastri ed una ventina di manipoli al “cavamento “dello spontone per far ciò si deve costruire una palizzata dentro il mare. Sette marinai sono intenti con le mazze ad impiantare i pali dentro l’acqua. Si compera il materiale occorrente per fare la palizzata nella vicina città di Messina. Sartie, tabule, travetti grossi de abeto, corda grossa e sottile, ferro, azaro, taglie seu mazi previti che servero per calar et alzar lo tavulato dela gravia, polegi ecc., sono portati con le barche da Messina a Reggio. Si acquista inoltre dai locali numerosa legna seu tratti “che se portano quali servero per la detta impalizata”. Alla fine di dicembre il capomastro Evangelista de Megna aveva dato inizio anche alla costruzione dello spontone Santa Maria. I lavori ai due spontoni continueranno fino ad agosto dell’anno successivo.[vi]

Lipari (da Strafforello G., La Patria. Sicilia. fig. 119).
Le spese
Il denaro stabilito per la fortificazione di Reggio, che il tesoriere di Calabria Ultra Baldassare Conill poteva utilizzare per i pagamenti, era stato stabilito in ducati 4000. Il luogotenente del tesoriere Michele Profeta, che si trovava in Reggio, era incaricato a fare i versamenti.
Il 2 giugno 1550 il commissario Petro Germudes de Santi ordina a Michele Profeta, luogotente del tesoriere, di pagare ducati 1109 tari 3 e grana 10 al capomastro Vamgelista de Mengna. Il pagamento è “per canne di fabrica e misurata per mano delo m.s aniballi balichi, regio misuratore canne otto cento ventidue a ragione di carlini tridichi e mezo la canna”.
Il Megna che fin dal luglio del 1549 ha avuto degli anticipi per un totale di ducati 220, riceve in quel giorno dal luogotenente il rimanente di ducati 889 tari 3 e grana 10. In seguito il capomastro con i suoi mastri e manipoli continua la costruzione degli spontoni, ed il 2 agosto 1550 riceve altri ducati 209 e grana 5 “per canne 303 di frabica fatta e misurata” ed il 4 settembre 1550 altri ducati 200 “per tanta calchi e petra avimo visto condutta in detta regia frabica in detto regio castello”. Inoltre il Mengna durante il periodo di costruzione dal settembre 1549 al giugno 1550 aveva ricevuto in più volte altri denari per spese sostenute e come anticipo per dare inizio alla costruzione dei due spontoni per un totale di ducati 782 e tari 2. Al denaro dovuto al capomastro bisogna aggiungere altri ducati 523 tari 3 e grana 15 per “provisioni ordinari e lignami”, riguardanti gli stipendi, salari e acquisti vari. In tutto nell’annata 1549 /1550 la spesa documentata per la “regia frabica” fu di ducati 2414 – tari 9 e grana 5.
La costruzione del castello nuovo proseguì anche in seguito, mentre le terre accanto, lasciate libere dalla deviazione del fiume, furono occupate abusivamente da alcuni cittadini. Un ordine della Regia Camera della Sommaria diretto al Regio Tesoriere di Calabria Ultra del 4 novembre 1603 gli ordinava di “pigliare possessione delle robbe stabile che possedeno alcuni particolari della Città di Reggio site fra le tempe dello vacuo seu letto dove faceva lo corso lo fiume de San Filippo”.[vii]

Le fortificazioni di Lipari viste dalla Marina Corta.
La fortificazione della città di Lipari
Allo stesso tempo si attivano i lavori di fortificazione della città di Lipari sotto la vigilanza del generale commissario Gonzalo de Armeglia.[viii] Presta la sua opera e segue personalmente i lavori “l’architettor” Jacobo Mal’herba (Malerba), con uno stipendio mensile di 10 ducati, il quale risulta presente a Lipari dal settembre 1549 al Giugno 1550*.
Fanno parte della struttura amministrativa della “Regia fabrica de Lipare” lo scrivano de razione Julio Cesare Bacchino (ducati 7 al mese), il luogotenente del regio tesoriere di Calabria Ultra George (Jorge) Hurtado (ducati 6 al mese), il munizioniere e soprastante Jovan de Giaen (al quale seguirà dal gennaio 1550 Geronimo del Valle) (ducati 2 tari 2 e grana 10 al mese) e lo scrivano Alvaro de Viana (dal gennaio 1550 Lorenzo de Saravia) (ducati 3 al mese).
I lavori di fortificazione iniziati nel mese di settembre 1549 cesseranno alla fine di giugno 1550 essendo finiti i duemila ducati stanziati per l’annata dell’ottava indizione 1549/1550. Per la mancanza di denaro I lavori terminano quasi due mesi prima della fine prevista, anzi rimangono ancora da pagare lo stipendio mensile di Giugno all’architetto Giacomo Malerba e parte di quello dovuto allo scrivano Lorenzo de Saravia. (“A Lorenzo de Saravia scrivano sopra ditta R.ia fabrica per tener li cunti appartati per il Mag.co S.or Comissario duc.ti uno tari tre et gr. setti e mezo, quali son in parte dela sua provisione de la presente mesata, et lo restante a suo complimento de duc.tre non se li è pagato à causa che dele due millia duc.ti dela presente annata non c’è più denari et similmente si resta à pagare la presente mesata allo Architettore per la causa preditta).[ix]

Le fortificazioni di Lipari viste dal mare.
Mastri e manipoli
Capomastro della regia fabbrica di Lipari è Mastro Angelo Bene Incasa della città di Cava. Egli ha anche il compito di pagare i mastri ed i manipoli, che lavorano al suo servizio e di eseguire i lavori di costruzione. Per questo motivo riceve il denaro occorrente per procedere e far fronte ai salari per mastri e manipoli al suo servizio e reperire il materiale.
Dall’analisi dei versamenti di denaro fatti da Giorge Hurtado, incaricato dal tesoriere Baldassar Conill, al capomastro e dai pagamenti effettuati dallo stesso ai Liparoti, che forniscono la calce, possiamo farci un’idea del procedere dei lavori.
Iniziati nel settembre 1549 i lavori procedono a rilento durante i mesi invernali, soprattutto spesso si interrompono nei mesi di dicembre 1549 e febbraio marzo 1550. La probabile causa è il maltempo e le burrasche marine, dovendo la fabbrica rifornirsi di calce via mare dalla città di Patti, che si trova in Sicilia.
Denaro consegnato al capomastro per pagare anche i mastri ed i manipoli
Settembre: 68 – 0 – 0
Ottobre: –
Novembre: 232 – 0 – 0
Dicembre: 2 – 3 – 5
Gennaio: 302 – 3 – 3
Febbraio: –
Marzo: –
Aprile: 300 – 0 – 0
Maggio: 35 – 0 – 0
Giugno: 4 – 0 – 0

Lipari (ME).
La calce
Per poter costruire le fortificazioni si usava la calce proveniente dalla città di Patti, situata sulla sponda siciliana di fronte all’isola di Lipari. Ogni salma di calce portata alla Regia fabrica costava quattro tari “dela moneta di Sicilia”, che equivalevano a 36 grana della moneta del Regno. Durante il periodo considerato nella città di Patti furono imbarcate e portate a Lipari 2191 salme e tomoli 6 di calce. Gestirono questo commercio solo sette Liparoti: Ciano Pantaleo, Francesco de Bastiano alias gambagrossa, Minico Lupo, Francesco Malvito, Agostino Pagano, Alfonso Giani e Nardo Piacente. I soli Francesco de Bastiano detto “gambagrossa” e Francesco Malvito fornirono l’ottantasei per cento della calce.
Salme di Calce portate da Patti e vendute alla Regia Fabrica di Lipari
Calce tari 4 la salma (Moneta Sicilia) = Grana 36 la salma (Moneta Regno) / 1 salma = 16 tomoli
Settembre: 239,5
Ottobre: 321
Novembre: 160
Dicembre: –
Gennaio: 48
Febbraio: 137
Marzo: 183
Aprile: 478,5 e t.a 11
Maggio: 383 e t.a 11
Giugno: 240
Totale: 2191 e t.a 6
Liparoti fornitori della calce
Francesco Malvito: 962,5 t.a 4 (settembre 1549 – giugno 1550).
Francesco de Bastiano alias gambagrossa: 919 t.a 35 (settembre 1549 – giugno 1550).
Ciano Pantaleo: 120 (settembre 1549 – novembre 1549).
Nardo Piacente: 115, 5 t.a 3 (aprile 1550 – giugno 1550).
Alfonso Giani: 40 (novembre 1549).
Agostino Pagano: 20 (ottobre 1549).
Minico Lupo: 10 (settembre 1549).

Cattedrale di San Bartolomeo di Lipari (ME).
Il denaro
Il denaro stabilito per l’annata 1549/1550 (VIII Indizione) è di ducati 2000. I versamenti sono concentrati nei mesi di novembre, gennaio e soprattutto in aprile, quando approssimandosi la bella stagione il pericolo turco era più incombente.
Dall’analisi delle spese risulta che i duemila ducati furono così ripartiti: spese per stipendi ducati 275 (14 %), per fornitura della calce ducati 780 tari 3 e grana 12 (39 %) ed i rimanenti ducati 944 tari 1 e grana 8 (47%) fu gestito direttamente dal capo mastro Angelo Bene Incasa della città di Cava per pagare i mastri ed i manipoli e tutto ciò che era necessario per la costruzione.
Spese in ducati per l’annata 1549/1550 VIII Ind.
Settembre 1549: 183 – 4 – 19 ½.
Ottobre 1549: 145 – 4 – 15.
Novembre 1549: 318 – 4 – 7 ½.
Dicembre 1549: 31 – 0 – 15.
Gennaio 1550: 350 – 4 – 18 ½.
Febbraio 1550: 78 – 1 – 12 ½.
Marzo 1550: 94 – 4 – 6.
Aprile 1550: 502 – 4 – 15 ½.
Maggio 1550: 184 – 2 – 5.
Giugno 1550: 108 – 2 – 5 ½.
Totale ducati 200. (in media duc. 200 al mese).

Il primo foglio del documento riguardante la fortificazione della città di Lipari (ASN, Dip. Som. 197, ff. 288 – 329).
Il documento
(f. 289r)
Cedula di pagam(en)to fatto per il Mag.co Baldassar Conill R.io Th.ro de Calabria Ultra et in sua absentia et suo nome per mano del M.co Giorge Hurtado, deputato per esso M.co Th.ro pagator e Th.ro q. in Lipar per le despese fano in la fortificatione con intervento de me Julio Cesar Bacchino, deputato per l’Ill.mo S.or Duca de Mont.ne (Ettore II Pignatelli) per or.ne de Sua Ecc.tia scrivano de alla despesa p.ta.
Adi primo de Settembre VIII ind.e 1549 per tutto l’ult(im)o del medesimo.
A Ciano Pantaleo de Lipari per salme trenta de calce portata da Patti et venduta a questa R.ia fabrica a ragione de tari quattro la salma dela moneta de Sicilia, quali redutti a moneta de Regno sono duc.ti deci tari quatt.o et gr. undeci cor. dico 10 – 4 – 11.
A Fran.co de Bast.no al.s gambagrossa de Lipari per salme trenta de calce portata da Patti et venduta a questa R.ia fabrica a la ragione sopra ditta quali redutti a moneta de Regno son duc.ti deci tari quatt.o et gr. undeci dico 10 – 4 – 11.
A minico Lupo de Lipari per salme dece de calce portata da Patti et venduta ala sopra ditta ragione ala R.ia fabrica quali redutti a moneta de Regno son duc.ti tre tari tre et grana
21 – 4 – 2
(f. 289v)
tre e mezo dico 3 – 3 – 3 ½.
A fran.co de Bast.no al.s gambagrossa de Lipari per salme trentacinque de calce portata da patti et venduta a questa R.ia fabrica à ragione de tari quatt.o la salma de la moneta de Sicilia, quali redutti a moneta del Regno sono duc.ti dodeci tari tre et gr. tredeci dico 12 – 3 – 13.
A fran.co Malvito de Lipari per salme quarantatre de calce pagati à ragione del sopra detto cunto duc.ti quindeci tari tre et gr. sidici dico 15 – 3 – 16.
Et al medesimo fran.co malvito de Lipari per salme cinquanta quattro de calce ala medesima ragione duc,ti decenovi et tari quattro dico 19 – 4 – 0.
A fran.co Bast.no als gambagrossa de Lipari per salme trentasetti e meza di calce venduta ala sopra ditta ragione duc.ti tredici tari tre et gr. quindeci dico 13 – 3 – 15.
A m(ast)ro Angelo Bene incasa dela cava capom.ro in questa R.ia fabrica duc.ti sessanta otto cor. per pagar m.ri e manipoli che hanno fatto servi.o in ditta R.ia fabrica, li quali vanno a suo bon cunto dico 68 – 0 – 0.
Al Mag.co Jac.o mal’herba Architettore in d.ta R.ia fabrica duc.ti deci cor. per sua pro.ne del presente mese dico 10 – 0 – 0.
143 – 3 – 7 ½
(f. 290r)
A me Julio Cesare Bacchino scrivano de ratione in ditta R.ia fabrica per mia provisione del presente mese duc.ti setti cor. dico 7 – 0 – 0.
Al Mag.co Giorge Hurtado pagatore ala despesa di ditta R.ia fabrica duc. Sei cor. per sua provisione del presente mese dico 6 – 0 – 0.
A Jova de Giaen monitionero et soprastante in ditta R.ia fabrica duc.ti dui tari dui etr gr. deci cor. per sua provisione del presente mese dico 2 – 2 – 10.
Ad Alvaro de Viana scrivano sopra d.ta R.ia fabrica per tener li cunti apartati del M.co S.or Comiss.o duc.ti tre cor. per sua provisione del presente mese dico 3 – 0 – 0.
Lo sopra ditto pagamento fatto per lo M.co Baldassar Conill R.io Th.ro de Calabria Ultra et per sua absentia et suo nome per mano del M.co Giorge Hurtado suo loc.te deputato per esso M.co Th.ro in ditta R.ia fabrica de Lipari summa duc.ti cento ottanta tre tari quattro et gr. decenovi e mezo, despesi et pagati da lo primo de settembre VIII Ind.e 1549 per tutto l’ultimo del medesimo mese incominzando dala prima partita de ciano pantaleo de duc.ti deci tari quattro et gr. undeci.
(f. 290v)
Et finisce all’ultima de Alvaro de Viana de duc.ti tre per le cause sopra narrate con intervento de me Julio Cesare Bacchino, deputato per l’Ill.mo S.or duca de Mont.ne per or.ne de sua Ecc.tia scrivano de ratione in ditta R.ia fabrica Et in fidem ho fatto la presente cedula scritta et sotto scritta de mia pp.a mano. Data in Lipari die et anno ut s.a
Io Julio Cesare de Bacchino scrivano de ratione
(f. 294r)
Cedula di pagamento fatto per lo Mag.co Baldassar Conill R.io Th.ro de Calabria Ultra et in sua absentia et suo nome per mano del Mag.co Giorgio Hurtado, deputato per lo sopra detto M.co Th.ro pagatore Th.ro q. in la Città de Lipari per le despese se fano in la fortificatione de me Julio Cesare Bacchino deputato per lo Mag.co S.or Duca de Mont.ne per or.e de sua Ecc.tia scrivano de ratione ala despesa p.ta.
Adi p.o de ottobre VIII Ind.e 1549 per tutto l’ult.o del medesimo.
A fran.co de Bastiano als gambagrossa de Lipari per salme vintisei de calce portata da Patti et venduta a questa R.ia fabrica a ragione de tari quattro la salma de la moneta de Sicilia, quali redutti a moneta del Regno sono duc.ti novi tari dui et gr. tredici dico 9 – 2 – 13.
A fran.co Malvito de Lipari per salme quaranta de calce pagate ala sopra ditta ragione duc.ti quattordici tari dui et grana decesetti dico 14 – 2 – 17.
Ad Agostino Pagano de Lipari per salme vinti de calce pagate ala sopra ditta ragione duc.ti setti tari uno et gr. dodici dico 7 – 1 – 12.
31 – 2 – 2.
(f. 294v)
A fran.co de Bastiano als gambagrossa de Lipari per salme quaranta de calce pagate ala med.a ragione de tari quattro la salma de la moneta de Sicilia, quali redutti a moneta de Regno sono duc.ti quattordici tari dui et gr. decesetti dico 14 – 2 – 17.
A fran.co Malvito de Lipari per salme cinquanta de calce pagate a la sopra ditta ragione duc.ti dece dotto tari uno et gr. deci dico 18 – 1 – 10.
A ciano Pantaleo de Lipari per salme quaranta cinque de calce pagate ala ragione sopra ditta duc. Sidici tari dui et gr. deci dico 16 – 2 – 10.
A fran.co de Bastiano als gambagrossa de Lipari per salme quaranta cinque de calce pagate ala ragione sopra ditta duc.ti sidici tari dui gr. deci dico 16 – 2 – 10.
A fran.co Malvito de Lipari per salme cinquanta cinque de calce pagate ala ragione sopra ditta duc.ti vinti et gr. sidici dico 20 – 0 – 16.
Al M.co Jacobo Mal herba Architettore in la R.ia fabrica p.ta duc.ti deci per sua provisione del presente mese dico 10 – 0 – 0.
A me Julio Cesar Bacchino per l’off.io de scrivano de ratione de d.ta R.ia fabrica duc.ti setti per sua provisione del presente mese dico 7 – 0 – 0.
103 – 0 – 3.
(f. 295r)
Al Mag.co Giorgio Hurtado pagator a la despesa de d.ta R.ia fabrica duc.ti sei per sua provisione del presente mese dico 6 – 0 – 0.
A Jovan de Giaen monitionero et soprastante in d.ta R.ia fabrica duc.ti dui tari dui et gr. deci per sua provisione del presente mese dico 2 – 2 – 10.
Ad Alvaro de Viana scrivano sopra d.ta R.ia fabrica per tener li cunti appartati del S.or Comissario duc.tre cor. per sua provisione del presente mese 3 – 0 – 0.
145 – 4 – 15
(f. 298r)
Cedula di pagamento fatto per lo Mag.co Baldassar Conill R.io Th.ro de Calabria Ultra et in sua absentia et suo nome per mano del Mag.co Giorgio Hurtado, deputato per lo sopra detto M.co Th.ro pagatore Th.ro q. in la Città de Lipari per le despese se fano in la fortificatione de me Julio Cesare Bacchino deputato per lo Mag.co S.or Duca de Mont.ne per or.e de sua Ecc.tia scrivano de ratione ala despesa p.ta.
Adi p.o Novembre VIII Ind.e 1549 per tutto l’ultimo del medesmo
A mastro Angelo Bene Incasa de la Cava capo mastro in questa R.ia fabrica duc.ti ducento trenta dui cor., li quali si son pagati a lui di contanti per pagare li mastri e manipoli che hanno fatto per lui servigio ala fabrica et vanno a suo bon cunto dico 232 – 0 – 0.
A fran.co Malvito de Lipari per salme quaranta sette de calce portata da patti et venduta à questa R.ia fabrica a ragione di tari quattro la salma dela moneta di Sicilia, quali redutti a moneta de Regno so ducati decesetti et gr. otto cor. dico 17 – 0 – 8.
A Ciano Pantaleo de Lipari per salme quaranta cinque de calce venduta a questa R.ia fabrica ala sopra ditta ragione duc.ti sidici tari uno et gr. sidici e mezo dico 16 – 1 – 16 ½.
265 – 2 – 4 ½.
(f. 298r)
Ad Alfonso Giani de Lipari per salme quaranta de calce portata da Patti venduta à questa R.ia fabrica a tari quattro la salma dela moneta de Sicilia, quali redutti a moneta de Regno so ducati quattordici tari tre et gr. sei e mezo dico 14 – 3 – 6 ½.
A francesco de Bastiano als gambagrossa de Lipari per salme vint’otto de calce venduta ala R.ia fabrica a la sopra ditta ragione duc.ti deci tari uno et gr. sei e mezo cor. dico 10 – 1 – 6 ½.
Al mag.co Jacobo Mal’herba Architettor in d.ta R.ia fabrica duc.ti deci cor. per sua provisione del presente mese dico 10 – 0 – 0.
A me Julio Cesar Bacchino per l’off.io de scrivano de ratione per mia provisione del presente mese duc.ti setti cor. dico 7 – 0 – 0.
Al Mag.co Giorgio Hurtado pagatore ala despesa di d.ta R.ia fabrica duc.ti sei per sua provisione del presente mese dico 6 – 0 – 0.
A Jovan de Giaen monitionero et soprastante in d.ta R.ia fabrica duc.ti dui tari dui et gr. deci cor. per sua provisione del presente mese dico 2 – 2 – 10.
Ad Alvaro de Viana scrivano sopra d.ta R.ia fabrica per tener li cunti apartati del Mag.co Comissario duc.ti tre per sua provisione del presente mese dico 3 – 0 – 0.
53 – 2 – 3.
265 – 2 – 4 ½.
318 – 4 – 7 ½.
(f. 302r)
Cedula di pagamento fatto per lo Mag.co Baldassar Conill R.io Th.ro de Calabria Ultra et in sua absentia et suo nome per mano del Mag.co Giorgio Hurtado, deputato per lo sopra detto M.co Th.ro pagatore Th.ro q. in la Città de Lipari per le despese se fano in la fortificatione de me Julio Cesare Bacchino deputato per lo Mag.co S.or Duca de Mont.ne per or.e de sua Ecc.tia scrivano de ratione ala despesa p.ta.
Adi p.o di Xbro VIII Ind.e 1549 per tuttol’ultimo del medesmo.
A mastro Angelo Bene Incasa dela cava capo mastro in questa R.ia fabrica de Lipari duc.ti dui tari tre et gr. cinque correnti et vanno a suo bon cunto dico 2 – 3 – 5.
Al mag.co Jacobo Mal Herba Architettor in la sopra ditta R.ia fabrica ducati dece correnti per sua provisione del presente mese dico 10 – 0 – 0.
A me Julio Cesare Bacchino per l’off.io de scrivano de ratione in ditta R.ia fabrica ducati setti cor. per mia provisione del presente mese dico 7 – 0 – 0.
Al Mag.co Giorgio Hurtado pagato ala despesa di ditta R.ia fabrica duc.ti sei cor. per sua provisione del presente mese dico 6 – 0 – 0.
25 – 3 – 5.
(f. 302v)
A Jouan de Giaen monitionero et soprastante in questa preditta R.ia fabrica duc.ti dui tari dui et grana deci correnti per sua provisione del presente mese dico 2 – 2 – 10.
Ad Alvaro de Viana scrivano sopra ditta R.ia fabrica per tener li cunti appartati del Mag.co S. Comissario duc.ti tre cor. per sua provisione del presente mese 3 – 0 – 0.
5 – 2 – 10.
25 – 3 – 5.
31 – 0 – 15.
(f. 304r)
Cedula di pagamento fatto per lo Mag.co Baldassar Conill R.io Th.ro de Calabria Ultra et in sua absentia et suo nome per mano del Mag.co Giorgio Hurtado, deputato per lo sopra detto M.co Th.ro pagatore Th.ro q. in la Città de Lipari per le despese se fano in la fortificatione de me Julio Cesare Bacchino deputato per lo Mag.co S.or Duca de Mont.ne per or.e de sua Ecc.tia scrivano de ratione ala despesa p.ta.
Adi p.o di Jennaro VIII Ind.e 1550 per tutto l’ultimo del medesmo.
A mastro Angelo Bene Incasa dela cava capomastro di questa R.ia fabrica di Lipari duc.ti sei tari quattro et gr. deci cor. li quali vano a suo bon cunto dico 6 – 4 – 10.
Et a m.ro Angelo Bene Incasa de la cava capo mastro sopra ditto duc.ti sei tari quattro et gr. deci cor. in alia mano, li quali vano a suo bon cunto dico 6 – 4 – 10.
A fran.co de bastiano als gambagrossa de Lipari per salme quarant’otto de calce portata da Patti et venduta a questa R.ia fabrica de Lipari a ragione de tari quattro la salma de moneta di Sicilia, quali redutti a moneta de Regno son ducati deci sette tari due et gr. cinque e mezo cor. dico 17 – 2 – 5 ½.
31 – 1 – 5 ½.
(f. 304v)
Et piu a Angelo Bene Incasa dela cava capo mastro di questa R.ia fabrica de Lipari in alia mano duc.ti ducento ottant’otto tari quattro e grana tre cor. quali se li sono pagati a lui de contanti per pagar li mastri e manipoli, che per lui sono andati a ditta R.ia fabrica et vanno a suo bon cunto dico 288 – 4 – 3.
Et tre risme de carta da scriver la quale serve per far cedule, mandati et altri cunti de questa R.ia fabrica, la quale carta costò a ragione de car.ni otto la risma, sono in tutti 2 – 2 – 0.
Al m.co Jacobo Mal’herba Architettor de questa R.ia fabrica de Lipari duc.ti deci per sua provisione del presente mese dico 10 – 0 – 0.
A me Julio Cesare Bacchino per l’off.io de scrivano de ratione de questa R.ia fabrica duc.ti setti cor. per mia provisione del presente mese dico 7 – 0 – 0.
Al mag.co Giorgio Hurtado pagator ala despesa di ditta R.ia fabrica duc.ti sei cor. per sua provisione del presente mese dico 6 – 0 – 0.
A lorenzo de Saravia scrivano sopra ditta R.ia fabrica per tener li cunti appartati del m.co S.or Comissario duc.ti tre cor. per sua provisione del presente mese dico 3 – 0 – 0.
317 – 1 – 3
(f. 305r)
A Geronimo del Valle per monitionero et soprastante de questa R.ia fabrica duc.ti dui tari dui et gr. deci cor. per provisione del presente mese dico 2 – 2 – 10.
350 – 4 – 18 ½.
(f. 310r)
Cedula di pagamento fatto per lo Mag.co Baldassar Conill R.io Th.ro de Calabria Ultra et in sua absentia et suo nome per mano del Mag.co Giorgio Hurtado, deputato per lo sopra detto M.co Th.ro pagatore Th.ro q. in la Città de Lipari per le despese se fano in la fortificatione de me Julio Cesare Bacchino deputato per lo Mag.co S.or Duca de Mont.ne per or.e de sua Ecc.tia scrivano de ratione ala despesa p.ta.
Adi p.o de febraro VIII Ind.e 1550 per tutto l’ultimo del medesimo mese.
A fran.co de Bastiano als gambagrossa de Lipari per salme quarant’otto de calce portata da Patti et venduta a questa R.ia fabrica à ragione de tari quattro la salma de la moneta de Sicilia quali redutti a moneta de Regno sono duc.ti decisetti tari due et gr. cinque et mezo cor. dico 17 – 2 – 5 ½.
A fran.co de Bastiano als gambagrossa de Lipari sopra ditto per salme quarantacinque e meza de calce portata da Patti et venduta a la sopra dittta ragione, quali redutti a moneta de Regno sono duc.ti sidici tari dui et gr. quindeci cor. dico 16 – 2 – 15
34 – 0 – 0 ½.
(f. 310v)
A fran.co Malvito de Lipari per salme quarantatre et meza de calce portata da Patti et venduta ala medesima ragione de tari quattro la salma dela moneta de Sicilia, quali redutti a moneta de Regno so ducati quindici tari quattro et gr. dui cor. dico 15 – 4 – 2.
Al Mag.co Jacobo Mal’herba Architettore dela sopra ditta R.ia fabrica duc.ti deci cor. per sua provisione del presente mese dico 10 – 0 – 0.
A me Julio Cesare Bacchino per l’off.io de scrivan de ratione in ditta R.ia fabrica duc.ti setti cor. per mia provisione del presente mese dico 7 – 0 – 0.
Al Mag.co Giorgio Hurtado pagator alla despesa de ditta R.ia fabrica duc.ti sei cor. per sua provisione del presente mese dico 6 – 0 – 0.
A Geronimo del Valle monitionero et soprastante in ditta R.ia fabrica duc.ti dui tari dui et gr. deci correnti per sua provisione del presente mese dico 2 – 2 – 10.
A Lorenzo de Saravia scrivano sopra ditta R.ia fabrica per tener li cunti appartati per il Mag.co S.or Comissario duc.ti tre cor. per sua provisione del presente mese dico 3 – 0 – 0.
44 – 1 – 12 ½.
34 – 0 – 0 ½.
78 – 1 – 12 ½.
(f. 314r)
Cedula di pagamento fatto per lo Mag.co Baldassar Conill R.io Th.ro de Calabria Ultra et in sua absentia et suo nome per mano del Mag.co Giorgio Hurtado, deputato per lo sopra detto M.co Th.ro pagatore Th.ro q. in la Città de Lipari per le despese se fano in la fortificatione de me Julio Cesare Bacchino deputato per lo Mag.co S.or Duca de Mont.ne per or.e de sua Ecc.tia scrivano de ratione ala despesa p.ta.
Adi p.o de Marzo VIII Ind.e 1550 per tutto l’ultimo del medesimo mese.
A fran.co Malvito de Lipari per salme quaranta cinque de calce portata da Patti et venduta per questa R.ia fabrica a ragione de tari quattro la salma de la moneta de Sicilia, quali redutti a moneta de Regno son duc.ti sidici tari uno et gr. sidici dico 16 – 1 – 16.
A fran.co de Bastiano als gambagrossa de Lipari per salme trentotto e meza de calce portata da Patti et venduta per questa R.ia fabrica a la ragione sopra ditta et sono de moneta de Regno duc.ti tridici tari quattro et gr. dui cor. dico 13 – 4 – 2.
30 – 0 – 18 ½.
(f. 314v)
A fran.co de Bastiano retroditto als gambagrossa de Lipari per salme quarantasei e meza de calce portata da Patti et venduta per questa R.ia fabrica a la ragione sopra ditta et sono de moneta de Regno duc.ti sedici tari quattro et gr. deci cor. dico 16 – 4 – 10.
A fran.co Malvito de Lipari per salme undeci e meza de calce portata da Patti et venduta per questa R.ia fabrica a ragione de tari quattro la salma de la moneta de Sicilia, quali redutti a moneta de Regno son duc.ti quattro et gr. deceotto dico 4 –0 – 18 ½.
A fran.co de Bastiano als gambagrossa de Lipari per salme quarant’una e meza de calce portata da Patti et venduta per questa R.ia fabrica a la ragione sopra ditta et sono de moneta de Regno duc.ti quindici et gr. novi cor. dico 15 – 0 – 9.
Al m.co Jacobo Mal’herba Architettor de questa R.ia fabrica de Lipari duc.ti deci per sua provisione del presente mese dico 10 – 0 – 0.
A me Julio Cesare Bacchino per l’off.io de scrivan de ratione in ditta R.ia fabrica duc.ti setti cor. per mia provisione del presente mese dico 7 – 0 – 0.
Al Mag.co Giorgio Hurtado pagator alla despesa de ditta R.ia fabrica duc.ti sei cor. per sua provisione del presente mese dico 6 – 0 – 0.
A Geronimo del Valle monitionero et soprastante in ditta R.ia fabrica duc.ti dui tari dui et gr. deci correnti per sua provisione del presente mese dico 2 – 2 – 10.
A Lorenzo de Saravia scrivano sopra ditta R.ia fabrica per tener li cunti appartati per il Mag.co S.or Comissario duc.ti tre cor. per sua provisione del presente mese dico 3 – 0 – 0.
11 – 2 – 10.
30 – 0 – 18 ½.
53 – 0 – 17 ½.
94 – 4 – 6.
(f. 318r)
Cedula di pagamento fatto per lo Mag.co Baldassar Conill R.io Th.ro de Calabria Ultra et in sua absentia et suo nome per mano del Mag.co Giorgio Hurtado, deputato per lo sopra detto M.co Th.ro pagatore Th.ro q. in la Città de Lipari per le despese se fano in la fortificatione de me Julio Cesare Bacchino deputato per lo Mag.co S.or Duca de Mont.ne per or.e de sua Ecc.tia scrivano de ratione ala despesa p.ta.
Adi p.o de Aprile VIII Ind.e 1550 per tutto l’ultimo del medesimo mese.
A fran.co Malvito de Lipari per salme cinquanta cinque e meza de calce portata da Patti et venduta per questa R.ia fabrica a ragione de tari quattro la salma de la moneta de Sicilia, quali redutti a moneta de Regno son duc.ti vinti et gr. deci setti e meza dico 20 –0 – 17 ½.
A mastro Angelo Bene Incasa de la Cava capo mastro in questa R.ia fabrica duc.ti trecento cor., et se li son pagati a suo bon cunto, deli quali ne ha pagato mastri e manipoli che per lui son andati a la R.ia fabrica preditta dico 300 – 0 – 0.
A fran.co Malvito de Lipari per salme cinquantadue e meza de calce portata da Patti et venduta per questa R.ia fabrica a ragione de tari quattro la salma de la moneta de Sicilia, quali redutti a moneta de Regno son duc.ti decinovi et gr. otto e mezo cor. dico 19 – 0 – 8 ½.
339 – 1 – 6.
(f. 318v)
A fran.co de Bastiano als gambagrossa de Lipari per salme trentanovi de calce portata da Patti et venduta per questa R.ia fabrica a la ragione sopra ditta et sono de moneta de Regno duc.ti quattordici e gr. deceotto cor. dico 14 – 0 – 18.
Al medesimo fran.co de Bastiano als gambagrossa de Lipari per salme cinquanta setti e t.a dodeci de calce portata da Patti et venduta per questa R.ia fabrica a la ragione sopra ditta et sono de moneta de Regno duc.ti vint’uno cor. dico 21 – 0 – 0.
A fran.co Malvito de Lipari per salme sessanta e t.a quattro de calce portata da Patti et venduta per questa R.ia fabrica a ragione de tari quattro la salma de la moneta de Sicilia, quali redutti a moneta de Regno son duc.ti vint’uno tari quattro et gr. undeci cor. dico 21 – 4 – 11.
A Nardo Piacente de Lipari per salme trenta setti e t.a tre de calce potata da Patti et venduta a questa R.ia fabrica a ragione de tari quattro la salma dela moneta de Sicilia quali redutti a moneta de Regno son duc.ti tredici tari tre et gr. dui cor. dico 13 – 3 – 2.
A fran.co Malvito de Lipari per salme cinquanta quattro de calce portata da Patti et venduta per questa R.ia fabrica a ragione de tari quattro la salma de la moneta de Sicilia, quali redutti a moneta de Regno son duc.ti decinove tari tre et gr. tre cor. dico 19 – 3 – 3.
90 – 1 – 14.
(f. 319r)
A Nardo Piacente de Lipari per salme vinticinque de calce portata da Patti et venduta a questa R.ia fabrica a ragione de tari quattro la salma dela moneta de Sicilia quali redutti a moneta de Regno son duc.ti nov et gr. tredici cor. dico 9 – 0 – 13.
A fran.co de Bastiano als gambagrossa de Lipari per salme quaranta cinque e t.a dodeci de calce portata da Patti et venduta per questa R.ia fabrica a la ragione sopra ditta et sono de moneta de Regno duc.ti sidici tari tre e gr. quattro cor. dico 16 – 3 – 4.
A fran.co Malvito de Lipari per salme cinquanta due e meza de calce portata da Patti et venduta per questa R.ia fabrica a ragione de tari quattro la salma de la moneta de Sicilia, quali redutti a moneta de Regno son duc.ti decinove et gr. otto e mezo cor. dico 19 – 0 – 8 ½.
Al Mag.co Jac.o mal’herba Architettore in d.ta R.ia fabrica duc.ti deci cor. per sua pro.ne del presente mese dico 10 – 0 – 0.
A me Julio Cesare Bacchino per l’off.io de scrivan de ratione in ditta R.ia fabrica duc.ti setti cor. per mia provisione del presente mese dico 7 – 0 – 0.
61 – 4 – 5 ½.
(f. 319v)
Al Mag.co Giorgio Hurtado pagator alla despesa de ditta R.ia fabrica duc.ti sei cor. per sua provisione del presente mese dico 6 – 0 – 0.
A Geronimo del Valle monitionero et soprastante in ditta R.ia fabrica duc.ti dui tari dui et gr. deci correnti per sua provisione del presente mese dico 2 – 2 – 10.
A Lorenzo de Saravia scrivano sopra ditta R.ia fabrica per tener li cunti appartati per il Mag.co S.or Comissario duc.ti tre cor. per sua provisione del presente mese dico 3 – 0 – 0.
11 – 2 – 10.
(f. 324)
Cedula di pagamento fatto per lo Mag.co Baldassar Conill R.io Th.ro de Calabria Ultra et in sua absentia et suo nome per mano del Mag.co Giorgio Hurtado, deputato per lo sopra detto M.co Th.ro pagatore Th.ro q. in la Città de Lipari per le despese se fano in la fortificatione de me Julio Cesare Bacchino deputato per lo Mag.co S.or Duca de Mont.ne per or.e de sua Ecc.tia scrivano de ratione ala despesa p.ta.
Adi p.o de maggio VIII Ind.e 1550 per tutto l’ultimo del medesimo mese.
A m.ro Angelo Bene Incasa dela cava capo m.ro de questa R.ia fabrica de Lipari duc.ti deci cor. pagati a lui de contanti et vano a suo bon cunto dico 10 – 0 – 0.
A fran.co de Bastiano als gambagrossa de Lipari per salme vinti sei de calce portata da Patti et venduta a questa R.ia fabrica à ragione de tari quattro la salma de la moneta de Sicilia quali redutti a moneta de Regno sono duc.ti novi tari due et gr. cinque cor. dico 9 – 2 – 5.
A fran.co Malvito de Lipari per salme cinquanta una de calce portata da Patti et venduta per questa R.ia fabrica a ragione de tari quattro la salma de la moneta de Sicilia, quali redutti a moneta de Regno son duc.ti diciotto tari due et gr. quattordici cor. dico 18 – 2 – 14.
A Nardo Piacente de Lipari per salme trenta de calce potata da Patti et venduta a questa R.ia fabrica a ragione de tari quattro la salma dela moneta de Sicilia quali redutti a moneta de Regno son duc.ti deci tari quattro et gr. undici cor. dico 10 – 4 – 11.
48 – 4 – 10.
(f. 324v)
A m.ro Angelo Bene Incasa dela cava capo m.ro de questa R.ia fabrica de Lipari duc.ti vinticinque cor. pagati a lui de contanti et vano a suo bon cunto dico 25 – 0 – 0.
A fran.co de Bastiano als gambagrossa de Lipari per salme cinquanta quattro e t.a setti de calce portata da Patti et venduta per questa R.ia fabrica a la ragione sopra ditta et sono de moneta de Regno duc.ti decinovi tari tre e gr. decinovi e mezo cor. dico 19 – 3 – 19 ½.
A fran.co Malvito de Lipari per salme cinquanta sei e meza de calce portata da Patti et venduta per questa R.ia fabrica a ragione de tari quattro la salma de la moneta de Sicilia, quali redutti a moneta de Regno son duc.ti vinti tari due et gr.quattordici cor. dico 20 – 2 – 14.
A fran.co de Bastiano als gambagrossa de Lipari per salme cinquantotto e t.a quattro de calce portata da Patti et venduta per questa R.ia fabrica a la ragione sopra ditta et sono de moneta de Regno duc.ti vintiuno e gr. decisette e mezo cor. dico 21 – 0 – 17 ½.
A fran.co Malvito de Lipari per salme cinquanta sei e meza de calce portata da Patti et venduta per questa R.ia fabrica a ragione de tari quattro la salma de la moneta de Sicilia, quali redutti a moneta de Regno son duc.ti vinti tari due et gr.quattordici cor. dico 20 – 2 – 14.
Al Mag.co Jac.o mal’herba Architettore in d.ta R.ia fabrica duc.ti deci cor. per sua pro.ne del presente mese dico 10 – 0 – 0.
117 – 2 – 14.
A me Julio Cesare Bacchino per l’off.io de scrivan de ratione in ditta R.ia fabrica duc.ti setti cor.
(f. 325r)
per mia provisione del presente mese dico 7 – 0 – 0.
Al Mag.co Giorgio Hurtado pagator alla despesa de ditta R.ia fabrica duc.ti sei cor. per sua provisione del presente mese dico 6 – 0 – 0.
A Geronimo del Valle monitionero et soprastante in ditta R.ia fabrica duc.ti dui tari dui et gr. deci correnti per sua provisione del presente mese dico 2 – 2 – 10.
A Lorenzo de Saravia scrivano sopra ditta R.ia fabrica per tener li cunti appartati per il Mag.co S.or Comissario duc.ti tre cor. per sua provisione del presente mese dico 3 – 0 – 0.
18 – 2 – 10.
48 – 4 – 10.
117 – 0 – 5.
184 – 2 – 5.
(f. 328r)
Adi p.o de Junio VIII Ind.e 1550 per tutto l’ultimo del medesimo mese.
A Nardo Piacente de Lipari per salme vintitre e meza de calce potata da Patti et venduta a questa R.ia fabrica a ragione de tari quattro la salma dela moneta de Sicilia quali redutti a moneta de Regno son duc.ti otto tari dui et gr. quindici cor. dico 8 – 2 – 15.
A fran.co malvito de Lipari per salme cinquanta due de calce venduta per questa R.ia fabrica alla ragione sopra ditta quali redutti a moneta de Regno son duc.ti deciotto tari quattro et gr. undeci cor. 18 – 4 – 11.
A fran.co de bastiano als gambagrossa de Lipari per salme sessanta quattro de calce venduta per questa R.ia fabrica ala ragione sopra ditta, quali redutti a moneta de regno son duc.ti ventitre tari uno et gr. setti e mezo dico 23 – 1 – 7 ½.
A m.ro Angelo Bene Incasa dela cava Capo mastro de questa R.ia fabrica duc.ti quattro cor. li quali per lui si pagano a m.ro Jo: battista tagliapetra et vanno a suo bon cunto dico 4 – 0 – 0.
53 – 3 – 13 ½.
(f. 328v)
A fran.co de bastiano als gambagrossa de Lipari per salme sessanta otto e meza de calce portata da patti et venduta per questa R.ia fabrica ala ragione preditta quali redutti a moneta de Regno son duc.ti vintiquattro tari quattro et gr. deci et mezo cor. dico 24 – 4 – 10 ½.
A fran.co Malvito de Lipari per salme trenta due de calce venduta per questa R.ia fabrica ala ragione sopra ditta, quali son de moneta cor. duc.ti undici tari tre et gr. quattro dico 11 – 3 – 4.
A me Julio Cesar Bacchino per l’off.io de scrivan de ratione di questa R.ia fabrica duc.ti setti cor. per mia provisione del presente mese dico 7 – 0 – 0.
Al Mag.co Giorgio Hurtado pagator alla despesa de questa R.ia fabrica duc. sei cor. per sua provisione del presente mese dico 6 – 0 – 0.
A Geronimo del Valle monitionero et soprastante in ditta R.ia fabrica duc.ti dui tari dui et gr. deci correnti per sua provisione del presente mese dico 2 – 2 – 10.
A Lorenzo de Saravia scrivano sopra ditta R.ia fabrica per tener li cunti appartati per il Mag.co S.or Comissario duc.ti uno tari tre et gr. setti e mezo, quali son in parte dela sua provisione de la presente mesata, et lo restante a suo complimento de duc.tre non se li è pagato à causa che dele due millia duc.ti dela presente annata non c ‘è più denari et similmente si resta à pagare la presente mesata allo Architettore per la causa preditta dico 1 – 3 – 7 ½.
53 – 3 – 12.
54 – 3 – 13 ½.
108 – 2 – 5 ½.
Note
[i] ASV, Reg. Lat. 1785, ff. 232-233.
[ii] “Lipare, la quale città sempre si mostrò fedele a i Re di Napoli da quali per ricompensa ottenne grandissimi privileggi di franchezze, ultimamente del mese di Luglio del 1544 fu distrutta col ferro, e col fuoco da Ariadeno Barbarossa Capitano dell’armata del Turco, ma fu in un subito rifatta da Carlo V”. Mazzella S., Descrizione del Regno di Napoli, Cappelli 1601, p. 153.
[iii] Il “Relevio delo Ill.o S.r q.o donno Ant.o de Aragonia Duca de Montealto” del 1544” documenta le perdite subite dal feudatario l’anno precedente. Nel “Quinterno”delle entrate fatto da Guglielmo de Alimeno e consegnato il 27 aprile 1544 al mag.co Alfonsio Riccho di Napeli si legge: “Le intrate de rigio sono vendute a bast.no pizzim.ti duc.ti duicento trenta cinq. q.li sono la baglia la decima del pisa et lo scannagio de d.ta cita, lo anno passato sene hebe solam.te duc.ti quaranta cinq. per la destruccion de ditta cita. ASN. R.C.S. Relevi, b. 348, f.83.
[iv] Mafrici M., Squillace e il suo castello nel sistema difensivo calabrese, Barbaro Ed., 1980, p. 92.
[v] Il 23 ottobre 1555 il luogotenente di Vicerè Bernardino de Mendoza inviava alla Regia Camera un inserto contenente il privilegio concesso all’università di Reggio dal re Filippo (II), datato “aliamptone Regni Angliae 24 julii 1555”. Il re prendeva atto del privilegio a suo tempo concesso dal precedente regnante e rinnovava all’università di Reggio per altri dieci anni l’esenzione dalle funzioni fiscali e da qualsiasi altra contribuzione ordinaria e straordinaria di qualsiasi genere e per qualsiasi causa, a partire dal giorno della scadenza della esenzione ventennale. ASN, Tesorieri e Percettori Vol. 4087 (ex 485) an. 1564/ 1565, f. 43.
[vi] ASN, Dip. Som. 197, ff. 194 – 287.
[vii] “…. l’anni passati à tempo si principiò la fabrica del castello novo in la marina della città de Reggio il fiume che sboccava in quel loco acciò non impedisse ne quastasse d.a fab.a fu divertitoli et dato l’altro corso et il loco per dove caminava restò vacuo et da d.o tempo in qua è stato occupato dall’infr.tti part.ri d’essa città …”. ASN, Tesorieri e percettori di Calabria Ultra, Vol. 558/4162, ff. 89, 191 sgg.
[viii] Nel 1553 Giacomo Malerba interveniva direttamente ridefinendo il bastione Don Pedro di Crotone. Infatti un corriere veniva inviato a Napoli al Sig. Don Loysio de Toledo per portar ad sua Signoria il designo novo ha fatto Jacomo Malerba de lo sponton de la Capperina”. F. Strazzullo, Architetti e ingegneri napoletani dal ‘500 al ‘700, Benincasa 1960, pp. 217 – 218.
[ix] ASN, Dip. Som. 197, ff. 288 – 329.
The post La costruzione delle fortificazioni della città di Lipari (settembre 1549 – giugno 1550) e del castello “novo” di Reggio appeared first on Archivio Storico Crotone.
Belvedere Spinello e Santa Maria della Scala
Dall’ordine della “Militiae Templi” a quello Gerosolimitano, la chiesa di San Giovanni di Santa Severina (sec. XII-XIV)

Santa Severina (KR), chiesa di San Giovanni Battista.
Dopo la loro affermazione in Terra santa durante le Crociate, gli ordini cavallereschi formatisi a seguito di questo movimento, oltre ad assumere la difesa dei luoghi sacri della Cristianità, ebbero il compito di presidiare i principali luoghi sensibili del regno. Essi furono quindi addetti al controllo ed alla gestione delle principali strade, dei passi e dei porti, ed a loro furono affidati i castelli che munivano questi luoghi strategici di transito.

Il Santo Sepolcro di Gerusalemme (foto da www.brundarte.it).

Pianta del Santo Sepolcro di Gerusalemme (foto da www.brundarte.it).
Ospitalieri e Templari
In ragione della sua particolare importanza nella rete delle comunicazioni “ultra mare”, legata ai suoi antichi scali portuali, posti sui favorevoli promontori che caratterizzavano la sua costa, il Crotonese fu interessato precocemente, da una diffusa presenza degli ordini cavallereschi formatisi in Terra santa dopo la prima crociata (1099), come testimoniano alcuni atti dei primi anni del sec. XII.[i]
In questo quadro, il controllo dei luoghi principali di attraversamento del territorio di Santa Severina, dove convergevano le più importanti vie d’accesso ai passi sui fiumi Tacina e Neto, nell’area in cui queste incrociavano quelle che risalivano verso l’altipiano della Sila, fu affidato agli Ospitalieri ed ai Templari, la cui presenza è documentata in questo contesto, nel periodo 1228-1229, quando troviamo i “magistri et provisores inperialium castrorum”, “frater Burrellus tenplarius” e “frater Rogerius hospitalarius”, impegnati a condurre un’inchiesta presso gli abitanti di alcune terre appartenenti alla diocesi di Santa Severina, con lo scopo di accertare se l’abbazia cistercense di Sant’Angelo de Frigillo, fosse tenuta a concorrere al riparo e al servizio dell’“inperialis castri Sancte Severine”.[ii]
Risalgono a questo periodo del dominio svevo, anche le prime notizie riguardanti la locale chiesa di San Giovanni, che fu realizzata secondo la “forma” del Santo Sepolcro di Gerusalemme, presso cui era stato fondato l’ordine degli Ospitalieri dopo la prima crociata, riproducendo un modello che troverà ampia diffusione in diversi luoghi europei.

La “forma” del Santo Sepolcro come risulta descritta in una miniatura medievale: “hec est forma eccl(es)ie n(ost)re ier(oso)limitane sacratissimi sepulcri hedificata a beata elhena fundatrice p(ri)ma”. “ista est forma sacri sepulcri d(omi)ni n(ost)ri ih(es)u xpi” (foto Wikipedia).

Santa Severina (KR), interno della chiesa di San Giovanni Battista (foto P. Barone).
Queste notizie sono contenute in un atto del gennaio 1223 scritto in greco, attraverso cui il presbitero Andrea Scaldieri ed il figlio Nicolao, donarono al santo monastero del Teologo ed Evangelista Giovanni detto di Fiore (ἀγίαν μoνὶν τoυ ϑεoλόγoυ ϰαὶ ευαγγελιστoυ ιωάννoυ τὴς λεγoμένης χειoυρε), una casa ricevuta in dono da domina Constantia Caninea, posta in Santa Severina, entro i confini di San Giovanni Evangelista (ἐνορίαν ϑεoλoγoυ), limitante con l’abitazione del presbitero Ioseph Cubiculario e con l’abitazione di Gaudioso e del presbitero Nicolao de Phiso.[iii]
Anche se non possediamo notizie esplicite a riguardo, dobbiamo ritenere che, in origine, questa chiesa appartenne ai Templari, come lasciano intendere alcuni documenti risalenti agli inizi del secolo successivo, quando l’ordine fu inquisito con l’accusa di eresia da parte del re di Francia Filippo il Bello. Accuse che determineranno papa Clemente V a sopprimerlo ed a confiscarne i beni, passati poi a quello Gerosolimitano. A questo punto, gli appetiti sollevati attorno ai beni dell’ordine soppresso, determinarono alcuni interventi da parte del papa. Interventi che sottolinenano la loro particolare consistenza in territorio di Santa Severina.
L’11 agosto 1308 Clemente V, comunicando la soppressione dell’“Ordinem Militiae Templi”, scriveva all’arcivescovo di Cosenza, all’arcivescovo di Rossano ed a quello di Reggio, nonché ai loro suffraganei, dando mandato “ut omnia eiusdem Ordinis bona in custodiam recipiant”[iv] mentre, il giorno successivo, ordinava agli arcivescovi di Napoli e di Brindisi, al vescovo di Avellino e ad altri ecclesiastici, di condurre un’inchiesta circa “de Fratribus Ordinis Militiae Templi”. Questo secondo documento, oltre ad essere indirizzato agli arcivescovi di Cosenza e di Reggio, fu inviato anche all’arcivescovo di Santa Severina.[v]

Santa Severina, Museo Diocesano. Plastico di una sezione della chiesa di San Giovanni Battista.
Quasi due anni dopo, il 4 aprile 1310, il papa scriveva agli arcivescovi di Cosenza e di Reggio ed ai loro suffraganei, nonchè all’“archiepiscopo S. Severinae et suffraganeis eius”, comunicando di aver prorogato la convocazione del Concilio di Vienna perché il processo “contra Ordinem Militiae Templi” non era stato ancora completato.[vi] A compimento di ciò, il 2 maggio dell’anno dopo, il papa poteva finalmente comunicare ad alcuni presuli calabresi “quod bona Ordinis Militiae Templi, approbante generali concilio Viennensi, Hospitali S. Iohannis Ierosolymitani assignantur”.[vii]
A testimonianza di questo passaggio, in occasione della reintegrazione della decima dovuta alla Santa Sede per l’anno 1310, “In provincia S. Severine et eiusdem Diocesis”, risulta il pagamento effettuato dal presbitero Petro Senatura (“Presbiter Petrus Senatura eo iure tar. II, gr. II”) che, relativamente alle decime dello stesso anno, pagò anche “In episcopatu Gennicastrensi eiusdem Provincie”, essendo cappellano della “ecclesie S. Iohannis Ierosolimitani” di Genicocastro (Belcastro).[viii]

Un riferimento a San Giovanni Evangelista si evidenzia sopra la porta laterale della chiesa di San Giovanni Gerosolimitano di Cosenza, dove Cristo con le sembianze dell’agnello, è raffigurato sopra il libro dell’Apocalisse da cui pendono i sette sigilli (foto da francescacanino.blogspot.com), come troviamo anche in una rappresentazione moderna realizzata sul pavimento della cattedrale di Santa Severina.

Santa Severina (KR), Agnello mistico raffigurato sul pavimento della cattedrale.
L’inchiesta pontificia
Il passaggio dei beni dall’ordine Templare a quello Gerosolimitano non fu certamente né subitaneo né esente da frodi, considerato che, ancora nella seconda metà del secolo, nell’ambito di una vasta inchiesta condotta in tutto il Mezzogiorno, il papa doveva intervenire anche nei confronti dell’arcivescovo di Santa Severina, per cercare di far luce circa la reale consistenza dei beni posseduti dai Gerosolimitani nella sua diocesi ed in quelle dei suoi suffraganei.[ix]
In merito a tale inchiesta, gli inventari cinquecenteschi superstiti delle scritture esistenti presso l’Archivio Arcivescovile di Santa Severina, conservano memoria di una “L(icte)rae Gregorii Papae Undecimi super redditibus religionis S. Joannis Hierosolimitani”, come segnala l’inventario delle “scritture appartenenti alla Chiesa, e Mensa Arciv.le di S. Sev.na che stanno in Archivio separati da l’altre sotto chiave segnata con questi segni R. R. fatto da me D. Gasparo Caivani Archid.o all’ultimo di settembre 1594”.[x] Tale documento però, non si ritrova più tra quelli conservati in questo archivio, ma è stato possibile rintracciarlo ancora presso l’Archivio Segreto Vaticano.
Da questa fonte apprendiamo che il 16 luglio 1373, in Santa Severina, alla presenza di Roberto Guarano “analis (sic) judex”, del presbitero Lucha Bruno e dell’arcidiacono Rogerio, tutti della città di Santa Severina, il regio pubblico notaro Nicolao Bruno anch’egli di Santa Severina, scrisse un “p(u)p(li)cum istr(ument)um” mediante il quale “Guill(elm)us dei et ap(osto)licae sedis gr(ati)a sante sev(er)ine Archiep(iscop)us”, rispose in merito alle disposizioni ricevute dal papa Gregorio XI, attraverso la lettera data in Avignone l’11 febbraio 1373 e riportata integralmente nell’atto.
Attraverso questa lettera, il papa, impegnato nella “reformationem status totius religionis hospitalis santi Ioh(anni)s Ierosol(im)itani”, ordinava all’arcivescovo di Santa Severina ed ai suoi “fr(atr)es suffraganei seu v(est)ris vicariis sive officialibus earum”, d’indagare e di relazionare entro il termine di un mese, circa “de n(omin)ibus preceptoriarum seu domorum prefati hospitalis” esistenti nelle loro città e nelle loro diocesi, di riferire i nomi, cognomi ed età dei “preceptorum seu rectorum”, dei “sacerdotum et aliorum constitutorum in sacris ordinibus” e dei “militum fratrum ip(s)ius hospitalis”. Il pontefice, inoltre, chiedeva di conoscere anche ogni singola situazione, circa “de fructibus redditibus et proventibus annuis ip(s)arum preceptoriarum seu domorum” ed i relativi oneri, disponendo che fosse anche fornita una stima del denaro che si sarebbe potuto ricavare annualmente, da un ipotetico affitto dei beni.
Volendo ottemperare diligentemente alla richiesta papale, l’arcivescovo fece citare numerosi testi che furono esaminati, chiedendo loro se “in Civitate sante sev(er)ine vel eius tenim.to”, esistessero “bonis hospitalis santi Ioh(ann)is Ierosolimitani”, ma questi deposero tutti, concordemente, che “nihil esse de bonis predicti in predicta Civitate et eius tenim.to”. Similmente, “per manus vicarii sui”, l’arcivescovo fece indagare circa l’esistenza dei detti beni in tutta la sua diocesi, ma niente fu trovato.[xi]
In potere dell’arcivescovo
Non conosciamo ulteriori sviluppi ufficiali della vicenda, ma è documentato che il papa continuò a mantenere sulla chiesa di San Giovanni l’antico patronato, anche dopo che questa era divenuta una delle parrocchiali della città. Il papa esercitava tale diritto che gli consentiva di nominare il parroco, ancora alla metà del Cinquecento anche se, in questo frangente, la chiesa passò ad appartenere all’arcivescovo, che riuscì così ad ottenerne infine il pieno controllo.
In questa direzione leggiamo già l’intervento dell’arcivescovo Alessandro de Marra che, il 24 luglio 1489, VII indizione, essendo vacanti la chiesa curata di “s(an)ti joh(ann)is bactiste” e quella rurale di “s(an)ti opi”, per la morte del “quondam dopni duranti novellisi olim rectoris sup.a dictarum ecc.arum”, unì le due chiese donandole al Capitolo, ossia all’arcidiacono “dopnum Venturam”, fatti salvi tutti i diritti arcivescovili.[xii]
Agli inizi del Cinquecento, la nomina del parroco della chiesa di San Giovanni Battista, posta vicino la casa di Giovanni e Francesco Iaquinta e quella di Giovanni Millesimo,[xiii] situata e fondata “in ecclesia seu iuxta ecclesiam metropolitanam S. Severinae”, era ancora di pertinenza del papa, come riferiscono i documenti vaticani.[xiv] Ciò risulta da questa fonte ancora verso la fine del 1557 quando, vacante per remissione di Salvatore Fracsio, il 27 marzo 1557 la chiesa fu concessa da papa Paolo IV al clerico riminese Hectore Brancati[xv] con il titolo di rettore “seu perpetuus capellanus”, come risulta nell’atto di convalida di questo passaggio del 5 ottobre seguente.[xvi]
I documenti locali evidenziano, invece, che già in questa fase, la chiesa era divenuta “mensalis”, ossia appartenente alla Mensa arcivescovile, così la nomina del parroco spettava ora all’arcivescovo che vi esercitava il diritto di visita.
Lo testimoniano gli atti della visita ai luoghi pii della città, compiuta dal vicario arcivescovile Giovanni Tommaso Cerasia nel maggio 1559, quando la chiesa parrocchiale di “s(anc)ti jo: bact.ae quae est prope et Conjunctim cum met.opolitana ecc.a”, era servita dall’arciprete della cattedrale D. Petro Gallo e ne era rettore l’Ill.mo e R.mo D. Nicolao Carrafa che era anche cappellano della cappella di Santo Andrea in cattedrale, di jus patronato dei conti di Santa Severina.
Ancora a quel tempo, la parrocchiale possedeva una rendita consistente derivante dal possesso di beni e diritti: “unam gabellam positam a Corazo”, un’altra “in loco dicto lo piro Citrino” assieme a molte altre terre, una casa nella città posta nella stessa parrocchia, due vigne nella valle detta “la valle delo giar.o”, annui ducati 4 derivanti da censi, e le decime dei suoi parrocchiani.[xvii]

La viabilità che converge su uno dei principali ed antichi attraversamenti del fiume Neto in località Corazzo (in evidenza). Particolare della Sez-12-Col-IX della carta delle provincie continentali dell’ex Regno di Napoli, realizzata nel periodo tra gli anni 1821-1824.
Il suo edificio era “ad lamiam Cum nonnullis Colunnis marmoreis” e vi era un fonte battesimale “de fabrica diversis lapidibus” ben chiuso e ben conservato, nel quale si trovava “mag.a quantitas aquae ut sac.i Canones”, ma il vicario ordinò lo stesso che, entro il termine di sei mesi, se ne facesse un altro di pietra in unico blocco (“sasseum”). In questa circostanza si faceva osservare come “sempre ab immemorabili tempo si è osservato, e di presente si osserva”, solo la cattedrale era “Chiesa Battesimale”, conservandosi in essa solamente il fonte battesimale, nel quale si ministra il Sacramento del Battesimo”.[xviii]

Santa Severina (KR), chiesa di San Giovanni Battista. Affresco raffigurante San Giovanni Battista inginocchiato in un paesaggio naturale con lo sguardo rivolto al cielo, mentre tiene nella sua mano destra l’acqua per battezzare Gesù Cristo
Oltre all’altare maggiore, sopra il quale si trovava una “Cona decente” con l’immagine della Vergine Maria e dei Santi Giovanni Battista e Giovanni Evangelista, nella chiesa vi erano l’altare della “S.ta Cruce”, iuspatronato della famiglia Protopapa, di cui era rettore il R.do D. Nicola Carrafa, l’altare di “s.ta m.e de Conceptioni”, di cui era rettore sempre il detto Carrafa e che serviva l’arciprete D. Petro Gallo, e l’altare dedicato a “S.te marie de nive” di cui era rettore Jo: Antonio Tilesi. Nel “Campanile” si trovavano due “Campane”.[xix]

Santa Severina (KR), chiesa di San Giovanni Battista.
Un edificio antico
Classificato tra le “costruzioni a cupola centrale”,[xx] nella quale furono riutilizzati materiali di spoglio provenienti da edifici dell’età classica, come le sue colonne “di granito”,[xxi] l’edificio della chiesa di San Giovanni Battista di Santa Severina dimostra ancora oggi una evidente antichità delle sue strutture, che sembrano comunque adeguarsi a quelle della cattedrale,[xxii] trovando numerosi esempi simili in varie parti del nostro Paese e d’Europa, come ad esempio, quello della chiesa di Sant’Angelo a Perugia, già evidenziato dal Loiacono,[xxiii] e quello di San Giovanni al Sepolcro a Brindisi.

La chiesa di Sant’Angelo sul colle di Monteripido a Perugia (foto da www.umbrialibera.it).

Brindisi. Chiesa di San Giovanni al Sepolcro (foto da www.brundarte.it).

Brindisi. Interno della chiesa di San Giovanni al Sepolcro (foto da www.brundarte.it).
Tale antichità è evidenziata anche dai documenti seicenteschi, come riferisce l’apprezzo della città del 1687 che la definisce “antichissima”[xxiv] mentre, nell’apprezzo cittadino del 1653, si menziona l’esistenza di una iscrizione (di cui è conservata una “una copia del sec. XVI” all’Archivio Segreto Vaticano),[xxv] posta sopra una delle colonne di questa chiesa “anticha”, dove ricorreva il suo anno di costruzione.[xxvi]
In questo periodo, l’esistenza di una “memoria” dell’arcivescovo Giovanni di Santa Severina, scritta “a caratteri greci” nel “Battisterio, senza sapersi altro del tempo” è testimoniata dal Fiore,[xxvii] mentre l’Ughelli, sulla base di quanto gli fu riferito dalle sue fonti locali, ne riportò il testo nella sua “Italia Sacra”, opera pubblicata per la prima volta alla metà del Seicento:
IΩAN. BAΠT. ΔAPXHETTHCKIT. KATEKEBA. ΔIK. IΓ.[xxviii]
Rispetto a questa prima edizione “da cui non se ne può cavare senso alcuno”, il conte Vito Capialbi di Monteleone, agli inizi dell’Ottocento, sulla base del testo che gli fece pervenire monsignor Deodato Ganini, arcidiacono e vicario generale di Santa Severina, fornì questa interpretazione:
“ιωανη o αγιoτατoς αϱxηεπησxoπoς ϰατεστευατε ιηω, ινδιτ. IΓ – Ioannes Sanctissimus Archiepiscopus construxit templum (supple hoc) indictione XIII.”
La sua lettura, però, non riuscì a sciogliere il nodo principale contenuto in questo antico testo: ovvero la data di costruzione dell’edificio. A riguardo egli riteneva che le “tre cifre che vi sono innanzi alle lettere INΔIK potrebbero dinotare l’anno della edificazione del tempio”, ma non riusciva, comunque, a comprenderne il significato, perciò era propenso a riconoscervi la parola “Nηως doricamente per Nαõς templum.”[xxix]

Santa Severina (KR), chiesa di San Giovanni Battista. Particolare della iscrizione che menziona l’arcivescovo Giovanni (foto P. Barone).
Relativamente a tale fondamentale questione, in una lettera del 27 dicembre 1829 scritta in Monteleone a monsignor Ganini, il “dotto Storico”, pur dovendo confessare di non essere riuscito a svelare la data di costruzione dell’edificio, lo consigliava di “fare osservare bene le tre sigle, che sono avanti alle altre INΔIK”, e che seguivano “le lettere Kατεσευασε”, nelle quali aveva ragione di credere si celasse o esprimesse “la voce Nηως”, oppure “l’anno della costruzione”. Quest’ultimo, stando a “come voi la delineaste”, era il 582 che però, risultava incompatibile con la storia della città che, a quella epoca, “non aveva pastore.” C’era poi da considerare, secondo il Capialbi che, “a quell’epoca”, i “greci” numeravano gli anni dalla creazione del mondo, fissata il primo settembre del 5509 a C., e ciò non si accordava con le tre lettere di cui sopra che, in questo caso, invece, sarebbero dovute essere quattro.[xxx]

Santa Severina (KR), chiesa di San Giovanni Battista. Particolare della iscrizione che menziona l’arcivescovo Giovanni (foto P. Barone).
Questi risultati e queste considerazioni dell’autore sono espresse anche più tardi nel suo volume Opuscoli Varii: “In Santa Severina. Le colonne che sostengono il battistero della Cattedrale, già chiesetta di San Giambattista, serbano la memoria di un Arcivescovo Giovanni nella seguente iscrizione posta nel giro di uno de’ capitelli: IωANHC O AΓIOTATOC APXHEΠHCK.Π KATECKEUACE NHCINΔIKIΓ Joannes Sanctissimus Archiepiscopus construxit …. indictione XIII. Nel sito avanti l’indizione vi sono tre lettere delle quali non arrivo a capirne il significato. Dovrebbero indicare o l’oggetto costruito, o l’anno della costruzione.”[xxxi]

Santa Severina (KR), chiesa di San Giovanni Battista. Particolare della iscrizione che menziona l’arcivescovo Giovanni (foto P. Barone).
Risultati e considerazioni che non furono comunque accolte a Santa Severina, come dimostra una tarda “GNOSEΩGRAFIA” manoscritta conservata nel locale Archivio Arcivescovile,[xxxii] che riporta questa iscrizione con un testo che non menziona l’anno di costruzione, accompagnato da una traduzione latina che lascia ampi dubbi.
IΩANNHΣ AΓIΩTATOΣ APXIEΠIΣKOΠOΣ
KATEΣKEϒAΣE NHΣIN ΔῙK ῙΓ
“yoannes Sanctissimus Archiepiscopus Superstruxit parvum Templum Duplica XIII”.[xxxiii]

Santa Severina (KR), chiesa di San Giovanni Battista. Particolare della iscrizione che menziona l’arcivescovo Giovanni (foto P. Barone).
Dopo la pubblicazione da parte di Vito Capialbi, l’iscrizione esistente nel “baptistère” di Santa Severina, il cui stile “atteste son origine byzantine”, fu pubblicata da Edouard Jordan, al termine del suo viaggio fatto in Calabria al principio del 1889 in compagnia di Pierre Batiffol.[xxxiv]
Questi, dopo aver riportato la trascrizione dell’Ughelli,[xxxv] e quella più recente dello Schultz (1860),[xxxvi] pubblicò, per la prima volta, un suo facsimile (accompagnato da una pianta e da una sezione dell’edificio), che trascriveva così:
Ἰωάννῆς ὁ ὰρ[χιεπίσϰoπoς] Ἰωάννῆς ὰρχ[ιεπ]ίσϰoπoς ϰατεσϰεαύσσεν ης (pour ὲἰς) ἰνδιϰ ίγ.

Il facsimile della iscrizione pubblicato da Eduard Jordan (1889).
A riguardo dell’epoca di costruzione, egli pensava che, presumibilmente, questa dovesse coincidere con il periodo compreso, tra quello in cui era documentata l’esistenza della metropolia e l’arrivo dei Normanni, anche se, malauguratamente, la “simple mention” dell’indizione, non consentiva di stabilire con precisione l’anno di costruzione.[xxxvii]

La sezione del Battistero di Santa Severina pubblicata da Eduard Jordan (1889), accompagnata dalla trascrizione dello Schultz (1860).
Archeologi al lavoro
Agli inizi del Novecento, al dilettantismo degli ecclesiastici locali e dei viaggiatori stranieri alla ricerca di antichità, andò progressivamente sostituendosi il professionismo degli archeologi di mestiere che, comunque, pur basandosi su metodi d’indagine più oggettivi, non riuscirono lo stesso a stabilire con certezza l’anno di costruzione dell’edificio. Continuò, invece, a radicarsi la teoria priva di riscontri, secondo cui l’edificio in questione doveva rappresentare un “Battistero” risalente al periodo Bizantino, fase in cui, sempre secondo coloro che condivisero questa teoria, la cattedrale si trovava invece in un altro luogo della città.
La voce più autorevole di questo periodo a sostegno di questa tesi, fu certamente quella dell’archeologo Paolo Orsi (Rovereto, 1859-1935) che, al tempo, dirigeva “l’appena costituita Regia Soprintendenza agli scavi e musei di Reggio Calabria”,[xxxviii] ed era impegnato ad effettuare scoperte archeologiche in tanti luoghi della Calabria. L’Orsi, assieme ai suoi collaboratori, soggiornò “alcuni giorni” a Santa Severina “in due riprese”, nei mesi di maggio e giugno del 1911, mentre il suo collaboratore Rosario Carta ritornò a Santa Severina nel novembre di quell’anno, per completare i suoi disegni ed effettuare dei sondaggi.[xxxix] I risultati ottenuti dalle indagini condotte, furono pubblicati una prima volta nel 1912, sul Bollettino d’arte del Ministero della P. I.[xl] e successivamente, nel volume Le Chiese Basiliane della Calabria (1929) che, a differenza di qualche precedente incerto, costituivano il primo tentativo condotto da un archeologo, di appurare la realtà esistente direttamente sul campo.[xli]
Questo primo studio del “monumento” che, al tempo, era da considerarsi praticamente inedito,[xlii] risultava corredato anche da una pianta e una sezione dell’edificio più rispondenti alla realtà, rispetto alla pianta “del tutto inesatta” realizzata precedentemente dal Jordan nel 1889 che era l’unica esistente.[xliii]
Risale al lavoro dell’Orsi anche un disegno dell’iscrizione esistente sul “pulvino SO” che, dopo l’edizione dell’Ughelli, era stata pubblicata “più correttamente” ma con errori paleografici, dallo Schultz e dal Jordan, e di cui si dava, finalmente, “il facsimile col testo preciso e definitivo”:
+ Ἰωάννῆς ὁ ἁγιώ(τατoς) ἀϱχηεπήσϰ(o)π(oς)
ϰατεσϰεύασεν ης (=ɜἰς), ἰνδιϰ(τιῶνα) ίγ.[xliv]
Riguardo all’epoca di costruzione dell’edificio, l’Orsi giudicava “il Battistero opera senza dubbio prenormanna”, mentre, a riguardo del suo anno di costruzione, affermava discutibilmente, che tale “data sta nascosta nell’indizione XIII, dalla quale però non è possibile ricavare l’anno esatto.”[xlv]

Il “facsimile” della “Epigrafe del Battistero” di Santa Severina pubblicato dall’Orsi (1929)
Il monumento
Dopo l’intervento dell’Orsi, essendo stato ormai riconosciuto con il valore di “monumento” storico, considerato “caposaldo dell’arte bizantina italiana”, il “Battistero” di Santa Severina fu interessato da importanti lavori di restauro, disposti dal Soprintendente alle Antichità Bruzio-Lucane comm. E. Galli, “allo scopo di mettere in luce quanto il monumento celava di originario, e di togliere le sovrapposizioni arbitrarie.”[xlvi]
Durante questi lavori che iniziarono nel 1927, durante i quali fu spostato l’ingresso della chiesa nel luogo attuale, ritenuto originario, mentre una delle colonne esistenti, essendo di fabbrica, fu sostituita con “due frammenti di colonne granitiche trovati come para carri davanti alla facciata della Cattedrale”,[xlvii] furono anche realizzati alcuni disegni “pazientemente delineati sul posto, in cima ad una scala, in condizioni di luce quanto mai difficili”, tra cui quello del “capitello n. 1 sul quale è inscritta la dedica dell’Arcivescovo Giovanni.”[xlviii]

Il “CAPITELLO N° 1” con la sua iscrizione secondo il rilievo pubblicato dal Loiacono nel 1934.
Più recentemente, l’iscrizione esistente sull’unico “capitello di marmo della chiesa”, è stata pubblicata dal Guillou (1999), che ci fornisce una interpretazione analoga a quella dell’Orsi:
+ Ἰωάννῆς ὁ ἁγι-
ώ(τατoς) ἀϱχηεπ-
ήσκ(o)π(oς) κατεσϰεύα-
σεν ἠς (leg. ἐἰς), ἰνδικ(τιῶνα) ίγ.
“L’ha costruita Giovanni, santissimo arcivescovo, durante la tredicesima indizione”.
In relazione alla individuazione dell’anno di costruzione, confrontando la “scrittura” di questa epigrafe con altre simili, l’autore propone “probabilmente” il IX secolo, fissando questa data al periodo 1 settembre 894 – 31 agosto 895, in cui ricorre la XIII indizione.[xlix]
Nel segno di una croce
Accanto a questa iscrizione un po’ enigmatica che c’informa circa il costruttore della chiesa, ma appare incomprensibilmente priva dell’anno di costruzione, pur menzionando la relativa indizione, una seconda iscrizione esistente nella stessa chiesa, ci fornisce qualche altro elemento che ci aiuta a fare maggiore chiarezza, nel tentativo di stabilire quando fu costruita.
Il testo greco di quest’ultima, infatti, che fa menzione di Teodoro in qualità di arcivescovo, secondo alcuni, di “ex-eparca”, secondo altri, le cui lettere sembrano sparse disordinatamente “un po’ ovunque”, accompagnano una “croce di Malta” posta tra “due colombe”,[l] che possiamo ricondurre solo alla presenza dell’ordine Gerosolimitano.
L’Orsi, la cui “attenzione” su questo particolare della chiesa, fu richiamata dal “vicario Mons. Puija”, “avendovi scorto lettere e simboli”, la ricostruì così nel 1911:
+ Θ[εoϑῶϰ]ε βoήϑη Θε[o]δώϱoυ ἀϱχ[ιε]πε[σϰόπ]o[υ][li]
Questa iscrizione, risultava invece ormai “illeggibile” al Guillou che, per la propria edizione (1999), utilizzò “un disegno di Paolo Orsi che la riproduce.”[lii] L’autore, che la descrive come un testo che si sviluppa ai lati e all’interno di un cerchio, in cui è inscritta “una croce di Malta” tra due colombe, lo fissa così accogliendo la proposta di V. Laurent:
+ Θ[εoϑόκ]ε βoήθη [τῷ δoύλῳ σ](oυ) θε(o)δώρ(oυ) ἀπὸ ἐ(πάρχων)
“Vergine, aiuta (il tuo servo) Teodoro, ex-eparca.”[liii]

Santa Severina (KR), chiesa di San Giovanni Battista. La “croce di Malta” e l’iscrizione posta sul capitello “Sud” che menziona Teodoro.

Il “Pulvino scritto del Battistero” pubblicato da Paolo Orsi (1929).
Accanto a questo simbolo, su altri due capitelli della chiesa compaiono altrettante croci patenti riferibili alla presenza dei Templari.


Santa Severina (KR). Croci patenti esistenti sui due diversi capitelli della chiesa di San Giovanni Battista.
A questo punto, sulla base delle testimonianze raccolte: documenti, iscrizioni e simboli, possiamo stabilire alcuni punti fermi circa l’epoca di costruzione della chiesa, che, pur non consentendoci di pervenire a fissare l’anno di costruzione, ci permettono comunque sicuramente di riferirla al tempo in cui fiorirono gli ordini cavallereschi formatisi in Terra santa, escludendo che essa possa essere pertinente all’epoca altomedievale.
Nelle due iscrizioni osservate, infatti, Giovanni (sicuramente) e Teodoro (forse), ricorrono in qualità di arcivescovi, circostanza che risulta in contrasto con quanto noi conosciamo circa l’apparire di questo titolo, il cui uso non è documentato durante il periodo altomedievale, quando la chiesa di Santa Severina era soggetta al patriarca di Costantinopoli.[liv] Risulta poi in contrasto con l’esistenza di un arcivescovo (ma anche di un metropolita), in qualità di costruttore/fondatore di questa chiesa, la sua documentata appartenenza ad ordini immediatamente soggetti al papa ed esenti dalla giurisdizione vescovile durante il Medioevo.
Possiamo quindi considerare estranea a questa chiesa, l’iscrizione che ricorda l’opera dell’arcivescovo Giovanni che, alla luce delle vicende messe in evidenza, deve poter provenire da qualche altra chiesa della città, probabilmente dalla vicina cattedrale dove, ancora nell’Ottocento, esistevano ben altre due testimonianze epigrafiche greche che menzionavano un arcivescovo Giovanni,[lv] successivamente disperse ed andate perdute.

Il nuovo ingresso del “Battistero” realizzato a seguito dei lavori iniziati nel 1927 (Loiacono P., 1934).

La “Pianta del Battistero com’era prima dei restauri” (Loiacono P., 1934).

La “Pianta del Battistero come doveva essere in origine, e com’era ora dopo i restauri” (Loiacono P., 1934).
Per chi suona la campana
Un’ultima testimonianza riconducibile alle vicende medievali della chiesa di San Giovanni Battista di Santa Severina, ci provengono da una campana oggi esposta nel locale Museo Diocesano, sulla quale esiste una iscrizione che, nel tempo, è stata oggetto di interpretazioni molto differenti.
Ritenuta greca in un primo momento, tale iscrizione fu sottoposta al conte Vito Capialbi in qualità di esperto. Da una lettera di quest’ultimo scritta in Monteleone il 15 febbraio 1829, “quando ancora non s’erano bene interpretate le iscrizioni greche e latine di Santaseverina”, ossia prima della venuta di Paolo Orsi, apprendiamo quanto il conte ebbe a dire al proposito in questa occasione.
Fu così che, rispondendo a monsignor Deodato Ganini, che gli aveva chiesto “un parere sui caratteri greci scolpiti nella campana di codesta chiesa di S. Maria Maggiore”, il conte “avendole attentamente considerate tali e quali le mi trascriveste, e supponendo in essa confusione di sigle greche e latine, com’è ovvio ne’ monumenti de’ secoli bassi”, stimava “potersino leggere: Θεoς Πατηϱ, Spiritus Aγιoς Πατϱoς, Θεoς Filius, Aμην, Aμην, Aμην. Deus Pater, Spiritus Sanctus patris, Deus Filius, – Amen. Amen. Amen.”[lvi]

L’iscrizione esistente sulla campana della chiesa di Santa Maria Maggiore di Santa Severina pubblicata dal Capialbi (1849).
Questa “inesatta interpretazione” del Capialbi, dovuta al fatto che “Il Ganini copiò male” e che “si scrisse e si scrive da lontano”,[lvii] fu totalmente sconfessata quasi un secolo dopo dall’Orsi che, durante la sua permanenza a Santa Severina, nella primavera del 1911, salito “faticosamente su quel pericoloso campanile”, per ispezionare la famosa “campana dell’Addolorata” malamente edita dai precedenti autori, pur riconoscendola “pregevole”, la giudicò “forse del sec. XIV, con lettere gotiche che ricordano un M(agister) Andreas, ma nulla di bizantino.”[lviii]
Di fronte a ciò, pur essendo costretti a riconoscere i grossolani errori del passato, le autorità ecclesiastiche locali scelsero di mantenere sospeso il giudizio emesso dall’Orsi, trovando anzi spunto per rivendicare l’estraneità della chiesa di Santa Severina rispetto allo “scisma foziano”.[lix] Meditavano poi di far realizzare nuovi studi, per poter accertare l’effettiva epoca di realizzazione dell’antica campana ed il significato della sua iscrizione, perché “l’ultima parola” non era stata “ancora detta”, riproponendosi di sostituirla con una nuova, in maniera da poterla riporre tra le “antiche memorie” della città, raccolte dall’arcivescovo Puija nella “sala dell’Episcopio”.[lx]
La campana, invece, essendo ormai tramontato ogni interesse attorno ad essa, rimase sul campanile “dell’Addolorata” e, solo dopo essere stata colpita da un fulmine “intorno agli anni Settanta”, fu ricollocata nel locale “Archivio Arcivescovile”, dopo una operazione di recupero realizzata nell’aprile del 1989 dalla ditta locale Nocita “sotto il patrocinio dell’Amministrazione Comunale” e grazie all’interessamento di Ilario Principe dell’Università di Cosenza e di Pino Barone di Santa Severina.[lxi]
Su di essa possiamo ancora leggere l’iscrizione medievale che ricorda il maestro dell’ordine cavalleresco che la donò alla chiesa:
A(MEN) +A(MEN) · M(AGISTER) · ANDREAS · M(I)H(I) · A(MEN).
Il riferimento alla SS.ma Trinità costituito dalle tre A (la maggiore riferita al Padre, quella sormonta dalla croce riferita al Figlio e la terza allo Spirito Santo) poste ai vertici di un triangolo che contiene il testo con il suo nome, infatti, esclude che questo maestro possa essere confuso con l’artigiano che ne realizzò la fusione.

La campana conservata nel Museo Diocesano di Santa Severina (foto di P. Barone).

Particolare dell’iscrizione esistente sulla campana conservata nel Museo Diocesano di Santa Severina (KR).
Note
[i] Guillou A., Les Actes Grecs des Fonds Aldobrandini et Miraglia XI – XIII sec., p. 141-144; Delaville Le Roulx J., Cartulaire Général de l’Ordre des Hospitaliers de S. Jean de Jérusalem (1110-1310), Parigi 1897, tome second (1201-1260), pp. 900-901.
[ii] Pratesi A., Carte Latine di Abbazie Calabresi provenienti dall’Archivio Aldobrandini, 1958, pp. 399-403.
[iii] Trinchera F., Syllabus Graecarum Membranarum 1865, pp. 373-374 n. CCLXXII.
[iv] Russo F., Regesto I, 1521.
[v] Russo F., Regesto I, 1525.
[vi] Russo F., Regesto I, 1534.
[vii] Russo F., Regesto I, 2413.
[viii] Vendola D., Rationes Decimarum Italiae nei sec. XIII e XIV, Apulia-Lucania-Calabria, 1939, pp. 203 e 214.
[ix] Salerno M., Toomaspoeg K., L’inchiesta Pontificia del 1373 sugli Ospedalieri di San Giovanni di Gerusalemme nel Mezzogiorno d’Italia, 2008, pp. 109 e 265-267.
[x] AASS, vol. 2A.
[xi] ASV, Instr. Misc., 2788.
[xii] AASS, pergamena 077. Alla metà del Cinquecento, i due benefici risultavano posseduti da R.do D. Nicolao Carrafa, come si ritrova in relazione al pagamento della decima alla Santa Sede. “R.to del S.r Cola Carraffa per S(anc)to Gioanne battista di S(anc)ta Severina per x.a d. 1.1… Et per S(anc)to Oppido d. 0.1…” AASS, 2A, f. 105.
[xiii] 3 maggio 1504. Giovanni Millesimo fa testamento nella sua casa posta “in civitate sancte severine in parrochia sancti joh(an)nis baptiste jux(ta) domum joh(an)nis jaquinte franciscus jaquinte viam puplicam et alias fines.” AASS, pergamena 078.
[xiv] 20 luglio 1539. “Die XX Iulii 1539, d. dionysius quondam Bartholomei de Molariis de Cento, Bononien. dioc., rector cappelle in parochiali ecclesia S. Iohannis Baptiste, site et fundate in ecclesia seu iuxta ecclesiam metropolitanam S. Severinae, per d.num Antonium Massam de galesio, clericum Romanum, procuratorem suum, in manibus S.mi D.N.ppe resignavit, in favorem d. Leonardi Sacchi, pbri S. Severine dictam cappellam, cum reservatione pensionis annue 10 duc. super fructibus parochialis S. Nicolai de plateis, terre Mesurace, dicte dioc., quam idem Leonardus obtinet, …”. Russo F., Regesto IV, 18097.
24 novembre 1539. “Leonardo Sacco, pbro S. SEverinae, providetut de cappella in ecclesia S. Io Baptistae sita et fundata in ecclesia iuxta metropolitanam ecclesiam S. Severinae, vac. per liberam resignationem Dionisii quondam Bartholomaei de Molariis de Cento, Bononien. dioc., reservata eidem annua pensione 10 duc. auri in auro de camera super fructibus parochialis ecclesiae S. Nicolai de Platea, terre Mesurace, eiusdem S. Severinae dioc. Cuius trefatus Leonardus est rector.” Russo F., Regesto IV, 18.141.
[xv] “Hectori Brancati, clerico Ariminen., providetur de parochiali seu s.c. ecclesia S. Io. Baptistae, S. Severinae, vac. per resignationem Salvatoris Fracsii.” Russo F., Regesto IV, 29491.
[xvi] “Die V octobris 1557, d.nus Salvator fracsius, rector seu perpetuus capellanus cappelle, parochialis forsan nuncupate, S. Io. Baptiste, S. Severine, per d.num Decium Alberti, procuratorem suum, consensit resignationi dicte ecclesie seu cappelle, in manibus S.mi D.N.ppe, in favorem d.ni Hectoris Brancati, clerici Ariminen., cui de illa provideri conceditur per supplicationem”. Russo F., Regesto IV, 20534.
[xvii] Tra i fondi esistenti in territorio di Santa Severina, appartenenti alla Vacante Mensa Arcivescovile di Santa Severina (1797), figura: “S. Jannello – Parocchia di S. Gio: Batt(ist)a di S. Severina d. 10”. AASS, 82A.
[xviii] La circostanza è evidenziata già durante la visita arcivescovile in questione (AASS, 16B), ed è rimarcata da una fede fatta dai parroci della città il 29 giugno 1699, nella quale si evidenzia che solo la cattedrale era “… Chiesa Battesimale, conservandosi in essa solamente il fonte battesimale, nel quale si ministra il Sacramento del Battesimo a tutti i bambini della Città medesima che nascono sotto quals.a di dette parrocchie, e così sempre ab immemorabili tempo si è osservato, e di presente si osserva …”. Le Parrocchie di Santaseverina, in Scalise G. B. (a cura di), Siberene Cronaca del Passato per le Diocesi di Santaseverina – Crotone – Cariati, pp. 149-150.
[xix] AASS, 16B, ff. 2 e 18v-19v.
[xx] Orsi P., Siberene – S. Severina, in Le Chiese Basiliane della Calabria, Firenze 1929 p. 210.
[xxi] “Parecchio altro materiale costruttivo antico fu impiegato nella erezione del Battistero bizantino; delle otto colonne, sette sono di granito ed una di pezzami intonacati;”. Orsi P., Siberene – S. Severina, in Le Chiese Basiliane della Calabria, Firenze 1929 p. 205. “Delle otto colonne, per quanto ho potuto vedere, una sola è in fabbrica, le altre di granito;”. Ibidem, p. 207.
[xxii] Secondo il Loiacono, la mancanza di una finestra sul lato sud, corrispondente alle tre esistenti disposte ad inquartare la rotonda dell’edificio in corrispondenza dei quattro punti cardinali, lasciava pensare che “il Battistero” potesse essere stato costruito posteriormente alla cattedrale. “Sull’arco murario AB non si riscontrò traccia di una quarta luce. Ciò forse perché la costruzione della chiesa madre era già iniziata quando fu fondato il Battistero. Questa considerazione potrebbe darci maggior lume sulla datazione del monumento.” Loiacono P., Sul restauro compiuto al Battistero di Santa Severina, in Bollettino d’arte del Ministero della P. I., 1934, p. 175.
[xxiii] Loiacono P., Sul restauro compiuto al Battistero di Santa Severina, in Bollettino d’arte del Ministero della P. I., 1934, p. 179.
[xxiv] “Ed attaccato a detta Chiesa vi è un’altra Chiesuola piccola antichissima detta di S. Giovanni coperta a lamia con un intercolunnio circolare con colonne di granito orientale d’ordine Toscano, dentro della quale chiesa vi è il fonte battesimale per esser chiesa parrocchiale.” Scalise G. B. (a cura di), Siberene Cronaca del Passato per le Diocesi di Santaseverina – Crotone – Cariati, p. 104.
[xxv] “cod. Vat. Gr. 1862, 153 recto”. Guillou A., Le iscrizioni bizantine di Santa Severina, in Quaderni Siberenensi, giugno 1999, p. 37.
[xxvi] Nell’apprezzo della città di Santa Severina del 1653, scritto da Carlo Maffeo con l’aiuto di alcuni collaboratori, dopo la morte della principessa di Scilla Giovanna Ruffo, troviamo: “Da detta Nave destra app.o è la Sacrestia si entra in una Chiesa piccola, la quale è de forma circolare coverta con Cupola sustentata da Colonne sotto titolo di San Gio: Battista nella quale è il fonte Battesimale la quale fu fatta nell’anno 13 come appare dal millesimo s.a una di dette Colonne e questa è la Chiesa anticha parrocchiale.” AASS, 31A, f. 20.
[xxvii] “Giovan Battista, la cui memoria a caratteri greci si conserva ancora nel Battisterio, senza sapersi altro del tempo;”. Fiore G., Della Calabria Illustrata, tomo II, p. 534.
[xxviii] “JOANNES BAPTISTA Graecus Sanctae Severinae Episcopus, cujus memoria Graecis chraracteribus extant in epistylio columnae Parochialis Ecclesiae S. Joan. Baptistae prope Cathedralem. IΩAN. BAΠT. ΔAPXHETTHCKIT. KATEKEBA. ΔIK. IΓ. Plures aliae Graecae inscriptiones tum in Cathedrali, tum in aliis ejusdem civitatis Ecclesiis sunt, et Episcoporum Graecorum inscriptiones quae vetustate pene deletae vix videri, non tamen legi possunt.” Ughelli F., Italia Sacra, VIII, Venezia 1721, c. 475.
[xxix] “Circa l’iscrizione di Giovanni Arcivescovo, io la trovo anche interessante. L’Ughelli la riferisce con molti errori, non saprei se da lui o da coloro che gliela comunicarono commessi: così IΩAN. EAΠT. ΔAPXHTTCKIT. KATEKEBA. ΔIK. IΓ., da cui non se ne può cavare senso alcuno. – Dalla forma delle lettere, se ne potessi avere un fac simile, spererei indovinarne approssimativamente il secolo, in cui venne scolpita.” Scalise G. B. (a cura di), Siberene Cronaca del Passato per le Diocesi di Santaseverina – Crotone – Cariati, Un’altra lettera del Conte Vito Capialbi, p. 248.
[xxx] “A proposito: nell’iscrizione del capitello del battisterio dopo le lettere Kατεσευασε dovrebbe fare osservare bene le tre sigle, che sono avanti alle altre INΔIK. In quelle ho ragione da credere che vi si nasconda o esprima la voce Nηως doricamente scritta per Nαõς templum, o l’anno della costruzione. Stando come voi la delineaste direbbe 582; ma in quell’epoca Santaseverina non aveva pastore. Con lieve mutazione potrebbero dire 882 e tutto converrebbe coll’istoria oscura di que’ tempi; ma l’indizione era 15 e non 13, …”. “Ma se pure ciò fosse il costumo di segnare gli anni de’ greci, a quell’epoca era ben differente numerando essi dalla creazione, per cui debbo candidamente confessare che le tre cifre anteriori all’INΔIK o non giungo a capirle, o legger si debbono come diceva Nηως alla dorica invece di Nαõς.” Scalise G. B. (a cura di), Siberene Cronaca del Passato per le Diocesi di Santaseverina – Crotone – Cariati, A proposito d’iscrizioni greche, p. 240.
[xxxi] Capialbi V., Opuscoli Varii del Dottor Vito Capialbi, Tomo I, Napoli 1840. Estratto Dal Faro, Anno IV, Tomo 11, Fasc. N. 11 e 12, Novembre e Dicembre 1836, Sopra alcuni monumenti del medio-evo esistenti in Calabria. Lettera del Cavaliere Vito Capialbi al Signor Carlo Bonucci, Architetto Direttore degli Scavi di Antichità in Napoli, p. 5.
[xxxii] “GNOSEΩGRAFIA, Storica Critica Cronologica della Regia Metropolitana Chiesa di Santa Severina”, AASS 084A.
[xxxiii] AASS 084A, f. 52.
[xxxiv] Jordan E., Monuments byzantins de Calabre, Santa Severina, in Mélanges d’archeologie et d’histoire, tome 9, 1889, pp. 321-324. https://www.persee.fr/doc/mefr_0223-4874_1889_num_9_1_6593.
[xxxv] “IωAN. BAΠT. ΔAPXHTETHCKIT KATEKEBA ΔIK. IΓ.” Jordan E., Monuments byzantins cit., p. 322.
[xxxvi] Schultz H. W., Denkmaeler der Kunst des Mittelalters in Unter Italien, II, Dresda 1860, p. 351.
[xxxvii] “Malheureusement la simple mention de l’anneé d’indiction ne permet pas de préciser davantage.” Jordan E., Monuments byzantins cit., p. 324.
[xxxviii] www.treccani.it/enciclopedia/paolo-orsi_(Dizionario-Biografico)/
[xxxix] “Ho passato in due riprese nella primavera del 1911 alcuni giorni a S. Severina …”. Orsi P., Siberene cit., 1929, p. 201. “Quanto espongo è il frutto di due rapide visite fatte a S. Severina nel maggio e giugno del 1911, coadiuvato dai miei bravi collaboratori prof. Sebastiano Agati e Rosario Carta, il quale ultimo vi fece una nuova visita nel novembre per completare i suoi disegni, ed eseguire qualche tasto.” Orsi P., Siberene cit., 1929, pp. 205-206.
[xl] Orsi P., Le chiese Basiliane della Calabria, Santa Severina in Bollettino d’arte del Ministero della P. I., VI (1912), pp. 189-239.
[xli] “Nessun archeologo, che a me consti, è stato lassù, e nemmeno il Lenormant; e così non fu visitata nè dallo Schultz, nè dal Salazaro, nè dal Bertaux, che pubblicarono opere grandiose sull’arte ed i monumenti del Mezzogiorno.” Orsi P., Siberene cit., 1929, p. 200. In nota afferma poi l’Orsi: “Forse la visitò, ma in ogni caso troppo rapidamente, il DIEHL, che ai suoi monumenti medioevali dedicò brevi ma sensate pagine (L’Art byzantin dans l’Italie méridionale, pag. 199-203). Un rapido sguardo ai monumenti sanseverinati è stato dato anche dal Croce in Napoli Nobilissima 1894, pag. 71-72, riassumendo le opinioni, giuste od errate, dei vari studiosi stranieri.” Orsi P., Siberene cit., 1929, p. 234, nota n. 18.
[xlii] “Malgrado la sua alta importanza, il Battistero di S. Severina va considerato come monumento inedito. H. Wil. SCHULTZ (Denkmaeler der Kunst des Mittelalters in Unter Italien), II vol., pag. 351 (Dresda 1860), dedica a S. Severina appena poche righe della sua classica opera, citando solo l’iscrizione battisteriale di Iohannes. Il Salazaro nei suoi farraginosi Studi sui monum. dell’Italia mer. dal IV al XIII sec. (Napoli 1877, 2 voll. gr. fol.) non ne parla affatto, come non esistesse. Invece lo Jordan, che visitò la città col Batiffol nel 1889, ne dà una pianta e sezione, con breve commento della epigrafe (Monum. byzantins de Calabre in Melanges Ecole franç, de Rome, 1889; estratto di pag. 1-4). Il disegnatore sig. Carta, è ritornato nel novembre 1911 a S. Severina per redigere con tutte le regole d’arte la pianta, la sezione ed i dettagli del Battistero che qui presento e che ho ragione di credere esattissimi.” Orsi P., Siberene cit., 1929, p. 235, nota n. 21.
[xliii] “Di fronte a tali difficoltà debbo limitarmi a descriverlo nel suo stato attuale, presentando una pianta ed una sezione (figg. 134 e 135) che il sig. R. Carta mio disegnatore ha eseguito sul vero, controllando quella del tutto inesatta del Jordan, che è poi l’unica esistente.” Orsi P., Siberene cit., 1929, p. 206.
[xliv] “Sul pulvino SO è scolpita nelle quattro fronti l’iscrizione che è stata riprodotta con lezione errata per primo dall’Ughelli (Italia Sacra, vol. IX, pag. 670), e più correttamente dallo Schultz (Denkmaeler, II, pag. 351), e dal Jordan (op. cit., pag. 3, estr.), ma pur sempre con errori paleografici. Sono ora lieto di poterne dare il facsimile col testo preciso e definitivo (fig. 138), osservando che le lettere sono disuguali di modulo ed altre da 5, 6 centimetri.” Orsi P., Siberene cit., 1929, p. 208.
[xlv] Orsi P., Siberene cit., 1929, p. 208.
[xlvi] Loiacono P., Sul restauro compiuto al Battistero di Santa Severina, in Bollettino d’arte del Ministero della P. I., 1934, p. 174.
[xlvii] Loiacono P., Sul restauro cit., p. 178.
[xlviii] Loiacono P., Sul restauro cit., pp. 176-177.
[xlix] Guillou A., Le iscrizioni bizantine di Santa Severina, in Quaderni Siberenensi, giugno 1999, pp. 37-39.
[l] “Il disegno riproduce la faccia principale del cuscino, con croce di Malta in disco affiancato da due colombe, una delle quali legata da un nastro al collo. Il lavoro di incisione, e non di scoltura, è anche qui condotto penosamente, e così le lettere, sparse un po’ ovunque.” Orsi P., Siberene cit., 1929, p. 209.
[li] Orsi P., Siberene cit., 1929 p. 209.
[lii] Orsi P., Siberene cit., 1929, p. 198, fig. 140.
[liii] Guillou A., Le iscrizioni bizantine di Santa Severina, in Quaderni Siberenensi, giugno 1999, pp. 39-40.
[liv] Rende P., La cattedrale di Santa Severina tra Alto e Basso Medioevo, www.archiviostoricocrotone.it
[lv] Capialbi V., Opuscoli Varii del dottor Vito Capialbi, Tomo III. Epistole, Riviste, Illustrazioni e Descrizioni, Napoli 1849, pp. 82-83. Scalise G. B. (a cura di), Siberene Cronaca del Passato per le Diocesi di Santaseverina – Crotone – Cariati, A proposito d’iscrizioni greche, p. 240. Capialbi V., Opuscoli Varii del Dottor Vito Capialbi, Tomo I, Napoli 1840. Esposizione di un anello d’argento, e di un bollo di rame. – Al chiarissimo Cav. Roberto Betti Intendente della Prima Calabria Ulteriore, pp. 9-10.
[lvi] Capialbi V., Opuscoli Varii del dottor Vito Capialbi, Tomo III. Epistole, Riviste, Illustrazioni e Descrizioni, Napoli 1849, pp. 70-71. Scalise G. B. (a cura di), Siberene Cronaca del Passato per le Diocesi di Santaseverina – Crotone – Cariati, Un’altra lettera del Conte Vito Capialbi, pp. 241-248.
[lvii] Scalise G. B. (a cura di), Siberene Cronaca del Passato per le Diocesi di Santaseverina – Crotone – Cariati, A proposito d’iscrizioni greche, p. 241.
[lviii] “Mons. Taccone-Gallucci, Epigrafi, p. 50, e da lui copiando Mons. Puija, Cronotassi p. 42, traggono da vecchi scrittori il ricordo di una epigrafe greca sulla campana dell’Addolorata. Salito faticosamente su quel pericoloso campanile vi ho riconosciuta una pregevole campana conica forse del sec. XIV, con lettere gotiche che ricordano un M(agister) Andreas, ma nulla di bizantino.” Orsi P., Siberene cit., 1929, p. 235, nota n. 40.
[lix] “La iscrizione della vecchia campana di Santasevrina fu, dunque, letta male e, per ciò, male interpetrata da’ lontani e dallo stesso valente archeologo e storico il Conte Vito Capialbi: noi di Santaseverina non negammo mai la processione dello Spirito Santo dal Padre e dal Figlio. La nostra campana non fu, quindi “un pubblico monumento” contro le «credenze dei latini limitrofi.»” “Se quanto dice il Comm. Orsi è vero, non solo cade il vecchio equivoco, ma anche cadono tutte le interpetrazioni dell’epigrafe, non letta bene dai vecchi osservatori e le congetture che n’erano venute, ma anche avremmo un monumento che ci provi essere passata la Chiesa nostra dal rito greco al latino nel XIV secolo. E si: perché se nella campana non sono greche le lettere ma gotiche – introdotte qui con i Normanni – è da ammettersi che noi non alla fine, ma nel corso di quel secolo accettammo il rito della Chiesa di Roma; come sin dall’XI secolo ne avevamo accettata la piena dipendenza.” Puija A., Un Vecchio Equivoco, in Scalise G. B. (a cura di), Siberene Cronaca del Passato per le Diocesi di Santaseverina – Crotone – Cariati, pp. 264-265.
[lx] “Ma l’ultima parola su la nostra campana non è ancora detta: tanto che, per studiarne bene le lettere che vi si trovano, l’attuale arcivescovo intende farla togliere dal campanile e sostituirla con altra nuova.” “Su la data della fusione della campana nulla può dirsi, se prima non è studiata da vicino, e da intendenti della materia. Né l’M interpetrato per Magister, ci appaga pienamente.” “Per evitare anche che si possa rompere, l’Arciv. C. Puija pensa portare la campana nella sala dell’Episcopio: ove ha già posto le pietre con le iscrizioni greche e quanto altro ha trovato di antiche memorie.” Puija A., Un Vecchio Equivoco, in Scalise G. B. (a cura di), Siberene Cronaca del Passato per le Diocesi di Santaseverina – Crotone – Cariati, pp. 264-265 e note n. 7 e 8.
[lxi] Barone P., Santa Severina: la storia e le sue campane, 1991 pp. 87-88.
The post Dall’ordine della “Militiae Templi” a quello Gerosolimitano, la chiesa di San Giovanni di Santa Severina (sec. XII-XIV) appeared first on Archivio Storico Crotone.
La cattedrale di Santa Severina dedicata a Santa Anastasia Romana tra Alto e Basso Medioevo

Santa Severina (KR), facciata della cattedrale dove campeggia l’iscrizione: IN HONOREM S. ANASTASIAE V. ET M. INCLYTAE CAROLUS BERLINGERIUS ARCHIEP. S. SEVERINAE A.D. MDCCV.
La chiesa di Santa Severina emerge al tempo di Leone VI il Filosofo (886-911), quando risulta documentata l’esistenza del nuovo vescovato di “Santa Severina di Calabria” (Ἁγίᾳ Σευηρινῇ τῆς Kαλαβρίας), che compare come nuova metropolia, assieme ai suoi quattro nuovi vescovati suffraganei: Umbriatico (ὁ Eὐρυάτων), Cerenzìa (ὁ ’Aϰερεντίας), Belcastro (ὁ Kαλλιπόλεως) e Isola ([ὁ] τῶν ’Aησύλων).[i]
Risalgono a questo periodo anche le prime notizie che sottolineano la particolare importanza strategica della sua posizione, quando, a seguito della conquista musulmana della Sicilia, avviata nel 827,[ii] la Calabria, già interessata dalle scorrerie dei Saraceni, fu esposta più direttamente alla loro minaccia che, attorno alla metà del secolo, si concretizzò con l’occupazione di “S. Severina” e di altre località rivierasche dello Ionio e del Tirreno.[iii]
Fondamentale per il controllo dei collegamenti tra la parte meridionale e quella settentrionale della regione, il luogo fu riportato successivamente in potere dei Bizantini, per opera dello “stratego di Calabria” Niceforo Foca il Vecchio (885-886),[iv] nell’ambito di una vasta campagna di riconquista che, assieme a Santa Severina (Ἁγίας Σευηρίνης), consentì loro di riconquistare anche Amantea e Tropea,[v] permettendogli così di arginare l’espansione dei Saraceni e d’imporre il dominio di Bisanzio alle terre dei Longobardi. Riconquista attuata attraverso le armi, secondo il monaco benedettino Erchemperto,[vi] ricorrendo invece ad un accordo, secondo le fonti musulmane, le quali riferiscono che il loro presidio rese la “città di (Santa) Severina” a “Niceforo” e fece ritorno in Sicilia.[vii]
Il ruolo strategico della città che, evidentemente, dovette essere ripopolata in questa fase, risulta consolidato agli inizi del secolo successivo, nel De thematibus (databile agli anni Trenta del sec. X), dove, a proposito del decimo thema di Sicilia, si riferisce che Santa Severina (ἁγίας Σεβηρίνης), assieme a Reggio, S. Cyriaca, Crotone ed altre in Calabria (Kαλαβρία), era sottoposta allo stratego di Calabria (στρατηγòς Kαλαβρίας).[viii]

Santa Severina (KR), portale principale della cattedrale.
La cattedrale
Alcune antiche testimonianze epigrafiche, oggi conservate nel Museo Diocesano di Arte Sacra della città, documentano che, agli inizi del primo millennio, come si riscontra in tutto il resto d’Europa, fu eretta la cattedrale di Santa Severina.
Le prime notizie circa l’esistenza di queste iscrizioni, emergono già nella documentazione vaticana del secolo XVI,[ix] mentre, successivamente, all’inizio del suo presulato, il crotonese Carlo Berlingieri (1679-1719) accenna genericamente ad alcune “inscriptiones” che testimoniavano l’antichità della sua sede vescovile.[x] L’esistenza d’iscrizioni di vescovi greci illeggibili per la loro vetustà, “tum in Cathedrali, tum in aliis ejusdem civitatis Ecclesiis”, è riferita dall’Ughelli nel volume IX della sua “Italia Sacra” edito nel 1721.[xi]
Risalgono invece alla prima metà dell’Ottocento, i primi tentativi locali di studiare questi antichi testi, quando monsignor Deodato Ganini, arcidiacono e vicario generale di Santa Severina, avvalendosi dell’amicizia del conte Vito Capialbi (1790-1853) di Monteleone, letterato, storico e archeologo, appartenente a diverse accademie, ricorse alla sua riconosciuta competenza, per avere dei pareri a riguardo.
La corrispondenza che i due intrattennero in questa occasione, è contenuta nel tomo I (1840) e nel tomo III (1849) degli “Opuscoli Varii” pubblicati dallo stesso Capialbi prima della sua morte che, dopo la sua scomparsa, fu ristampata sulla rivista “Siberene”, fondata nel gennaio 1913 dall’arcivescovo di Santa Severina Carmelo Pujia e diretta da suo fratello Antonio.[xii]
In una lettera del 22 novembre 1829, scritta da Monteleone in risposta a quella di monsignor Ganini “de’ 26 prossimo passato mese”, il Capialbi riferiva circa una “monca iscrizione greca” sottopostagli dal suo interlocutore, affermando che, appena avesse avuto un po’ di tempo, l’avrebbe esaminata “con tutta diligenza, tenendo presenti le circostanze della pietra, ed il luogo, ove la rinveniste.”
Entrando comunque in argomento, il conte affermava che, similmente a quanto riportava un’altra iscrizione esistente sul “capitello del battisterio” fattagli pervenire, “Il Giovanni, di cui si fa menzione nelle due iscrizioni rimessemi, potrebbe essere il primo notato dall’Ughelli, ma potrebbe stare che fusse anche quegli, che viveva nel 1129.” A riguardo di ciò, giudicava che le “forme delle lettere forse potrebbero sole darci qualche lume: per tutt’altro è dubbio, se fosse stato l’uno o l’altro”, considerato, oltre tutto, che “l’autorità dell’Ughelli nulla vale”, perché egli aveva solo riportato quanto gli era stato “riferito, e malamente riferito” da Santa Severina.[xiii]
Successivamente, invece, questa valutazione del Capialbi fu “assolutamente” scartata dall’Orsi, che giudicava impossibile identificare l’arcivescovo Giovanni menzionato nell’iscrizione, con quello presente alla “coronazione di re Ruggero in Palermo”, il giorno di Natale del 1130, “essendo il Battistero opera senza dubbio prenormanna”.[xiv] Noi sappiamo, invece, che la costruzione del “Battistero” è certamente da riferire al periodo successivo alla conquista normanna, e che la testimonianza relativa all’arcivescovo Giovanni riportata sull’unico “capitello di marmo della chiesa”,[xv] che ne ricorda la costruzione da parte sua, risulta estranea a tale contesto.[xvi]

Santa Severina (KR), chiesa di San Giovanni Battista. Particolare della iscrizione che menziona l’arcivescovo Giovanni (foto P. Barone).
Le iscrizioni perdute
Risale al 27 dicembre 1829, la lettera con la quale il conte Vito Capialbi fornì finalmente a monsignor Ganini, l’interpretazione richiesta “circa l’ultima monca greca iscrizione favoritami”.
In questa occasione, avvalendosi anche dell’aiuto del figlio primogenito, il “dotto Storico” faceva notare all’amico, che l’iscrizione in questione risultava “una ripetizione di un’altra da voi favoritami, e che io avevo letto alla meglio.” Entrambe queste, poste “nel medesimo edificio della vostra Arcicattedrale”, erano infatti “di quattro linee, le quali cominciano colle stesse voci, colle medesime lettere, e co’ medesimi scompartimenti: l’ortografia, e la forma delle lettere sono somigliantissime” mentre, “Con piccolo supplimento alla terza linea”, la restituzione del testo risultava il seguente per “ambedue”:
+ KΥPIE ΘEOΣ HMωN
Toυ Δoυλoυ σoυ
AMAPToλoυ APXIEΠHΣKOΠOV
IωANNOυ +
+ Domine Deus noster (supple recordare)
Servi tui
Peccatoris Archiepiscopi
Joannis +”.[xvii]
L’iscrizione esistente sui “Due travertini inediti della Chiesa Metropolitana di S. Severina”, è riportata dal Capialbi, con la medesima interpretazione, anche nel tomo I dei suoi “Opuscoli Varii”:
+ KĒ ΘEOC HMωN
Toυ Δoυλoυ coυ
AMAPτoλoυ APXI …..
IωANNoυ +
“Domine Deus noster (supple: MNH CΘHTI – recordare o memento) servi tui peccatoris Archiepiscopi Joannis, oppure Boηθη: adiuva servum tuum peccatorem Archiepiscopum Joannem.”[xviii]
Volendo cercare di identificare questo arcivescovo Giovanni, al fine di definire il periodo di tempo in cui furono realizzate le iscrizioni che lo riguardano, rileviamo che, nel periodo compreso tra la fine del sec. XI e quella del sec. XIV, quando può avere senso il titolo arcivescovile scritto in greco che lo identifica, le notizie in nostro possesso possono essere ricondotte: al Giovanni che “fu tra i presenti alla coronazione di Ruggero II, il giorno di Natale del 1130”, al Giovanni che fu scomunicato ai tempi di Marcovaldo,[xix] oppure al Giovanni detto “de policastro”, che si colloca durante la prima metà del Trecento.[xx]
In merito invece, alla presenza di altre antiche testimonianze provenienti dalla cattedrale, da un altro opuscolo dello stesso Capialbi, pubblicato già nel 1836, apprendiamo che quest’ultimo nutriva la speranza di poter rintracciare nella “antica Cattedrale” di Santa Severina, qualche altra testimonianza medievale, accennando al fatto che, a quel tempo, monsignor Ganini gli aveva “rimesso altre tre iscrizioni greche, sebbene monche, dell’epoca, di cui parliamo”.[xxi] Sappiamo inoltre che, durante la primavera del 1911, ormai ultimati i “grandiosi lavori del sottosuolo della cattedrale”, Paolo Orsi aveva potuto esaminare uno dei “mattonacci” della vecchia fabbrica, recante “il seguente bollo rettangolare, a letterine nitide e belle, mancante però del principio:
…………. TOYOP
KAINOYIOYEΛE[xxii]

Santa Severina (KR). Bassorilievo medievale conservato nel locale Museo Diocesano di Arte Sacra (1), simile a quello murato nella parete della cappella di San Leone della cattedrale (2). Foto di Pino Barone.
Le testimonianze rimaste
Rispetto ai primi tentativi ottocenteschi, condotti dal Capialbi con l’intento d’interpretare le iscrizioni sottopostegli dal Ganini che, in alcuni casi, si dimostreranno di epoca successiva a quella Bizantina, più risonanza ebbero quelli successivi messi in atto al tempo dell’arcivescovo Carmelo Pujia (1905-1927) che, dopo i danni causati dal terremoto del settembre 1905, intraprese il restauro della cattedrale spendendovi “ingenti somme”,[xxiii] e si adoperò per far giungere a Santa Severina, ad investigarne i monumenti, l’importante archeologo Paolo Orsi (Rovereto, 1859-1935) che, al tempo, dirigeva “l’appena costituita Regia Soprintendenza agli scavi e musei di Reggio Calabria”,[xxiv] ed era impegnato a condurre scoperte archeologiche in numerosi luoghi della regione.
L’Orsi, assieme ai suoi collaboratori, soggiornò “alcuni giorni” a Santa Severina “in due riprese”, nei mesi di maggio e giugno del 1911,[xxv] e pubblicò i risultati ottenuti dalle indagini condotte, una prima volta nel 1912, sul Bollettino d’arte del Ministero della P. I.[xxvi] e successivamente, nel volume Le Chiese Basiliane della Calabria (1929) che, a differenza di qualche precedente incerto, costituivano il primo tentativo condotto da un archeologo, di appurare la realtà esistente direttamente sul campo.[xxvii]
Animato dalla volontà di scoprire quanto si celava in un contesto che gli si presentava praticamente inesplorato, l’Orsi visitò i luoghi ed i resti della città più interessanti per l’antichità che dimostravano ai suoi occhi, e visionò le “due epigrafi bizantine” che, a suo dire, “con savio provvedimento”, l’arcivescovo Pujia aveva “fatto distaccare dal muro settentrionale della cattedrale vecchia”, dove “stavano «ab immemorabili»” e tanto “deperivano da essere prossime alla ruina totale”,[xxviii] facendole portare con altre “antiche memorie”, nella “sala dell’Episcopio” come risulta riferito dalla testimonianza di suo fratello Antonio nel giugno 1916.[xxix]

Paolo Orsi (da www.museocivico.rovereto.tn.it)
La “cattedrale vecchia”
L’esistenza di una fantomatica cattedrale “Greca” o “vecchia” di cui non siamo riusciti a trovare traccia, tanto meno nel locale Archivio Arcivescovile, comincia ad essere attestata in una tarda e anonima “GNOSEΩGRAFIA” manoscritta, conservata in questo archivio,[xxx] che attribuisce a “Rogerio di Stefanuzia” che fu arcivescovo di Santa Severina durante l’ultimo quarto del sec. XIII, la costruzione di una “nuova Cattedral Basilica”, dedicata “sotto la special invocazione di S. Anastasia Vergine e Martire”.[xxxi]
Sempre in questo manoscritto, volendosi produrre prova della consacrazione da parte del vescovo Ambrogio, di una precedente “Chiesa Cattedrale Greca”, “dedicata alla Beatissima Vergine, all’Apostolo S. Andrea ed alla Martire S. Severina”, si richiama l’esistenza di una “lapide sottratta all’ingiurie de tempi” che, pur priva di datazione, sembrava costituire una chiara prova in tal senso, in ragione dei suoi “greci caratteri”.
Questa cattedrale greca, sebbene rimaneva “oscura” l’epoca precisa della sua realizzazione, s’individuava con la chiesa parrocchiale “sotto l’invocazione di S. Maria Magiore”,[xxxii] mentre, della “lapide” un tempo esistente “dentro l’antica Chiesa Cattedrale Greca” ed “oggi conservata nella Biblioteca del Capitolo”, si fornivano una trascrizione ed una traduzione in latino:
+ K ΘEOΣ HMΩN TH ΠPEΣBIA
THΣ AΓIAΣ ΘEOTOKOΥ TOΥ AΓIOΥ
AΠOΣTOΛOΥ ANΔPEOΥ K THΣ
AΓIAΣ MAPTΥPOΣ ΣEΥHPINI EM
NIΣΘI TOΥ ΔOΥΛOΥ ΣOΥ AMBRO
ΣIOΥ TOΥ AΓIΩTATOΥ HMΩN EΠIΣK
“Salvator et Deus noster. Dedicatio hujus principalis Templi ad honorem Sanctorum Dei Genitricis Sancti Apostoli Andreae et Sanctae Martyris Severinae efficit ut meminerimus servi tui Ambrosii Sanctissimi nostri Episcopi.”[xxxiii]
Questa iscrizione contenuta nel manoscritto storico della “Regia Metropolitana Chiesa di Santa Severina”, che era già stata pubblicata “assai malamente da diversi”,[xxxiv] fu successivamente pubblicata anche dall’Orsi che, pur nutrendo seri dubbi sulle ragioni dei fatti che gli erano stati riferiti,[xxxv] accolse lo stesso la “tradizione costante ed antichissima”, testimoniata dalla “lapide” greca, secondo cui la primitiva cattedrale di Santa Severina era sorta sul luogo in cui esisteva la chiesa di Santa Maria Magna, dove “ora sorge la chiesetta dell’Addolorata”, in prossimità dei ruderi “denominati il Vescovato Vecchio”.[xxxvi]
+ K(ύϱι)ε ὀ ϑ(εό)ς ἠμῶν. Tῇ πϱεσβίᾳ τῆς
ἁγίας Θεoτόϰoυ τoῦ ἁγίoυ
ἀπoστόλoυ Ἀνδϱέoυ ϰ(αί) τῆς ἁ-
γίας μάϱτυϱoς Σευιϱίνης
μνίσϑιτι τoῦ δoύλoυ σoυ Ἀ-
μβϱoσίoυ τoύ ἀγιωτάτoυ ἠμῶν ἐπισϰ(όπoυ).
Ai suoi tempi, però, questa epigrafe già sottoposta all’attenzione del Capialbi,[xxxvii] non si trovava più nella biblioteca del Capitolo, come si affermava nel manoscritto, ma l’archeologo di Rovereto la trovò “posta in salvo e murata nell’episcopio”, considerato che, precedentemente, “era stata collocata da ignoranti operai come gradino nel seminario.” A tale riguardo, poi, l’Orsi affermava di non sapere dove “fosse collocata in origine”, anche se giudicava che “con ogni probabilità era nella cattedrale vecchia”.[xxxviii]
Più verosimilmente, invece, considerando i luoghi dove fu ricollocata, ed il consistente consumo della sua superfice, dovuto, evidentemente, al prolungato calpestio, possiamo immaginare soltanto una sua provenienza dal pavimento della stessa cattedrale, da cui fu probabilmente rimossa in occasione dei “grandiosi lavori del sottosuolo” fatti eseguire dall’arcivescovo Carmelo Pujia che, dopo il terremoto del settembre 1905, portarono alla realizzazione di una nuova pavimentazione.[xxxix]
Fino a quei tempi, infatti, pur interpretando in maniera inesatta le testimonianze bizantine conservate al suo interno, non si poneva in questione che la cattedrale dedicata anticamente a S.to Andrea e alla martire Severina, fosse lo stesso edificio successivamente intitolato a Sant’Anastasia, come appare chiaramente evidenziato da una epigrafe risalente al tempo dell’arcivescovo Carlo Berlingieri (1679-1719):
“D. O. M.
TEMPLUM HOC OLIM DIVO ANDREAE ET S. SEVERINAE MARTYRI
POSTEA DIVAE ANASTASIAE POST EJUS BRACHII INVENTIONEM
CAROLUS EPISCOPUS SIBERINANTENSIS
POSTQUAM ORNARE COMPLEVIT, DICAVIT, ASSIGNAVITQUE
DIEM XIII NOVEMBRIS PRO EJUS ANNIVERSARIA FESTIVITATE”.[xl]
Ritornando, invece, all’antica epigrafe bizantina, secondo la testimonianza di Francesco Le Pera, ancora recentemente, prima della sua definitiva sistemazione all’interno del locale Museo Diocesano di Arte Sacra, sappiamo che questa si trovava “sulla parete destra della prima rampa dello scalone dell’arcivescovado attiguo alla cattedrale.”[xli]
Il Guillou (1999) ce ne fornisce la seguente trascrizione con la traduzione:
+ K(ύϱι)ε ὀ Θ[(εό)ς] ἠμῶν, τῇ πϱεσβία τῆ[ς]
ἁγίας Θεoτòϰ(oυ), τ(oῦ) ἁγίoυ
ἀπoστόλ(oυ) Ἀνδϱέ(oυ), (καὶ) τῆς ἁ-
γίας μάϱτυϱoς Σευιϱίνι
ς μνίσϑιτι τ[oῦ δ(oύ)λ(oυ) σoυ A-
μβρoσί(oυ) τ(oῦ) ἁγιωτά[τ(oυ) ἡ]μ(ῶ)ν ἐπισκ(όπoυ).
“Signore Iddio, per l’intercessione dell’Immacolata Theotokos, del santo apostolo Andrea, e della santa martire Severina, ricordati del tuo servo Ambrogio, nostro santissimo vescovo.”[xlii]

L’epigrafe bizantina che ricorda il vescovo Ambrogio (Museo Diocesano di Arte Sacra di Santa Severina).
L’anno di costruzione
Ulteriori elementi, utili a comprendere e contestualizzare meglio, le informazioni che possiamo attingere da questa prima testimonianza, ci sono fornite da altre due epigrafi che, assieme alla precedente, dimostrano di costituire un insieme coerente, risultando chiaramente appartenenti “allo stesso ciclo”.[xliii]
La prima di queste, infatti, riferisce la costruzione della chiesa da parte del vescovo Ambrogio nell’anno 1036 (a. m. 6544), indizione IV, secondo la “difficile” lettura dell’Orsi,[xliv] il quale, dopo “lunghi tentativi, fatti anche con la luce elettrica tangenziale”, considerato che “le offese recate dalle secolari intemperie sono così profonde che la lettura, se non al tutto disperata, ne è estremamente difficile”, ed avvalendosi della collaborazione di Giuseppe Gerola, al tempo “Soprintendente a Ravenna”, che lo aiutò sulla base della fotografia ricevuta,[xlv] così ne fissò il testo:
+ Ἐν ὀνόματι τoῦ Π(ατ)ϱ(ός) ϰαὶ
τoῦ Ὑιoῦ ϰ(αὶ) τoῦ ἁγίoυ Πν(εύματo)ς ἐϰτίσϑη ταύτη
[ἐϰϰλησία] τoῦ Θ[εo]ῦ ϰαϑoλίϰ(ή) ϰ(αὶ) ἀπoστoλίϰ(ή)
ἐπί Ἀμβϱoσίoυ τoῦ ἁγιω (τάτoυ) ἡμῶν
ἐπισϰ(όπoυ) ἰνδ(ιϰτιῶνoς) δ՚ ἔτoυς Ἱφμδʹ[xlvi]
In tempi più recenti (1999), questa “iscrizione, oggi poco leggibile”, esistente “su un blocco di pietra tenera (cm 79 x 34), mal conservato, incastrato nel muro”, ovvero “murata sulla parete sinistra della cappella del Crocifisso nell’odierna cattedrale”,[xlvii] è stata edita dal Guillou, che ha pubblicato un “testo stabilito sulla base della lettura di P. Orsi, verificata sulla pietra”, ed ha fornito questa traduzione:
+ Ἐν ὀνόματι τoῦ Π(ατ)ϱ(ὸ)ς καὶ
[τoῦ] Υ(ἱo)ῦ κ(αὶ) τoῦ ἁγίoυ Πν(εύματo)ς ἐκτίσθη ταύτη
[ἐκκλησ]ία τoῦ Θ(εo)ῦ καθoλίκ(ή) κ(αὶ) ἀπoστoλίκ(ὴ)
ἐπί Ἀμβρoσίoυ τoῦ ἁγιωτ[άτoυ ἡμῶν] ἐπισκ(όπoυ)
ἰνδ(ικτιῶνoς) δ՚ἒτoυς ςφμδʹ
“In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo è stata costruita questa chiesa di Dio universale e apostolica, sotto l’episcopato del nostro santissimo vescovo Ambrogio, durante la IV indizione, anno 6544.”[xlviii]
Si accordano con questa data di costruzione della chiesa cattedrale, due importanti riferimenti contenuti in questa antico testo, a cominciare dal termine “cattolica” (καθoλίκή) che l’identifica, ritenuto correlato alla cattedrale bizantina.[xlix] Termine che ricorre anche in un altro raro documento di questo periodo, dove si menziona Euthymios, domestico (δoμέστιϰoῦ) della cattedrale (ϰαθoλιϰῆς) di Santa Severina (῾Aγίας Σευηρίνης).[l]
Anche il fatto che, in entrambe le testimonianze che lo menzionano, Ambrogio risulti in qualità di “vescovo” (ἐπισκόπoυ), costituisce una seconda conferma in tal senso. L’uso del titolo arcivescovile, infatti, comincia ad entrare in uso soltanto dopo la conquista normanna e l’obbedienza alla chiesa di Roma mentre, in precedenza, riscontriamo l’uso dei titoli di “vescovo” e di “metropolitano”, che appartengono ad una organizzazione ecclesiastica precedente.[li]

L’epigrafe bizantina che ricorda la data di costruzione della cattedrale (Museo Diocesano di Arte Sacra di Santa Severina).
Vescovi e metropoliti
L’esistenza di una gerarchia vescovile in Calabria, comincia ad evidenziarsi verso gl’inizi del sec. IX. Sappiamo, infatti che, al tempo del concilio di Nicea del 787, i vescovi calabresi presenti risultavano ancora “indipendenti gli uni dagli altri”, ed erano tutti immediatamente soggetti alla Santa Sede.[lii] Successivamente, invece, fu eretta la metropolia di Reggio, “che esisteva nei primi del secolo IX”,[liii] alla quale furono sottomesse “tutte le diocesi della Calabria”, tra cui non figura comunque Santa Severina[liv] che, in qualità di metropolia, compare per la prima volta, solo al tempo di Leone VI il Filosofo (886-911).[lv]
In relazione a ciò il metropolita reggino non compare mai con il titolo di arcivescovo nel “Brébion” della metropolia bizantina di Reggio, che si data verso la metà del sec. XI,[lvi] né ritroviamo alcun arcivescovo tra le notizie scritte in greco da Nilo Doxapatris al tempo di Ruggero II re di Sicilia (1101-1154),[lvii] in cui la metropoli (μητρόπoλις) di Santa Severina (Ἁγία Σεβερίνη), risulta con cinque vescovati (ἐπισϰoπάς) suffraganei.[lviii] Ancora nel Provinciale Vetus di Albino, verso la fine del sec. XII, si menzionano solo “episcopos” dipendenti da una “Metropolis”.[lix]
Dopo la conquista normanna, comunque, a seguito del passaggio all’obbedienza papale, l’uso del titolo arcivescovile cominciò ad entrare in uso negli atti riguardanti i vescovi greci della Calabria. Come risulta ad esempio, in quelli pubblicati dal Trinchera.[lx] Il presule di Santa Severina, comunque, continua a comparire con l’antico titolo di metropolita, negli antichi privilegi dell’abbazia di Calabro-Maria (1099-1149),[lxi] dove Policronio risulta sempre in qualità di “Episcopus” di Cerenzìa, mentre Costantino compare sempre in qualità di “Metropolitano”, ovvero di “Praesule” della metropoli di Santa Severina.[lxii]
Ancora alla metà del sec. XII, Andrea risulta in qualità di metropolita (“μητροπολίτης”) di Santa Severina (῾Aγίας Σευειρήνης),[lxiii] mentre bisognerà attendere gli ultimi anni del regno normanno, per trovare il primo documento che fa menziona di un arcivescovo di Santa Severina. Si tratta della famosa “bolla di Lucio III” (1183), che proviene dalla Curia romana ed è un falso.[lxiv]
A conferma di questa antica tradizione, da cui dovevano discendere diritti antichi e molto importanti, anche durante la prima metà del sec. XIII, troviamo coesistere l’uso dell’antico titolo di metropolita, con quello più recente di arcivescovo, come dimostra un atto datato giugno 1202 riguardante Bartolomeo, che compare con il titolo di “arcivescovo metropolita” (ἀρχιεπίσκoπoς μητροπολίτης) di Santa Severina (῾Aγίας Σηβερίνης), nelle vicende del monastero di S.to Stefano de Vergari che, pur essendo posto in territorio di Mesoraca, risultava pertinente alla metropolia (μητροπόλεως).[lxv] Stessa circostanza che rileviamo nel caso di Dionisio, il quale risulta “metropolitanus eorum, videlicet archiepiscopus S. Severinae” (1211),[lxvi] e ricorre successiavamente, durante il periodo 1219-1233, indifferentemente, con l’uno o l’altro titolo.[lxvii]
Un “campo di ruine”
L’epigrafe che c’informa circa l’anno di costruzione della cattedrale, ci fornisce anche un secondo elemento molto importante, riguardante la storia del luogo dove fu eretto l’edificio principale di Santa Severina che ne qualificava l’assetto cittadino, considerato che, dopo il suo distacco, sul “fronte interno” di questo blocco di calcare, prima celato, fu scoperto “un grande titolo romano” attestante il suo riuso.[lxviii]
L·MARIVS·L·F·L·LVRIVS·L·F·DVIR[i]
MVRVM · FORNICEM · AREA[m]
[fe]CERVNT.[lxix]
Questa epigrafe latina, secondo l’Orsi risalente “ai primissimi tempi dell’impero od alla fine della repubblica”, riferendo della “costruzione di un edificio pubblico della città”[lxx] da parte dei duoviri, ci testimonia l’esistenza di una municipalità documentata dalla presenza di questa magistratura locale.
Relativamente alla localizzazione di questo centro urbano dell’epoca romana, a cui risultava evidentemente legata la provenienza del blocco calcareo di “pietra tenera”, riutilizzato al tempo della costruzione della cattedrale, l’Orsi considerava che questo dovesse necessariamente provenire “dalla città stessa”, in quanto non sarebbe risultato logico il riutilizzo di un materiale di così poco valore trasportato da lontano quando, invece, questo era diffusamente disponibile in loco.
Una considerazione che si legava alla convinzione maturata dall’archeologo, circa l’esistenza di “un campo di ruine che io ritengo vicinissimo se non dentro la città stessa”,[lxxi] come dimostravano chiaramente le colonne di granito e di porfido, assieme agli altri marmi di riutilizzo esistenti in tutta quest’area che, alla fine dell’Ottocento, come riferisce anche Edouard Jordan,[lxxii] si rinvenivano davanti alla cattedrale, sulla soglia del portone dell’episcopio e, soprattutto, dento la chiesa di San Giovanni Battista.[lxxiii]

L’epigrafe romana di Santa Severina conservata nel locale Museo Diocesano di Arte Sacra
A riguardo dell’identificazione di questo centro urbano d’età romana, preesistente a quello altomedievale di Santa Severina, l’Itinerarium Provinciarum Antonini Augusti (sec. III-IV d.C.), lungo il tragitto tra Capua e Reggio (“ab Equo tutico per Roscianum Regio”), tra Paterno e Tacina, menziona l’esistenza della statio di Neto (“Meto”)[lxxiv] che, analogamente a Paterno, scomparve durante il periodo altomedievale.[lxxv]
Agli inizi del Seicento, il Marafioti menzionava l’esistenza di un antico “castello dal nome del fiume chiamato Neto”, dove si trovavano le antiche saline (“Rocche di sale in Neto”), affermando, in maniera del tutto anacronistica, che nel suo “territorio”, erano posti i casali di San Mauro, San Giovanni Monaco e Scandale[lxxvi] che, al tempo, appartenevano invece, a quello della città di Santa Severina.

In evidenza l’abitato di “Neeto” nelle vicinanze del fiume omonimo e della città di “S. Severina”, raffigurato in un affresco cinquecentesco della Galleria delle carte geografiche ai Musei Vaticani.
Lo spataro candidato Staurace
Anche l’ultima epigrafe bizantina appartenente al gruppo conservato presso il locale Museo Diocesano di Arte Sacra, ci fornisce elementi utili a definire il contesto in cui fu costruita la cattedrale di Santa Severina. Si tratta di un “masso rettangolare di metri 0,65 x 0,52 x 0,23 profondamente scritto nella fronte con undici righi, otto dei quali incorniciati da un cordone,” che evidenzia i “medesimi caratteri” di scrittura dell’iscrizione precedente,[lxxvii] di cui l’archeologo di Rovereto ci fornisce questa trascrizione:
+ K(ύϱιε) ὁ Θ(εός). Tῆς ἁγίας ἀχϱά-
ντoυ Θεoτόϰoυ. τoῦ
ἁγίoυ ἐνδ(όξoυ) ἀπoστόλoυ
Ἀνδϱέoυ. τῆς ἁγίας μάϱ-
τυϱoς τoῦ X(ϱιστo)ῦ Σευιϱη-
νη(ς). Θ(εός) μνίσδιτι τoῦ ϑoύ-
λoυ σoυ Σταυϱαϰίoυ βα-
σιληϰoῦ σπαϑάϱoυ ϰαν-
(διδά)τoυ ϰ……
ἐντάδε τῇ ἁγίᾳ
τoῦ Θ(εo)ῦ ἐϰϰλησίᾳ.[lxxviii]
La più recente edizione dal Guillou (1999), ci fornisce anche questa traduzione:
+ K(ύϱι)ε ὁ Θ(εo)ς ἠμῶν, τῇ πϱεσβία τῆς ἁγίας ἀχρά-
ντoυ Θεoτόκoυ τoῦ
ἁγίoυ ἐνδ(όξoυ) ἀπoστόλoυ
Ἀνδϱέoυ (καὶ) τῆς ἁγίας μάρ-
τυρoς τoῦ X(ϱιστo)ῦ Σευιρή-
νης μνίσδιτι τoῦ δoύ-
λoυ σoυ Σταυραϰίoυ βα-
σιληκoῦ σπαθάρoκανδ(ι)δ(ά)-
τoυ κ(αὶ) συνδρ[o]μειτ(oῦ)
ἐν τάύτη τῇ ἁγία
τoῦ Θ(εo)ῦ ἐϰϰλησία +
“Iddio, nostro Signore, per l’intercessione della immacolata Theotokos del santo e celebrato apostolo Andrea, e di Severina, santa martire di Cristo, ricordati del tuo servo Stauracio, spataro candidato imperiale, che ha contribuito al finanziamento di questa santa chiesa di Dio.”
Rispetto alle testimonianze precedenti, che ricordano il vescovo Ambrogio, in questo caso, la stessa invocazione alla Madre di Dio (Θεoτόκoυ), all’apostolo Andrea e alla martire Severina, ricorre in favore di Stauracio, spataro e candidato imperiale, ricordato per aver contribuito alla costruzione dell’opera.
Il contributo da parte di questo ufficiale imperiale, ci permette di poter ricondurre i fatti ad un periodo certamente precedente alla conquista dei luoghi da parte dei Normanni (metà del sec. XI), come del resto testimonia la formula dell’invocazione rituale alla Vergine Madre di Dio, protettrice dell’Umanità, all’apostolo Andrea, protettore di Costantinopoli, ed alla patrona cui era affidata la protezione della città: la santa martire Severina.

Santa Severina. L’epigrafe bizantina che ricorda Stauracio, spataro e candidato imperiale conservata nel locale Museo Diocesano di Arte Sacra.
All’epoca del feudo
Dopo la conquista da parte dei Normanni e l’introduzione del feudalesimo, tagliati ormai definitivamente i secolari legami con l’impero costantinopolitano, le strutture dell’antica chiesa greca calabrese si adeguarono al sistema introdotto dai nuovi padroni, riproducendo una piaramide feudale, parallela ma autonoma, rispetto all’omologa organizzazione civile del nuovo regno che si stava formando.
Anche se non possediamo documenti relativi all’organizzazione del vescovato di Santa Severina durante questo periodo, ce ne rende qualche testimonianza un “Brébion” dell’altra metropolia bizantina esistente a quel tempo in “Calabria”, quella di Reggio che, “vers 1050”, risultava ancora organizzata sulla base del possesso di diritti e di tenimenti posti anche oltre quello che sarà il confine del suo territorio diocesano.[lxxix]
La formazione di questi territori e l’affermazione del potere vescovile su di essi, sarà un processo ancora lungo e contrastato, non deve quindi creare troppa meraviglia che, di questa antica fase caratterizzata dal tramonto del vecchio e dal sorgere del nuovo, ci siano rimaste pochissime tracce per lo più inquinate da evidenti falsificazioni, che possiamo considerare come i maldestri tentativi di conciliare la realtà precedente con il nuovo assetto ancora in divenire, come documentano – un caso per tutte – le tormentate vicende relative alla formazione della diocesi di Catanzaro.
Per quanto ci riguarda più da vicino, ne rappresenta esempio la questione dei quattro vescovi suffraganei della metropolia di Santa Severina durante il periodo altomedievale che, successivamente, per un certo tempo risultano invece cinque, a cui si vollero aggiungere anche alcuni vescovati chimerici, come quello “Sitomensis”, ricordato ancora al tempo dell’arcivescovo Carlo Berlingieri (1679-1719)[lxxx] e del suo successore Nicolò Pisanelli (1719-1731),[lxxxi] o come l’altro “Lissitanum”,[lxxxii] maldestramente riportato nella bolla di Lucio III (“Lesimanensem”) dove, come nel provinciale Vetus di Albino,[lxxxiii] non risulta tra i suffraganei dell’arcivescovo di Santa Severina il vescovo di Isola ma quello di Crotone,[lxxxiv] mentre, tra i testi che sottoscrissero un atto giudicato non anteriore al giugno 1207, compare il “p(resbite)r Nicolaus Lisitanie Eclesie canonico” (!).[lxxxv]
La chiesa di “S. Anastasiae”
Costituiscono uno spartiacque con la realtà altomedievale della chiesa bizantina di Santa Severina, le prime notizie che c’informano circa la titolarità della cattedrale da parte di Santa Anastasia Romana,[lxxxvi] che ci segnalano così l’apparire della nuova realtà feudale, fondata attraverso la consacrazione delle reliquie della santa da parte dei nuovi signori che, essendo riusciti ad impadronirsi delle terre precedentemente appartenute ai Bizantini, riuscirono ad importarvi la nuova suddivisione per territori imponendo il vassallaggio.
Una organizzazione che, quantunque portatrice della modernità, per lungo tempo a venire, dovrà tenere conto e scendere a patti con i diritti consolidati localmente da quanti vi avevano praticato un uso plurisecolare.
I documenti relativi agli inizi del dominio svevo, infatti, evidenziano che ancora dopo l’istituzione del giustizierato di Terra Giordana, il territorio Crotonese e quelli vicini, pur ricadendo nell’ambito di tale ripartizione, continuarono ad essere identificati in “Calabria” fino agli inizi del periodo angioino,[lxxxvii] come risaliva già alla fine del sec. IX – inizi del sec. X. Ciò in relazione alla loro antica identità etnica e religiosa che, pur avviata a disgregarsi ed a omologarsi a quella latina, persisterà ben oltre il periodo della dominazione sveva.
Agli inizi del Duecento, infatti, la lingua ed il rito greco nel Crotonese, anche se minacciati dalle nuove istituzioni politico-religiose, mantenevano ancora la loro forza, rappresentando i tratti caratteristici di una particolare identità e di una specifica appartenenza, dalla quale discendevano usi propri e specifici diritti della popolazione. In particolare quelli che riguardavano il governo locale.
Come leggiamo nella decretale di Innocenzo III del 6 febbraio 1198, nella quale è riferito che i canonici componenti il capitolo della cattedrale di Santa Severina, parlavano ed officiavano in greco: “Cum igitur in ecclesia vestra, quae sub obedientia sedis apostolice perseverans, Graecorum hactenus et ritum servavit et linguam”, mantenendo i loro antichi diritti, tra cui quello che consentiva loro di eleggere il proprio arcivescovo. Identità e prerogative però, che cominciavano ad essere contrastate.
Proprio in questa occasione, infatti, il capitolo si era rivolto al papa chiedendone l’intervento, al fine di rimuovere un arcivescovo imposto “per laicalem potentiam” dallo scomunicato senescalco imperiale Marcovaldo che, agendo senza l’autorità e l’elezione da parte dei canonici, aveva insediato sulla cattedra di Santa Severina, un pastore latino definito “barbarus” e “intrusus”.
Accogliendo le richieste del “Capitulo Sanctae Anastasiae, il papa concedeva ai canonici la libertà di eleggere l’arcivescovo, secondo gli statuti e l’antica consuetudine della chiesa di Santa Severina[lxxxviii] e qualche giorno dopo (9 febbraio 1198), dava mandato agli arcivescovi di Capua, Reggio e Palermo, di rimuovere l’“intrusus barbarus ab ecclesia S. Anastasiae”, in maniera tale che il capitolo potesse celebrare liberamente l’elezione,[lxxxix] scrivendo anche alla regina Costanza d’Altavilla, “ex parte capituli S. Anastasiae”, affinché non frapponesse ostacoli all’elezione del nuovo pastore.[xc]
A quel tempo, i canonici di Santa Severina che, al pari degli altri ecclesiastici della città, non osservavano il vincolo del celibato,[xci] non facevano vita in comune, ma continuavano a seguire il costume orientale ed a vivere separati ognuno con la propria famiglia. In relazione alla loro importanza, essi possedevano la prerogativa riservata solo a vescovi ed abati, di portare la mitra,[xcii] ed in quanto membri del governo della diocesi, intervenivano nelle decisioni più importanti assunte dall’arcivescovo, perchè questi poteva agire e prendere le decisioni, solo “cum consensu et voluntate capituli”, come testimoniano alcuni atti riguardanti l’abbazia di Sant’Angelo de Frigillo.[xciii]
La presenza del rito greco a Santa Severina è ancora testimoniato nella prima metà del Trecento sia nella città che nei suoi casali e nella limitrofa San Leone,[xciv] mentre, ancora in età moderna, rifacendosi ai loro diritti che discendevano dagli antichi usi, gli arcivescovi di Santa Severina conservavano il diritto si spoglio nei confronti dei propri suffraganei.[xcv]
Tra i loro antichi diritti, spesso aspramente contrastati che, per lo più, noi conosciamo perché richiamati in età moderna, o attraverso qualche antico privilegio, troviamo quello che gli consentiva d’incamerare la quarta parte dei beni mobili di quanti morivano “ab intestato” in tutta la diocesi, ed anche dai diocesani che morivano fuori di essa. L’arcivescovo di Santa Severina, inoltre, indossava il pallio ed esigeva la decima di ogni animale appartenente a diocesani o a forestieri, pascolante nell’ambito della sua diocesi,[xcvi] anche se sappiamo che l’esercizio di questo diritto fu al centro di aspre liti giudiziarie in età moderna. Oltre quello concesso a Meleto (1183), infatti, il privilegio più antico che attesta il diritto dell’arcivescovo di Santa Severina di esigere le decime (sono menzionate quelle sulla bagliva della città e sulla salina di Neto), risale al 10 Giugno 1308, dove sono richiamati due altri privilegi precedenti concessi a tale riguardo dal re Carlo I d’Angiò, il primo dato in Brindisi il 2 marzo 1275, III indizione, e l’altro dato in Roma il 24 maggio 1278, VI indizione.[xcvii]

Santa Anastasia raffigurata in una miniatura medievale (da Wikipedia).
Una festa mobile
Secondo la tradizione locale raccolta dall’arcivescovo Carlo Berlingieri alla fine del Seicento, la chiesa di Santa Severina risultava insignita del titolo (“honore”) “Metropolitico” già prima dell’anno 1099,[xcviii] periodo in cui, secondo la tradizione locale, sarebbero giunte nella città le reliquie di Santa Anastasia ad opera del “glorioso Duca Roberto Guiscardo” che, verso la fine del secolo XI, avrebbe ottenuto “dai cittadini di Zara in Dalmazia la preziosa reliquia del braccio destro di S. Anastasia Vergine e Martire: dove con special pompa e singolar divozione veneravasi l’intero corpo della Santa Martire.”[xcix]
Sempre secondo questa fonte, dopo la conquista della città da parte di Roberto il Guiscardo e di suo fratello Ruggero, riferibile agli anni 1073/74,[c] su disposizione del papa Gregorio VII, le reliquie della santa sarebbero state consegnate all’arcivescovo di Santa Severina Stefano il 29 ottobre 1083,[ci] giorno dedicato a Santa Anastasia “la Romana”, detta anche “Maggiore” e “Osiomartire”, ossia monaca martire.
Tale ricorrenza risulta anche quella anticamente osservata a Santa Severina dove, accanto alla festa della santa che cadeva nel tale giorno, “nella terza domenica de maggio”, invece, si celebrava quella della Consacrazione della cattedrale a lei dedicata.[cii]
Come ricorda la concessione di Ferdinando il Cattolico (1507), questa festa mobile in cui ricorreva la Dedicazione della chiesa metropolitana di Santa Severina, cadeva in “die Dominica infra octavam Ascensionis”,[ciii] giorno in cui si teneva il “sinodo” di Santa Anastasia, quando tutti coloro che possedevano benefici nell’ambito territoriale dell’arcidiocesi, erano tenuti a comparire personalmente in cattedrale, davanti alla cattedra arcivescovile, manifestando la loro obbedienza pagando il “catthedraticum”.
Questa festività della santa titolare della cattedrale, ovvero della chiesa madre (“matris Eclesie”) di Santa Severina, il cui carattere mobile implica sicuramente un riferimento a tempi molto remoti, risulta richiamata già in un atto del giugno 1219 conservato in una copia del secolo XIV, attraverso cui l’arcivescovo Dionisio, concesse all’abbazia di Sant’Angelo de Frigillo, la chiesa di San Giovanni de Monticello posta in territorio di Policastro, fatto salvo il diritto dovuto alla “matris Eclesie, silicet scefato uno annuat(im) persolvendo in festivitat(e) sancte Anastascie.”[civ]

Santa Anastasia Romana. L’ultima foto riproduce la santa alla base di un ostensorio (1821) conservato al Museo Diocesano di Arte Sacra di Santa Severina.
La patrona della città
Riconosciuta in qualità di nume “Tutelare e Padrona della Città”, che troviamo succedere all’altra santa martire Severina,[cv] la santa martire Anastasia, “Titularis, et Tutelaris” della cattedrale di Santa Severina,[cvi] nonché di due dignità del capitolo (Cantorato e Arcipresbiterato), riassume in sé, adeguandoli al suo tempo, i significati appartenuti alle divinità femminili che l’avevano preceduta, tutte espressioni primordiali della potenza rigeneratrice della natura, che rendono conto delle diverse fasi attraverso cui si realizzò la strutturazione del territorio in epoca storica.[cvii]
Ne abbiamo testimonianza fin dall’evo antico quando, secondo il mito, i Crotoniati, reduci dalla guerra di Troia, al termine del loro viaggio, sarebbero giunti erranti nella “regione” posseduta da “una Amazone”, rappresentata dalle “inaccessibili alture della Sila” dove, dopo molti sforzi, sarebbero infine riusciti a distruggere “la città dell’Amazone”, uccidendo “la regina che porta il nome del suo paese”.[cviii]
In relazione all’importanza di questo racconto che fissa nel mito un atto fondativo,[cix] questa divinità femminile, in qualità di personaggio eponimo, è ricordata da Stefano Bizantino agli inizi dell’età altomedievale (sec. V-VI d.C.) il quale, citando Arriano, riferisce che “Abrettenia”, territorio di Misia, era così chiamato dalla “ninfa Brettia” (Ἀβρεττηνή, χώρα Mυσίας, ἀπὸ Bρεττίας νύμφης),[cx] mentre Iordanes, ripercorrendo i fatti accaduti in Italia al tempo di Alarico, evidenzierà che i “Brittios”, ovvero la regione dei “Bryttiorum”, aveva tratto questo nome da quello della regina “Bryttia”[cxi] come, del resto, riferirà successivamente, anche Paolo Diacono (sec. VIII d.C.), facendone risalire l’origine a quello della “reginae quondam suae nomine appellata”.[cxii]
Con l’erezione della metropolia, tali significati saranno ereditati da Santa Severina (fine del sec. IX – inizi del sec. X), la cui figura trova un corrispettivo in quella di Santa Dominica/Santa Cyriaca, patrona di Tropea, in quanto entrambe testimonianze di una religiosità che può essere riferita ancora al Cristianesimo latino, mentre, in questa fase, analogamente a ciò che succede a Santa Severina, Santa Cyriaca/Gerace contraddistingue il passaggio dalla Locri romana al nuovo vescovato greco.[cxiii]
Con la testa coronata, Santa Severina compare sul sigillo dell’università ancora in età moderna. In questa rappresentazione, di difficile interpretazione, che rimonta all’antichità, i tratti caratteristici della “SANTA” non possono trovare riscontro con altre rappresentazioni moderne, perché la canonizzazione delle loro figure è stata sicuramente successiva. Le analogie vanno quindi ricercate nelle realtà cittadine più prossime a Santa Severina, ed in relazione ai miti fondativi che rendono conto della formazione del territorio e della sua particolare identità.
In questa direzione possiamo osservare che, i toponimi delle quattro diocesi suffraganee della nuova metropolia, dimostrano di essere tutti correlati alle caratteristiche dei luoghi in cui sorsero questi insediamenti, mentre i santi titolari delle loro chiese, prescelti come protettori delle comunità, ad esclusione di Isola, dove ciò che sappiamo in merito alla cattedrale dedicata all’Assunta, emerge solo in una fase in cui il suo territorio si mostra già compenetrato con quello di Crotone, dimostrano tutti uno spiccato carattere militare.
Si tratta delle figure tradizionali della cultura guerriera cara al modo greco-bizantino, come San Michele Arcangelo a Belcastro, San Teodoro a Cerenzìa e San Donato a Umbriatico, che esprimono la volontà delle nuove comunità di confidare nella loro protezione/difesa. Una circostanza evidentemente legata al particolare momento storico in cui queste comunità sorsero, caratterizzato dalla lotta per la riconquista del territorio, condotta dai Bizantini nei confronti dei Saraceni e dei Longobardi sul finire del sec. IX.

Da sinistra verso destra: San Teodoro, San Donato e San Michele Arcangelo.
Anche la figura di Santa Severina, quindi, deve esprimere tali significati che, in considerazione della qualità agiografica del toponimo che identifica la città, non possiamo non riconoscere in quelli di una divinità appartenente alla tradizione locale.
La figura di Santa Severina sul sigillo della sua città, dove compare coronata e nuda in quanto erede dell’antica sovrana dello spazio selvaggio (le vesti nel disegno pubblicato dall’Ughelli e nell’attuale gonfalone del Comune devono essere considerate una pudica aggiunta), mentre estrae dal suo petto due spade, rappresenta quindi un richiamo all’antico mito della “regina” guerriera, il personaggio eponimo che manifesta la sua vittoria sulla morte, in ragione delle sue qualità rigeneratrici di divinità madre.

Il sigillo dell’università di Santa Severina pubblicato dall’Ughelli nel volume IX (1721) della sua “Italia Sacra” (1), riprodotto negli atti del catasto onciario cittadino del 1785 (2), su alcuni documenti del 1810 (3) e sull’attuale gonfalone comunale (4).
Questi significati mantenuti in età medievale, perché, in questo periodo, il territorio a cui sono correlati, mantenne inalterata la sua antica economia e la sua identità selvaggia legata alla “Montagna”, saranno evidenziati anche da Santa Anastasia il cui nome significa “resurrezione”.
Anche nel suo caso, infatti, le raffigurazioni della santa conservate a Santa Severina, oltre a evidenziare i suoi attributi tipici, la mostrano tenere nelle mani la città che, in ragione del suo ruolo di patrona, risulta posta sotto la protezione del suo braccio, come ricorda l’iscrizione posta sul portale principale della cattedrale: “BRACHIO SANCTO SUO DEFENDET. SAP.S”.
Ne costituisce esempio il sigillo ovale del Capitolo, dove Santa Anastasia, vestita con la tonaca monacale, appare in piedi martire sul rogo, mentre tiene nella mano destra un ramo di palma, emblema della vittoria del martirio sulla morte, e sorregge con la mano sinistra il vangelo, su cui poggia un simulacro della città di Santa Severina.
Tale simulacro che appare del tutto anonimo in alcune rappresentazioni abbastanza tarde, in questo caso, invece, evidenzia una chiara caratterizzazione, che trova confronti con i “tria castella” menzionati dal Malaterra al tempo della conquista della città da parte del duca Roberto e del conte Ruggero,[cxiv] in riferimento all’antico mito che racconta la nascita del territorio dei Brettii tramandato dalle fonti classiche.[cxv] Essa, infatti, risulta la patrona principale dell’arcidiocesi,[cxvi] ricevendo la devozione “de populi convicini”,[cxvii] e la sua protezione si estende “per totam Provinciam Metropoliticam”.[cxviii]

Sigillo del Capitolo di Santa Severina.
Rispetto a questa rappresentazione, dove non risulta coronata, ma compare con l’aureola che ne esprime genericamente la santità, tutte le raffigurazioni più tarde della santa conservate a Santa Severina, la ritraggono invece con la corona che, non risultando mai tra i suoi attributi, possiamo riferire soltanto ad un fatto locale, forse relativo al periodo in cui sul vescovato fu esteso il regio patronato.[cxix]

Raffigurazioni più recenti di Santa Anastasia conservate a Santa Severina: dipinto su tavola (1790), statua di argento fatta realizzare dopo il terremoto del 1783 dall’arcivescovo Antonino Ganini (1763-1795), particolare di un ostensorio (1821), statua recente in cartapesta. Museo Diocesano di Arte Sacra di Santa Severina (KR).
La cappella di Santa Anastasia (sec. XVI-XVIII)
Sembrano confermare questa tesi alcune rappresentazioni più antiche di Santa Anastasia ancora conservate a Santa Severina, costituite da un quadro attribuito al pittore Fabrizio Santafede (Napoli nel 1560 circa. – morto dopo il 1628), che doveva trovarsi nell’antica cappella della santa posta in cattedrale, e da un bassorilievo proveniente, probabilmente, dalla stessa cappella, poi spostato, assieme ad altri, nella “Cappella del Crocifisso”, forse al tempo dei lavori fatti realizzare dal Pujia nei primi anni del Novecento,[cxx] quindi sistemato all’interno del “battistero” nel 1955[cxxi] ed, infine, recentemente smontato e depositato nei locali di una ex scuola.[cxxii]

Cattedrale di Santa Severina (KR). Bassorilievo raffigurante Sant’Anastasia (Orsi P., 1929) e quadro che ritrae la santa attribuito a Fabrizio Santafede.
Di questa antica cappella dove si raccoglievano numerosi “vota Cerea”, offerti quotidianamente dai fedeli alla santa vergine Anastasia, consistenti in “votis” ed in alcuni “toreis”, abbiamo notizia già alla metà del Cinquecento, quando sappiamo che al suo interno, protetto da una vecchia cancellata lignea, c’era l’altare ad essa consacrato.
Alla metà del Cinquecento, un’altra importante ed antica rappresentazione della santa, oggi ormai perduta, esisteva sopra l’altare maggiore, dove si trovava la “Cona magna” con le immagini dipinte della Gloriosa Vergine Maria e della Gloriosa Vergine Anastasia, insieme ad altre tre vergini ed ai quattro dottori della Chiesa, con in mezzo l’immagine del Salvatore in croce pendente. L’icona che “in calce” raffigurava anche i dodici apostoli, risultava provvista di una tela azzurra, era dorata, antica, molto bella e ben conservata.[cxxiii]
Nella sacrestia “magna” era conservato, invece, il braccio di Santa Anastasia “con la carne, nerve, pelle, et piccoli peli”,[cxxiv] che rappresentava la principale reliquia esistente nella cattedrale.[cxxv] Alla metà del Cinquecento, questa si trovava riposta in una grande cassa di noce con serratura e chiave che custodiva il tesoriere, all’interno della quale si trovava una “cassula” coperta di seta verde, dentro la quale era custodito il braccio della Gloriosissima Vergine e Martire Santa Anastasia diligentemente tenuto, ben conservato e ricoperto di argento che, attraverso una “fissuram argentatam” lasciava vedere le ossa e la carne che costituivano la reliquia.[cxxvi]

La reliquia del braccio di Santa Anastasia con l’arme dell’arcivescovo Niccolò Carminio Falcone (1743-1759), conservata nel Museo Diocesano di Arte Sacra di Santa Severina.
La teca d’argento contenente la reliquia della santa, fu fatta dorare dall’arcivescovo Giulio Antonio Santoro (1566-1573), quando ancora risultava conservata in un “reliquiario” riposto in una delle due sacrestie,[cxxvii] come risulta anche al tempo di Alfonso Pisani (1587-1623).[cxxviii]
Il suo successore Fausto Caffarelli (1624-1651), invece, rese perfette le fabbriche della sua cappella,[cxxix] vi ripose la reliquia e la dotò di una lampada mantenuta sempre accesa a sue spese.[cxxx]
Al tempo di Francesco Falabella (1660-1670), la cappella di Sant’Anastasia, posta sul lato sinistro dell’altare maggiore, era una delle quattro cappelle della cattedrale,[cxxxi] in cui si conservava la sua effige e la sua insigne reliquia costituita dal suo braccio,[cxxxii] come risulta anche al tempo di Carlo Berlingieri (1679-1719),[cxxxiii] quando fu ornata con croci d’argento, candelabri, vasi, ecc.[cxxxiv]
Durante l’arcivescovato di Nicolò Pisanelli (1719-1731), agli inizi di giugno del 1726, la cappella di S. Anastasia[cxxxv] fu danneggiata da un temporale, quando il quadro della titolare sarebbe stato visto miracolosamente trasformarsi,[cxxxvi] mentre ancora al tempo di Niccolò Carminio Falcone (1743-1759), a sinistra dell’altare maggiore, esisteva la cappella di Santa Anastasia che era la seconda “in Cornu Epistolae”, e in un “Armario lapideo” posto sopra il suo altare, si conservava il braccio della santa nella sua teca, assieme ad altre reliquie.[cxxxvii]
Note
[i] “MH. Tῇ Ἁγίᾳ Σευηρινῇ τῆς Kαλαβρίας. ὁ Eὐρυάτων, ὁ ’Aϰερεντίας, ὁ Kαλλιπόλεως, [ὁ] τῶν ’Aησύλων.”. Gelzer H., Georgii Cypri Descriptio Orbis Romani, Lipsia 1890, p. 82.
[ii] Amari M., Storia dei Musulmani di Sicilia, I, Firenze 1854, pp. 253-275.
[iii] “I musulmani di Sicilia e di Africa si mostrano a un tempo nel Ionio e nel Tirreno. Occupano S. Severina e Amantea; presidiano Taranto; afforzansi al capo Licosa e si fan padroni di Ponza.”. Moscato G.B., Cronaca dei Musulmani in Calabria, 1902 rist. 1963, p. 15.
[iv] “Stefano fallisce un colpo sopra Amantea, tenuta dai musulmani; e Basilio manda in sua vece Niceforo Foca, creato stratego di Calabria; il quale ultima il riacquisto, prendendo Amantea e Santa Severina.” Moscato G.B., Cronaca dei Musulmani in Calabria, 1902, rist. 1963 p. 21.
[v] Theophanes Continuatus, V, 71, in Migne J. P., Patrologia greca, CIX, coll. 327-330.
[vi] “Calabriam, qua residebat Graecorum exercitus super Saracenos in Sancta Severina commorantes, properarunt; ubi et omnes Graiorum gladiis extincti sunt. Dehinc Amanteum castrum captum est; deinde et dictae Beatae Severinae oppidum apprehensum est.” Erchemperti, Historia Langobardorum Beneventanorum, in Waitz G., Monumenta Germaniae historica, Scriptores/3, Hannoverae 1878, p. 256.
[vii] “Anno 272” (18 giugno 885-7 giugno 886). “Spirata quest’anno la tregua che Sawâdah, emir di Sicilia, avea stipulato coi Rûm, ei mandò le gualdane nei paesi che i Rûm teneano ancora nell’isola; le quali predarono e ritornarono. Questo medesimo anno venne di Costantinopoli, con grande esercito, un patrizio per nome Niceforo; il quale posto il campo sotto Santa Severina assediolla e strinse i Musulmani che la tenenano; tanto ch’essi resero la città a patti, e se ne andarono in Sicilia. Quindi Niceforo mandò un esercito alla città di Amantea, la quale fu assediata e costretto il presidio a renderla a patto e (tornarsene) a Palermo in Sicilia.”. Amari M., Biblioteca Arabo-Sicula volume primo 1880, pp. 399-400.
“L’anno 272 Sawâdah, principe di Sicilia, mandò le gualdane nei paesi dei Rûm; le quali ritornarono con preda. Lo stesso anno seguirono parecchi scontri tra i Musulmani ed un patrizio per nome Niceforo. Venuto di Costantinopoli con un grande esercito, questi entrò nella città di (Santa) Severina; dalla quale il presidio musulmano uscì per accordo e [ritornò] in Sicilia.”. Amari M., Biblioteca Arabo-Sicula volume secondo 1881, pp. 17-18.
[viii] Costantino Porfirogenito, De thematibus, 10. Ed. Immanuel Bekker, Bonnae 1840, pp. 58-60.
[ix] Guillou A., Le iscrizioni bizantine di Santa Severina, in Quaderni Siberenensi, giugno 1999, pp. 37-45.
[x] “Sedes in ea Episcopalis antiquissima, ut Epistolae Innocentii III., vetustaeque inscriptiones indicant;”. ASV, Rel. Lim. Santa Severina 1685, f. 326.
[xi] “Plures aliae Graecae inscriptiones tum in Cathedrali, tum in aliis ejusdem civitatis Ecclesiis sunt, et Episcoporum Graecorum inscriptiones quae vetustate pene deletae vix videri, non tamen legi possunt.” Ughelli F., Italia Sacra, IX, Venezia 1721, c. 475.
[xii] Scalise G. B. (a cura di), Siberene Cronaca del Passato per le Diocesi di Santaseverina – Crotone – Cariati, Prefazione p. VII.
[xiii] Capialbi V., Opuscoli Varii del dottor Vito Capialbi, Tomo III. Epistole, Riviste, Illustrazioni e Descrizioni, Napoli 1849, p. 81. Scalise G. B. (a cura di), Siberene Cronaca del Passato per le Diocesi di Santaseverina – Crotone – Cariati, Una lettera del Conte Vito Capialbi, pp. 231-232.
[xiv] “Codesto arcivescovo Giovanni ci è noto esclusivamente per questo titolo; che egli s’abbia ad identificare con un suo omonimo, intervenuto nel 1129 alla coronazione di re Ruggero in Palermo (Taccone Gallucci, Regesti, pag. 425) non credo assolutamente, essendo il Battistero opera senza dubbio prenormanna. Si pensò da taluno che a lui debbasi la creazione del monumento, la cui data sta nascosta nell’indizione XIII, dalla quale però non è possibile ricavare l’anno esatto.” Orsi P., Siberene – S. Severina, in Le Chiese Basiliane della Calabria, Firenze 1929 p. 208. “Che esso sia prenormanno e dovuto ai Bizantini, pare l’opinione più attendibile.” Orsi P., Siberene – S. Severina, in Le Chiese Basiliane della Calabria, Firenze 1929 p. 212.
[xv] Guillou A., Le iscrizioni bizantine di Santa Severina, in Quaderni Siberenensi, giugno 1999, pp. 37-39.
[xvi] Rende P. La chiesa medievale di Santa Severina intitolata a San Giovanni Battista, www.archiviostoricocrotone.it
[xvii] Capialbi V., Opuscoli Varii del dottor Vito Capialbi, Tomo III. Epistole, Riviste, Illustrazioni e Descrizioni, Napoli 1849, pp. 82-83. Scalise G. B. (a cura di), Siberene Cronaca del Passato per le Diocesi di Santaseverina – Crotone – Cariati, A proposito d’iscrizioni greche, p. 240.
[xviii] Capialbi V., Opuscoli Varii del Dottor Vito Capialbi, Tomo I, Napoli 1840. Esposizione di un anello d’argento, e di un bollo di rame. – Al chiarissimo Cav. Roberto Betti Intendente della Prima Calabria Ulteriore, pp. 9-10.
[xix] 10 agosto 1199. Universis archiepiscopis, episcopis, comitibus, baronibus, civitatibus et universo populo in regno Siciliae consistentibus, nuntiat conversionem Marcovaldi, olim infestissimi hostis Constantiae imperatricis et Friderici regis Siciliae. «Item excomunicamus J. quondam electum Sanctae Severinae, qui eidem Marcovaldo adhaerens, administrationem Salernitanae ecclesiae de ipsius manu recepit».” Russo F., Regesto I, 486.
[xx] Escludendo il Giovanni che compare come teste lontano da Santa Severina durante il breve periodo 1263-1264 nei documenti vaticani (13 marzo 1263: “Iohannes, Archiepiscopus S. Severinae” (Russo F., Regesto I, 964). 10 luglio 1263: “Iohannes, Archiepiscopus S. Severinae” (Ibidem, 965). 3 aprile 1264: “Iohannis, Archiepiscopi S. Severinae” (Ibidem, 973). 9 aprile 1264: “Iohanne, archiepiscopo S. Severine” (Ibidem, 974). 17 giugno 1264: “Iohannes, archiepiscopus S. Severinae” (Ibidem, 979)), la notizia più antica che menziona un arcivescovo di Santa Severina con questo nome, risale al febbraio del 1118 nei documenti vaticani (20 febbraio 1118. “Consecrationi Gelasii II papae, Caietae celebratae, intersunt Archiepiscopi Sennes Capuanus, Landulfus Beneventanus … J(ohannes) Sanctae Severinae … et quamplures alii de Apulia et Calabria, cum Guillelmo Troiano et diversarum regionum episcopis. Russo F., Regesto I, 269.), mentre una carta latina locale, sospetta di falso, traduzione di un documento greco deperdito, menziona il “sanctissimus metropolitanus dominus Gregorius” nel novembre di quello stesso anno (Pratesi A., Carte Latine di Abbazie Calabresi provenienti dall’Archivio Aldobrandini, 1958, pp. 27-30). In precedenza, l’arcivescovo greco di Santa Severina, che si ritiene possa essere Costantino (“Constantino” compare nel 1099 (Ughelli F., Italia Sacra tomo IX, Venezia 1721, cc. 476-477), e risulta presente “al concilio di Guastalla (1105) e a quello Romano (1112)”. Le Pera F., Alcune note sulla cronotassi degli Arcivescovi di Santa Severina, in Quaderni Siberenensi giugno 2001, p. 12., che cita Russo F., L’Episcopato calabrese nei Concili, in Almanacco Calabrese, anno XII, n. 12, 1962, p. 78.), risulta menzionato al tempo di Pasquale II (1099-1118), tra coloro che sottoscrissero l’annullamento del privilegio per le investiture, concesso l’anno prima dal papa all’imperatore Enrico V (23 marzo 1112. “Edicto Synodali de «pravilegio» subscribunt, inter alios, Archiepiscopi Sennes Capuan, Landulfus Beneventan, Amalfitan, H. Regitan, Hidrontin, Brundusinus, Compsam (als Consentin), Girontin, et graeci archiepiscopi Rossanen et Sanctae Severinae.” Russo F., Regesto I, 258 e nota n. 86). Secondo il Pirro, che lo scrive nella sua “Sicilia Sacra” (1733), “Joannes Sancta Severina Archiepiscous”, fu tra i presenti alla coronazione di Ruggero II, il giorno di Natale del 1130 (Pirro R., Sicilia Sacra, 1733 tomo I, p. XIV-XV. “Si rilevano con certezza le due coronationi di Rogerio dalla Cronologia degl’Arcivescovi di S. Severina perché ivi si legge: Ioannes Archiepiscopus coronationi Rogeri Siciliae Regis adstitit anno MCXXIX.” AASS, 84A, f. 31v). Tale circostanza è riportata già dal Fiore che, nella sua cronotassi, ripresa dal Taccone-Gallucci (In questo elenco, Giovanni risulta “intervenuto alla incoronazione del Re Ruggiero in Palermo” (1129), preceduto da Costantino, “che fondò il Monastero di Basiliani detto Calabro-Mariano nella sua Provincia Ecclesistica” (1099), da Rosano “nel Concilio Romano del Papa Pasquale II” (1112) e da Silverio, “che assisté alla consecrazione del Papa Gelasio II in Roma (1119), mentre fu seguito da Romano che risulta “in un diploma dell’Archimandritato del Patirio di Rossano” (1132). Taccone-Gallucci D., Regesti dei Romani Pontefici per le Chiese della Calabria, Roma 1902, pag. 425), pone Romano dopo Giovanni (“Costantino è il primo degli arcivescovi di questa metropoli: quello il quale l’anno 1099 presta l’assenso a Policronio, vescovo geruntino, ch’edifichi il monasterio di S. Maria di Altilia. A questi succede Rosano, il quale l’anno 1112 interviene al Concilio di Laterano sotto papa Pascale II; ed a lui Silverio, il quale l’anno 1119 si ritrovò presente alla consagrazione di papa Gelasio I; indi poi abbiamo Giovanni, già presente alla coronazione del re Rogiero fatta in Palermo l’anno 1129. Succede senz’altro Romano, il quale l’anno 1132 soscrive ad una donazione di Mobilia, figliuola del duca Roberto Guiscardo, a beneficio della chiesa e monaci del Patiro.” Fiore G., Della Calabria Illustrata, tomo II, p. 534). Questo successore di Giovanni compare in un privilegio latino tradotto dal greco (Ughelli F., Italia Sacra, t. IX, 481-482), datato “anno Mundi 6636. qui erat Christi 1132” (sic), ed è ricordato a posteriori nel 1183 (AASS, Pergamena 001).
Risultano datate invece nella prima metà del Trecento, le vicende dell’arcivescovo “Iohannes de policastro”, che troviamo relativamente alla reintegrazione del pagamento delle due decime dovute alla Santa Sede per gli anni 1310-1311, “In provincia S. Severine et eiusdem Diocesis”: “Presbiter Iohannes de Pollicastro eo iure tar. VII gr. XV” (Vendola D., Rationes Decimarum Italiae nei sec. XIII e XIV, 1939, p. 203. Russo F., Regesto I, 2356. Scalise G.B. (a cura di), Siberene, Cronaca del Passato per le Diocesi di Santaseverina – Crotone – Cariati, 1999, p. 280). Più tardi, egli fu arcivescovo di Santa Severina, come riporta l’Eubel, il quale annota che fu provvisto il 31 maggio 1320 e che, in precedenza, era stato canonico della stessa chiesa (Eubel C., Hierarchia Catholica Medii Aevi, 1913, vol. I, p. 448). Di lui fanno menzione l’Ughelli (“Joannes electus promisit sacro Collegio solitum charitativum subsidium die 2 Julii anno 1320 cujus meminit et Reg. Vatic. Joanni XXII. epist. 927. anni 4. caetera ignorantur.”. Ughelli, cit. t. VIII, p. 484) ed il Fiore, che a “Paolo, di cui si ha memoria nel Registro di Napoli l’anno 1309”, fa seguire, “ma senza certezza di tempo”, “Giovanni, la cui memoria apparisce l’anno 1320” (Fiore G., cit. II, p. 535). Il 22 giugno 1321, Giovanni de Policastro ricevette il pallio vescovile: “Iohanni (de Policastro), archiepiscopo S. Severinae, assignatur pallium, per archiepiscopatum Rossanen. Tradendum” (Russo F., Regesto I, 2552) ma, come riferisce il Sisca, successivamente, il presule “fu sospeso donec Pontifex melius informetur perché aveva assunto in sede vacante, due anni prima, le funzioni di Arcivescovo di S. Severina” (Sisca D., Petilia Policastro, 1964 rist. 1996, p. 217-218, che cita: Archivio Vaticano 8F. 73 EP. 431). Giovanni compare ancora in qualità di arcivescovo di Santa Severina in occasione del pagamento delle decime dovute alla Santa Sede per l’anno 1326 (“(f. 89) Item in provincia ac civitate et dyocesi S. Severine. Dominus Iohannes archiepiscopus dicte civitatis unc. duas et tar. quindecim.” Vendola D., Rationes Decimarum Italiae nei sec. XIII e XIV, Apulia-Lucania-Calabria, 1939, p. 205), e in un atto dell’abazia di Sant’Angelo de Frigillo del 4 marzo 1330 (“Iohannes (de Policastro) archiepiscopus Sancte Severine”. Pratesi A., cit., p. 452, n. 240, che cita: “cf. Gams, Series episcoporum, p. 922; Eubel, Hierarchia catholica, I, p. 448 donde risulta che fu sospeso da Giovanni XXII il 5 febbraio 1322; Taccone-Gallucci, Regesti dei romani pontefici, p. 425”).
[xxi] “Nell’antica Cattedrale poi di Santa Severina forse diligentemente perquirendo si potrebbe rinvenire qualche altra memoria del medio-evo; giacchè quel mio egregio amico Signor Arcidiacono Deodato Ganini, che riunisce a’ grandi meriti ecclesiastici cortesi maniere, vastità, e profondità di dottrine, mi ha rimesso altre tre iscrizioni greche, sebbene monche, dell’epoca, di cui parliamo. Capialbi V., Opuscoli Varii del Dottor Vito Capialbi, Tomo I, Napoli 1840. Sopra alcuni monumenti del medio-evo esistenti in Calabria. Lettera del Cavaliere Vito Capialbi al Signor Carlo Bonucci, Architetto Direttore degli Scavi di Antichità in Napoli, estratto Dal Faro, Anno IV, Tomo 11, Fasc. N. 11 e 12, Novembre e Dicembre 1836, p. 5.
[xxii] Orsi P., Siberene cit., 1929, p. 203.
[xxiii] “Aggiungasi che anche lo Stato nulla vi ha fatto sin qui; e solo l’arcivescovo mons. Carmelo Pujia ha speso recentemente ingenti somme per i restauri della sua cattedrale, senza concorso tecnico o finanziario degli uffici dei monumenti; …”. Orsi P., Siberene cit., 1929, p. 200.
[xxiv] www.treccani.it/enciclopedia/paolo-orsi_(Dizionario-Biografico)/
[xxv] “Ho passato in due riprese nella primavera del 1911 alcuni giorni a S. Severina …”. Orsi P., Siberene cit., 1929, p. 201. “Quanto espongo è il frutto di due rapide visite fatte a S. Severina nel maggio e giugno del 1911, coadiuvato dai miei bravi collaboratori prof. Sebastiano Agati e Rosario Carta, il quale ultimo vi fece una nuova visita nel novembre per completare i suoi disegni, ed eseguire qualche tasto.” Orsi P., Siberene cit., 1929, pp. 205-206.
[xxvi] Orsi P., Le chiese Basiliane della Calabria, Santa Severina in Bollettino d’arte del Ministero della P. I., VI (1912), pp. 189-239.
[xxvii] “Nessun archeologo, che a me consti, è stato lassù, e nemmeno il Lenormant; e così non fu visitata nè dallo Schultz, nè dal Salazaro, nè dal Bertaux, che pubblicarono opere grandiose sull’arte ed i monumenti del Mezzogiorno.” Orsi P., Siberene cit., 1929, p. 200. In nota afferma poi l’Orsi: “Forse la visitò, ma in ogni caso troppo rapidamente, il DIEHL, che ai suoi monumenti medioevali dedicò brevi ma sensate pagine (L’Art byzantin dans l’Italie méridionale, pag. 199-203). Un rapido sguardo ai monumenti sanseverinati è stato dato anche dal Croce in Napoli Nobilissima 1894, pag. 71-72, riassumendo le opinioni, giuste od errate, dei vari studiosi stranieri.” Orsi P., Siberene cit., 1929, p. 234, nota n. 18.
[xxviii] “Avendo Mons. Carmelo Pujia, con savio provvedimento, fatto distaccare dal muro settentrionale della cattedrale vecchia due epigrafi bizantine che vi stavano «ab immemorabili», e che tanto deperivano da essere prossime alla ruina totale, si accorse che nel fronte interno di una di esse era scolpito un grande titolo romano.” Orsi P., Siberene cit., 1929, p. 204.
[xxix] “Per evitare anche che si possa rompere, l’Arciv. C. Puija pensa portare la campana nella sala dell’Episcopio: ove ha già posto le pietre con le iscrizioni greche e quanto altro ha trovato di antiche memorie.” Puija A., Un Vecchio Equivoco, in Scalise G. B. (a cura di), Siberene Cronaca del Passato per le Diocesi di Santaseverina – Crotone – Cariati, p. 265 nota n. 8.
[xxx] “GNOSEΩGRAFIA, Storica Critica Cronologica della Regia Metropolitana Chiesa di Santa Severina”, AASS 084A.
[xxxi] “E finalm.te avendo perquisito il Volume, dove stà registrata la Cronologia degli Ar(civesco)vi di d.a Città di S. S(everi)na hò ritrovato al num.o 17 la seguente particola = Rogerius de Stephanutia Caroli I., et II. Neapolis Regis Consiliarius, ac familiaris, successit Bernardo, Anno 1274, et a Bonifacio VIII. ad Consentinam Ecclesiam fuit translatus Anno 1295.” AASS, 093A, f. 43v. “Rogerio di Stefanuzia o sia Stevenswort fiamengo, Consigliere del Re Carlo I e Carlo II d’Angiò.” AASS 084A, f. 44v. “Si distinse fra gli altri nella divozione verso detta gloriosa Protettrice Rogerio di Stefanuzia o sia Stevenswort nella Ghalhia oggi Francese eletto Arcivescovo sin dall’anno 1274. Fece egli costruire una nuova Cattedral Basilica a tre navate più estesa e magnifica della prima nel miglior sito della Città volgarmente detto il Campo; in dove trasferì pella publica venerazione l’ansidetta preziosa Reliquia. E lasciando alla Città il nome di S. Severina in memoria della Martire sudetta da più secoli adottato con solenne consagrazione dedicò la nuova Cattedrale sotto la special invocazione di S. Anastasia Vergine e Martire. Allora fu riconosciuta non solo qual Padrona e Tutelare della Città, come l’era stata da ben dugent’anni, ma dell’Arcidiocesi ancora e Provincia Metropolitica.” AASS 084A, f. 49.
[xxxii] “Ma se ignota resta l’epoca precisa della spiritual regenerazione de Seberenati, oscura è ancora quella del material edificio della loro Chiesa. Una lapide sottratta all’ingiurie de tempi serve tutta via di argomento parlante per far conoscere la solenne consagrazione della Chiesa Cattedrale Greca eseguita per mano del Vescovo di nome Ambrosio. Non fu ivi segnata l’Era di tal consagrazione, ma con greci caratteri ben dimostra che fu allor dedicata alla Beatissima Vergine, all’Apostolo S. Andrea ed alla Martire S. Severina (2): ed è questa Chiesa appunto che oggi si ravvisa col titolo Parocchiale sotto l’invocazione di S. Maria Magiore.” AASS, 84A, ff. 48-48v.
[xxxiii] AASS, 084A, ff. 52v-53.
[xxxiv] Orsi P., Siberene cit., 1929, p. 221. “In libera traduzione italiana del Giustiniani, Dizion. Geog. Del Regno di Napoli (1802) S. v. S. Severina; Taccone-Gallucci, Epigrafi cristiane del Bruzio, Calabria (Reggio C., 1905), pag. 50; non è fedele il testo di mons. A. Pujia, Cronotassi, pag. 18.” Orsi P., Siberene cit., 1929, p. 235, nota n. 38.
[xxxv] “Vuole la leggenda, che vescovado e cattedrale sieno stati poi abbandonati alla fine del sec. XIII, causa le micidiali esalazioni che salivano dalla sottostante vallata, e trasportati da Ruggero di Stefanuzia sul colmo del colle, dove trovansi attualmente.” Orsi P., Siberene cit., 1929, p. 215.
[xxxvi] “Una tradizione costante ed antichissima dice, che la cattedrale di S. Severina fosse posta nel sito dove ora sorge la chiesetta dell’Addolorata, sulla punta Nord-Est del colle. E là presso in immediata contiguità si osservano ruderi abbastanza vasti, dalla patina nera di molti secoli, denominati il Vescovato Vecchio.” Orsi P., Siberene cit., 1929, p. 215.
[xxxvii] “A primo occhio le sigle intermedie mi parvero mi parvero significare Andreas, e già me ne andava fantasticando il Santo titolare di codesta Metropoli, menzionato nell’altra iscrizione del Vescovo Ambrogio favoritami;”. Opuscoli Varii del dottor Vito Capialbi, Tomo III. Epistole, Riviste, Illustrazioni e Descrizioni, Napoli 1849, pp. 70-71.
[xxxviii] “E poiché sono a pubblicare iscrizioni bizantine di S. Severina, ne aggiungo qui una che menziona lo stesso vescovo Ambrogio. È una lapide rettangolare in calcare duro, sul cui fronte di cm. 77 x 34 è inciso il titolo, che vedesi nella unita immagine fotografica (fig. 151). Le lettere sono molto affievolite ed in parte quasi cancellate, per il continuo stropicciamento dei piedi; infatti la pietra era stata collocata da ignoranti operai come gradino nel seminario, ma ora fu posta in salvo e murata nell’episcopio. Dove essa fosse collocata in origine non consta, ma con ogni probabilità era nella cattedrale vecchia;”. Orsi P., Siberene cit., 1929, p. 221.
[xxxix] Orsi P., Siberene cit., 1929, p. 203.
[xl] Capialbi V., La continuazione all’Italia Sacra dell’Ughelli per i Vescovadi di Calabria, in Archivio Storico della Calabria II, 1914, p. 183.
[xli] Le Pera F., Da Siberene, città degli Enotri, a Santa Severina dei Bizantini, in Quaderni Siberenensi giugno 1999, p. 52.
[xlii] Guillou A., Le iscrizioni bizantine di Santa Severina, in Quaderni Siberenensi, giugno 1999, pp. 43-44.
[xliii] “Queste tre iscrizioni, e qualche altra, di cui è scomparso l’originale lasciando soltanto il ricordo attraverso pessimi apografi o libere traduzioni italiane, di cui non è lecito fidarsi, appartengono allo stesso ciclo.” Orsi P., Siberene cit., 1929, p. 221.
[xliv] “L’arcivescovo Ambrogio fondatore della chiesa è altrimenti sconosciuto, e se la lezione della data è sicura, esso cade nella prima metà del mille, e deve essere quasi contemporaneo dello spatario Staurace. S’intende che la data è segnata ἀπo ϰτίσεως ϰόσμoυ cioè dal 5509 a. Cr. ed il nostro corrisponderebbe al 6544 ed appunto al 1036 coincide esattamente la quarta indizione.” Orsi P., Siberene cit., 1929, p. 219.
[xlv] “Sono gratissimo all’amico dott. G. Gerola, Soprintendente a Ravenna, per l’aiuto prestatomi nella lettura di questa difficile epigrafe sulla fotografia. Orsi P., Siberene cit., 1929, p. 235, nota n. 34.
[xlvi] Orsi P., Siberene cit., 1929, p. 219.
[xlvii] Le Pera F., Da Siberene, città degli Enotri, a Santa Severina dei Bizantini, in Quaderni Siberenensi giugno 1999, p. 52.
[xlviii] Guillou A., Le iscrizioni bizantine di Santa Severina, in Quaderni Siberenensi, giugno 1999, pp. 42-43. Tale interpretazione della data risulta anche quella del Gasperini, come afferma Francesco Le Pera, Alcune note sulla cronotassi degli Arcivescovi di Santa Severina, in Quaderni Siberenensi, febbraio 2000, p. 34, nota n. 37, che cita: Gasperini L., Vecchie e nuove epigrafi del Bruzio Ionico, Decima Miscellanea greca e romana, Roma 1986, pp. 165 e sgg.
[xlix] Guillou A., Le iscrizioni bizantine di Santa Severina, in Quaderni Siberenensi, giugno 1999, pp. 42-43.
[l] Guillou A., Le Brébion de la Métropole Byzantine de Règion (vers 1050), Biblioteca Apostolica Vaticana, 1974, pp. 76 e 196.
[li] Rende P., La chiesa medievale di Santa Severina intitolata a San Giovanni Battista, www.archiviostoricocrotone.it
[lii] Russo F., La Metropolia di S. Severina, in Scritti Storici Calabresi C.A.M., Napoli 1957, pp. 43-44.
[liii] Russo F., cit., 1957, p. 44. Basilii Notitia, in Gelzer H., Georgii Cypri Descriptio Orbis Romani, Lipsia 1890, p. 27.
[liv] “… la metropolia di Reggio, alla quale furono sottomesse tutte le diocesi della Calabria, e cioè Gerace (Locri o S. Ciriaca), Squillace, Crotone, Cosenza, Vibona, Tropea, Nicotera, Tauriano, Tempsa e Turio. Le ultime due esistevano solo nominalmente.” Russo F., cit., 1957, p. 44.
[lv] Gelzer H., Georgii Cypri Descriptio Orbis Romani, Lipsia 1890, p. 82.
[lvi] Guillou A., Le Brébion de la Métropole Byzantine de Règion (vers 1050), Biblioteca Apostolica Vaticana, 1974.
[lvii] Parthey G., Hieroclis Synecdemus et Notitiae Graecae Episcopatuum, 1866, p. 265 e sgg.
[lviii] Ibidem, pp. 293-294 e 303.
[lix] “Metropolis Regium hos habet suffraganeos episcopos: (…)”; “Metropolis Cosentia hos habet suffraganeos episcopos: (…)”; “Metropolis Rossanun nullum suffraganeum episcopum habet”; “Metropolis Sancte Severine hos habet suffraganeos episcopos: Hembriacensem, Stroniensem, Genecocastrensem, Cotroniensem, Gerentinum.” Fabre M. P., Le Liber Censuum de l’Eglise Romaine, V, p. 104, Parigi 1889.
[lx] 1091: Romano arcivescovo di Rossano (Trinchera F., Syllabus Graecarum membranarum, 1865, p. 69); 1099: Antzerio arcivescovo della santa chiesa metropolitana di Reggio (Ibidem, p. 70); 1130: Cosma arcivescovo della città di Rossano (Ibidem, p. 141); 1167: Ioannes arcivescovo della città di Rossano (Ibidem, p. 225); 1170: Rogerio arcivescovo della metropoli di Reggio (Ibidem, p. 230); 1177: Basilio arcivescovo di Taranto (Ibidem, p. 248).
[lxi] Non possediamo più questi privilegi nella loro forma originaria scritta in greco, ma nella traduzione latina che, su richiesta dell’abate Nicola, fu fatta dai due giudici Nicola à Iudice e Michele de S. Mauro, come risulta nell’atto scritto il 2 dicembre 1253, in Crotone, per mano del pubblico notaio Giovanni di Pietra Paula. Ughelli F., Italia Sacra tomo IX, Venezia 1721, cc. 475-478.
[lxii] 31 maggio 1099 (a.m. 6607). “Polychronio Deo dilectissimo Episcopo Geruntinensi fundatori Sanctissimae Dei Genitricis Calabro Mariae”, “dilectissimus Episcopus Geruntinensis Dominus Polychronius”, “beatissimo Metropolitano nostro Constantino Praesule Metropoli S. Severinae”, “d. Episcopo”, “dilectissimo Metropolitano nostro Constantino”, “quod non habeant licentiam, seu potestatem amodo aliquis de Metropolitanis, qui in ipsa Metropoli sint, ac possit de Sancta Severina inferre aliquando contrarium”, “tam ipsi Metropoli S. Severinae statutum et confirmatur à beatissimo Metropolitano nostro Constantino”, “Episcopo Geruntinensi Domino Polychronio”. Ughelli F., Italia Sacra tomo IX, Venezia 1721, cc. 476-477.
1 giugno 1115 (a. m. 6623). “Domino Patri nostro Episcopo Geruntinensi D. Polychronio”, “Episcopo Geruntinensi Domino Polychronio”, “Domino dilectissimi Metropolitae S. Severinae Domino Constantino”, “Metropolitani Dom. Constantini in magna Ecclesia Metropolitana”, “Episcopo Domino Polychronio”. Ibidem, cc. 477-478.
18 ottobre 1149 (a. m. 6653). “Domino Polychronio Episcopo Geruntinensi”, “Domino Constantino Metropolitano S. Severinae”, “Metropolitano Domino Constantino”. Ibidem, c. 478.
[lxiii] Guillou A., Les Actes Grecs des Fonds Aldobrandini et Miraglia XI-XIII s., Biblioteca Apostolica Vaticana 2009, p. 95-97.
[lxiv] “Meleto S(anc)tae Severinae Archiep(iscop)o”; “Archiep(iscopu)s Andreas”; “Archiep(iscopu)s romano”. AASS, Pergamena 001.
[lxv] Guillou A., Les Actes Grecs des Fonds Aldobrandini et Miraglia XI-XIII s., Biblioteca Apostolica Vaticana 2009, pp. 101-106.
[lxvi] De Leo P. (a cura di), Documenti Florensi 2001, p. 048.
[lxvii] Giugno 1219: “Dionisius divina miseratione archiepiscopus Sancte Severine” (Pratesi A., Carte Latine di Abbazie Calabresi provenienti dall’Archivio Aldobrandini, 1958, pp. 282-284). 1223-1224: Dionisio santissimo arcivescovo di Santa Severina (Guillou A., Les Actes Grecs des Fonds Aldobrandini et Miraglia XI-XIII s., Biblioteca Apostolica Vaticana 2009, p. 83). 1226: Dionisio santissimo metropolita di Santa Severina (Trinchera F., Syllabus Graecarum membranarum, 1865, p. 376). 1228: Dionisio santissimo metropolita di Santa Severina (Ibidem, p. 385). 1229: Dionisio santissimo metropolita di Santa Severina (Ibidem, p. 390). 27.02.1233: “Bulla Gregorii papae VIIII confirmationis donationis factae per b. m. Dyonisium metropolitam S. Severinae” (De Leo P. (a cura di), Documenti Florensi 2001, p. XXVIII).
[lxviii] “… si accorse che nel fronte interno di una di esse era scolpito un grande titolo romano.” Orsi P., Siberene cit., 1929, p. 204.
[lxix] Orsi P., Siberene cit., 1929, p. 204.
[lxx] Orsi P., Siberene cit., 1929, p. 205.
[lxxi] Orsi P., Siberene cit., 1929, p. 205.
[lxxii] “La cathédrale a bien conservé dans l’ensemble le plan d’une basilique; et quelques tronçons de colonnes, dressés devant le porche, exactement pareils pour le diamètre et pour la nature de la pierre aux colonnes du baptistère, proviennent peut-ètre de l’ancien édifice.” Jordan E., Monuments byzantins de Calabre, Santa Severina, in Mélanges d’archeologie et d’histoire, tome 9, 1889, p. 324. https://www.persee.fr/doc/mefr_0223-4874_1889_num_9_1_6593.
[lxxiii] “Parecchio altro materiale costruttivo antico fu impiegato nella erezione del Battistero bizantino; delle otto colonne, sette sono di granito ed una di pezzami intonacati;”. “Davanti alla cattedrale sono erette cinque esili colonne in granito ed un paio in porfido; ed è in marmo pario (sic) un grosso masso deformato, che davanti la chiesa serviva per bancone. Fungono poi da soglia dell’attuale portone dell’episcopio due pezzi di architrave in marmo greco, i quali presentando una doppia fronte facevano parte di un portichetto corinzio.” Orsi P., Siberene cit., 1929, p. 205.
[lxxiv] Parthey G. e Pinder M., Itinerarium Antonini Augusti et Hierosolymitanum, 1848, pp. 52-53.
[lxxv] Rende P., Gli abitati scomparsi di Paterno e Neto, www.archiviostoricocrotone.it
[lxxvi] “(…) tra Cutro, e’l fiume Neto occorre un castello dal nome del fiume chiamato Neto : dove si veggono le rocche, dalle quali hoggidì si cava’l sale bianchissimo (…)”; a margine: “Rocche di sale in Neto”. “(…) e nel suo territorio sono questi Casali, S. Mauro, S. Giovanni, e Scaualio. (…)”; a margine: “Casali di Neto”. Marafioti G., Croniche et Antichità di Calabria, Padova 1601, libro III, p. 211v.
[lxxvii] “Su una delle faccie del masso che reca l’iscrizione romana sopra illustrata è scolpito il titolo bizantino di cui dò l’immagine fotografica alla fig. 149. Si direbbe tracciato se non proprio dalla stessa mano, certo coi medesimi caratteri di quello dello spatario Staurace, che segue.” Orsi P., Siberene cit., 1929, p. 219.
[lxxviii] Orsi P., Siberene cit., 1929, p. 219.
[lxxix] Guillou A., Le Brébion del la Métropole Byzantine de Règion, Biblioteca Apostolica Vaticana 1974.
[lxxx] “Metropolitico postmodum honore insignita ante annum millesimum nonagesimum nonum, eidem insuffraganeos attributis undecim Episcopalibus Ecclesiis, quarum duabus penitus ab antiquo deletis, nempe Xithomensi, et Florentinenesi; Militensi vero, et S. Marci Apostolico indulto à Metropolitani iure ad immediatam S. Sedis subiectionem transuectis; Illa autem Sancti Leonis à B. Pio V. huic Ecclesiae subiective unita: supersunt nunc sex tantum V(idelicet): Umbriaticen., Insulan., Bellocastren., Strongolen., et qui praest simul duabus aeque principaliter unitis Ecclesiis Geruntinen., et Cariaten., …”. ASV, Rel. Lim. Santa Severina 1685, f. 326-326v.
[lxxxi] “Et si enim decem in libro Provinciali huius metropolis suffraganei re / censeantur, eorum tamen quatuor, sive quinque hoc n(ost)ro desunt aevo / si quadem Duo, Melitensis nempe, et S.ti Marci, Romonarum Pontificuum Diplomata metropolitana Jurisd.e exempti, et S. Sedi immediate / subiecti, hic Consentiam, ille vero Rhegium ad Provincialem Conven / tum accedit; Sitomensis vero, et Florentinen.s episcopatuum nulla, nisi in ipso Pro(vincia)li libro supersunt vestigia; S. Leonis tandem episco / palis Eccl(esi)a a S. Pio V huicmet suae Metropolitanae subiectivi unita.” ASV, Rel. Lim. Santa Severina 1725.
[lxxxii] Russo F., Regesto I, 30 e nota n. 18.
[lxxxiii] “Metropolis Sancte Severine hos habet suffraganeos episcopos: Hembriacensem, Stroniensem, Genecocastrensem, Cotroniensem, Gerentinum.” Fabre M. P., Le Liber Censuum de l’Eglise Romaine, V, p. 104, Parigi 1889.
[lxxxiv] AASS, pergamena 001.
[lxxxv] Pratesi A., Carte Latine di Abbazie Calabresi provenienti dall’Archivio Aldobrandini, 1958, p. 212.
[lxxxvi] Pesavento A., La cattedrale di Santa Severina dedicata a Santa Anastasia Romana dal Quattrocento al Settecento, www.archiviostoricocrotone.it
[lxxxvii] 1 giugno 1273 “Ecclesia Sancte Severine in Calabria”. Russo F., Regesto I, 1060.
[lxxxviii] 6 febbraio 1198. “Capitulo Sanctae Anastasiae. Ex illo singularis excellentie privilegio quod unigenitus Dei Filius Jesus Christus Apostolorum Principi concessit, sanctorum patrum postmodum instituta manarunt, ut maiores cause ad sedem apostolicam perferrentur; quatenus quod super eis deberet statui, circumspecta ipsius responsio declaret. Cum igitur in ecclesia vestra, quae sub obedientia sedis apostolice perseverans, Graecorum hactenus et ritum servavit et linguam, per laicalem potentiam preter nostram auctoritatem et electionem vestram non tam latinus quam barbarus sit intrusus; nos de fratrum nostrorum consilio intrusionem ipsam irritam decernentes, ne diutius pastoris solatio vestra careret ecclesia, vobis humiliter postulantibus secundum statuta canonum et antiquam eiusdem ecclesie consuetuddinem liberam concedimus licentiam eligendi; per apostolica scripta vobis mandantes quatenus talem vobis in pastorem electione canonica preferatis, qui non minus prodesse desiderat et noverit quam preesse.” Russo F., Regesto I, 446.
[lxxxix] 9 febbraio 1198. “(Mathaeo) Capuano, (Guilelmo) Rheginen. et (Bartholomaeo) Panormitano archiepiscopis mandat, laborent ut intrusus barbarus ab ecclesia S. Anastasiae removeatur et ab ipsius capitulo electio possit in ea libere celebrari.” Russo F. Regesto I, 447.
[xc] 9 febbraio 1198. “Constantiae, imperatici Romanorum, mandat quatenus nullius impedimeni obstaculum interponat in electione Pastoris ex parte capituli S. Anastasiae.” Russo F., Regesto I, 448.
[xci] De Leo P., Documenti cit., pp. 47-49.
[xcii] “molte … vecchie mitre piccole di tela, che da quelle si prende testimonianza che in tempo antico li canonici di quella chiesa siano stati mitrati”. ASV, Rel. Lim. S. Severina, 1603.
[xciii] Pratesi A., Carte Latine cit., pp. 170, 283.
[xciv] “(f. 142v) In provincia S. Severine et eiusdem Diocesis. Receptio pecunie reintegrationis dictarum duarum decimarum. (…) Dominus Iohannes prothopapa pro reintegratione dictarum decimarum tar. I gr. XV. Dominus Iohannes prothosaltus pro reintegratione dictarum decimarum gr. VII.” Vendola D., Rationes Decimarum Italiae nei sec. XIII e XIV, Apulia-Lucania-Calabria, 1939, p. 203. “(f. 143v) Presbiter Petrus prothopapa S. Iohannis de Monacho eo iure tar. II. (…) Presbiter Nicolaus prothopapa S. Mauri eo iure tar. II ½. Presbiter Constantinus prothopapa Sguro eo iure gr. VI.” Ibidem, p. 204. “(f. 89) Item in provincia ac civitate et dyocesi S. Severine. (…) Dominus Alamagnus prothopapa tar. unum gr. decem.” (…) Dominus Iohannes prothopapa tar. unum. (…) Presbiter Nicolaus prothopapa S. Mauri tar. tres et gr. quinque.” Ibidem, pp. 205-206. “(f. 120) In civitate et dyocesi S. Leonis eiusdem provincie. (…) Dompnus Theoderus prothopaa S. Leonis tar. tres.” Ibidem, p. 208.
[xcv] Per un approfondimento su questo diritto, Carnì M., Il Diritto Metropolitico di Spoglio sui Vescovi Suffraganei, Torino 2015.
[xcvi] Di un antichissimo diritto dei nostri Metropolitani, in Scalise G. B. (a cura di), Siberene Cronaca del Passato per le Diocesi di Santaseverina – Crotone – Cariati, pp. 86-87.
[xcvii] AASS, pergamena 003.
[xcviii] “Metropolitico postmodum honore insignita ante annum millesimum nonagesimum nonum, …”. ASV, Rel. Lim. Santa Severina 1685, f. 326. Alla fine del sec. XI (maggio 1092) risalgono anche i primi privilegi concessi dal duca Ruggero alla cattedrale di Isola: “In quoquidem privilegio continebatur fabricae reparationis ecclesiae Santae Dei Genitricis et semper Virginis Mariae de Insula de tenimento Cotroni, quae longo tempore diruta lacerata et deserta”. AVC, Privilegio dello Sacro Episcopato della città dell’Isula, in Processo grosso di fogli cinq.cento settanta due della lite, che Mons. Ill.mo Caracciolo ha col S.r Duca di Nocera per il Vescovato, ff. 417 sgg.
[xcix] “Sul declinar poi del secolo XI. riuscì al glorioso Duca Roberto Guiscardo annientar il dominio de Greci Costantinopolitani nelle Contrade di Puglia e Calabria. Ne contento di ciò volle stendere le sue conquiste a danno di quel Greco Imperatore al di la delle spiagie Illiriche, sommettendo al suo comando diverse Provincie Oltremarine. Allora fu che ottenne dai cittadini di Zara in Dalmazia la preziosa reliquia del braccio destro di S. Anastasia Vergine e Martire: dove con special pompa e singolar divozione veneravasi l’intero corpo della Santa Martire.” AASS 084A, f. 48v.
[c] Goffredo Malaterra, De Rebus Gestis Rogerii Comitis, in Muratori L. A., Rerum Italicarum Scriptores, Zanichelli N. Bologna s.d., tomo V, parte I, pp. 59-60.
[ci] “Sotto il di 29 Ottobre dell’anno 1083 in tempo del Ponteficato di Gregorio VII e di Cosma Costantinopolitano Patriarca ne dispose la solenne consegna in mano di Stefano che di quel tempo regea la Cattedra Vescovile.” AASS 084A, f. 48v.
[cii] 01.09.1301. Santa Severina. “Luciferus Dei gratia Sanctae Severinae archiepiscopus”, con il consenso del capitolo, concede per 5 anni all’abbate e al convento del monastero di Fiore, la libera e piena potestà di prendere l’acqua del fiume Neto per i propri mulini, pagando l’annuo censo di 2 oncie d’oro “in festo beatae Anastasiae, in mense octobris, vel circa festum eiusdem”. De Leo P. (a cura di), Documenti Florensi 2001, pp. 161-162. “La detta Città di S. Severina è in calabria nella provintia ultra, et vi è la chiesa Cathedrale Arcivesco(vi)le, e Metropolitana sotto lo titolo de S.ta Anastasia Romana Vergine, e Martire, et è consecrata, della quale Consecrat.e se ne fa la festa nella terza domenica de maggio, et di S.ta Anastasia si celebra alli XXVIIII de ottobre.” (ASV, Visita Apostolica alla diocesi di Santa Severina, 1586). “… qui mense Maio in festo dedicationis Ecc.ae Cathedralis, eidem S.tae Virgini, et Martyri dicatae …” (ASV, Rel. Lim. S. Severina., 1633).
[ciii] ASV, Rel. Lim. Santa Severina, 1725, 1735.
[civ] Pratesi A., Carte Latine di Abbazie Calabresi provenienti dall’Archivio Aldobrandini, 1958, pp. 282-284.
[cv] “… dichiarandola Tutelare e Padrona della Città la Chiesa Cattedrale che da tempo immemorabile era stata dedicata come si è detto sotto gl’auspici della Beatissima Vergine di S. Andrea Apostolo e della Martire S. Severina, sotto l’invocazione della nuova Tutelare ad imitazione della Cattedrale di Zara, restò di unita al Collegio Capitolare specialmente designata”. AASS 084A, f. 49.
[cvi] “Titularis, et Tutelaris Eccl(esi)ae, ac Patrona Principalis, est Sancta Anastasia Virgo, et Martyr, …”. ASV, Rel. Lim. S. Severina., 1765.
[cvii] Rende P., La formazione del territorio Crotonese: dalla “chora” dei Brettii ribelli fino alle “terre” del “Marchesato” (sec. I-XIV), www.archiviostoricocrotone.it
[cviii] “Ed altri intanto giungeranno sulle inaccessibili alture della Sila e sul promontorio di Lino che alto si protende nel mare – regione posseduta da una Amazone – e accoglieranno il giogo di una donna di condizione servile. Lei condurranno le onde, errabonda, in straniera contrada, lei, serva di quella indomita vergine che va tutta coperta di bronzo, e cui, nell’atto di esalare l’estremo spirito, sarà strappato un occhio, che costerà la vita ad un Etolo pernicioso, brutto come una scimmia; il quale dall’asta ancora calda di sangue sarà passato da una parte all’altra. Un giorno, in vero, distruggeranno la città dell’Amazone i Crotoniati, uccidendo la regina che porta il nome del suo paese; ma molti pria cadranno sotto i colpi di lei mordendo coi denti la terra, né senza affanno abbatteranno le torri quei nepoti di Laureta.” Licofrone, Alexandra vv. 993-1007.
[cix] Rende P., La formazione del territorio Crotonese: dalla “chora” dei Brettii ribelli fino alle “terre” del “Marchesato” (sec. I-XIV), www.archiviostoricocrotone.it
[cx] Stefano Bizantino, Ethnica, s.v. Ἀβρεττηνή.
[cxi] Iordanes, De origine actibusque Getarum, XXX, 156.
[cxii] Paulo Diacono, Historia Langobardorum II, 17; MGH Hannoverae 1878, p. 98.
[cxiii] “Gerace (Haghia Kiriaké – Hierak), come abbreviazione di Santa Cyriaca o Sancta Dominica”. De Rose L., Le Dominazioni in Calabria analisi storico-linguistica, 2012, p. 46.
[cxiv] Goffredo Malaterra, De Rebus Gestis Rogerii Comitis, in Muratori L. A., Rerum Italicarum Scriptores, Zanichelli N. Bologna s.d., tomo V, parte I, pp. 59-60.
[cxv] Rende P., La formazione del territorio Crotonese: dalla “chora” dei Brettii ribelli fino alle “terre” del “Marchesato” (sec. I-XIV), www.archiviostoricocrotone.it
[cxvi] “Eius Metrop(olita)na Ecclesia S: Anastasiae Virg. et Mart. Romanae, Civitatis, et Archidioecesis universae praecipuae principalis Patronae dicata”. ASV, Rel. Lim. S. Severina., 1744.
[cxvii] “Vi sono due sacristie fatte nuovamente dal p(rese)nte Arcivescovo in una de quali si conservano le più pretiose cose della chiesa; dove stà un reliquiario munito di inferrate, et catenaccio, sopra un altare con alcune reliquie, la maggior delle quali è un braccio di Santa Anastasia padrona della chiesa come s’è detto, reliquia notabile, non solo per la devotione de populi convicini, ma anco perché si vede conservarsi in quella teca d’argento il braccio di quella santa con la carne, nervi, pelle et piccoli peli.” ASV, Rel. Lim. S. Severina., 1603.
[cxviii] “Titularis, et Tutelaris Eccl(esi)ae, ac Patrona Principalis, est Sancta Anastasia Virgo, et Martyr, cuius festum omni possibili pompa, et solemnitate die 29. m.s Octobris quotannis celebratur, et servatur de praecepto per totam Provinciam Metropoliticam, in qua sub ritu duplicis minoris Officium recitatur, in Civitate vero, et Dioecesi sub ritu duplici primae Classis cum Octava ex decr. S.R.C.” ASV, Rel. Lim. S. Severina., 1765. “Allora fu riconosciuta non solo qual Padrona e Tutelare della Città, come l’era stata da ben dugent’anni, ma dell’Arcidiocesi ancora e Provincia Metropolitica.” AASS 084A, f. 49.
[cxix] Il decreto con il quale la chiesa metropolitana di Santa Severina fu reintegrata “ad regium patronatum” risale al 5 novembre 1798. Il R. Patronato della nostra Metropolitana, in Scalise G. B. (a cura di), Siberene Cronaca del Passato per le Diocesi di Santaseverina – Crotone – Cariati, p. 219.
[cxx] “È nella prima di destra, del Crocefisso, la pietra tombale di un guerriero del Cinquecento, sul quale molto fantasticarono gli eruditi locali; dicesi provenga dalla diruta chiesa di S. Domenico fuori città. Più importanti mi sembrano gli avanzi marmorei smembrati di un monumento della rinascenza con grandi figure di due angeli, due apostoli ed una donna simbolica (figg. 169-171).” Orsi P., Siberene cit., 1929, p. 230. “Questi basorilievi erano prima tutti collocati nella Cappella del Crocifisso, dove giacevano, murate fino al 1998 – a mo’ di riempimento della parte bassa dell’abside –, anche le tre famose lapidi scritte con caratteri greci, che ho rimosso e disposto nelle vetrine progettate da me per la sezione a Piano Terra del Museo Diocesano.” Lopetrone P., Il Battistero Bizantino di Santa Severina, in Quaderni Siberenensi, anno XV 2013, p. 111.
[cxxi] La sistemazione dei quattro bassorilievi nel battistero, risale al progetto dell’arcivescovo Dadone e del colonnello Francesco Galli (1955). Lopetrone P., Il Battistero Bizantino di Santa Severina, in Quaderni Siberenensi, anno XV 2013, p. 111.
[cxxii] “Nel 2006-2007 ho restaurato gli interni (…). Ho smurato poi i cinque bassorilievi …”. “Tutti i manufatti smontati, assolutamente estranei al Tempio, sono stati trasportati accatastati ordinatamente in apposite casse di legno nello spogliatoio dell’ex scuola materna un tempo gestita dalle Suore, a quel tempo già dismessa.” Lo Petrone P., Il Battistero Bizantino di Santa Severina, in Quaderni Siberenensi, anno XV 2013, p. 112.
[cxxiii] Liber Visitationis maioris ecc.e et aliarum ecc.arum civi.tis s.tae severinae (1559). AASS, 16B.
[cxxiv] ASV, Rel. Lim. Santa Severina, 1603.
[cxxv] Considerato che nella metropolitana non c’era altra reliquia che il braccio di S. Anastasia Romana, nel 1613 il papa Paolo V concedeva all’arcivescovo di Santa Severina di poter estrarre sacre reliquie da Roma per portarle nella sua diocesi. ASV, Secr. Brev. 490, ff. 23- 24.
[cxxvi] Liber Visitationis maioris ecc.e et aliarum ecc.arum civi.tis s.tae severinae (1559). AASS, 16B.
[cxxvii] “Reliquie ve ne sono molte, e la maggiore è il braccio di S. Anastasia padrona della chiesa, come si è detto, posto in theca di argento inorato dal detto S.r Cardinale, e tutte si conservano dentro uno reliquiario in una sacrestia, o Tesoro fabricato per ordine, et a spese del sudetto S.r Cardinale per conservavisi le cose più pretiose di quella chiesa.” ASV, Rel. Lim. S. Severina, 1589.
[cxxviii] “Vi sono due sacristie fatte nuovamente dal p(rese)nte Arcivescovo in una de quali si conservano le più pretiose cose della chiesa; dove stà un reliquiario munito di inferrate, et catenaccio, sopra un altare con alcune reliquie, la maggior delle quali è un braccio di Santa Anastasia padrona della chiesa come s’è detto, reliquia notabile, non solo per la devotione de populi convicini, ma anco perché si vede conservarsi in quella teca d’argento il braccio di quella santa con la carne, nervi, pelle et piccoli peli.” ASV, Rel. Lim. S. Severina., 1603.
[cxxix] “Quaternis interim sacellis ingentibus, eleganti opere perfettis attolitur; … Anastasiae Virgini, et Martyri …”. ASV, Rel. Lim. S. Severina., 1625.
[cxxx] “Plurimis, et praeclaris Sanctorum Reliquiis locupletatur, sed bracchium S. Virginis, et Martyris Anastasiae Patronae argento inclusum, carne adhuc incorrupta, multis iam saeculis possidet; Et ex quo illuc accessi, ac celebriori loco reposui, facemque ad SS.orum reliquias perpetuo ardere, annuo censu attributo, iussi, praecipua veneratione colitur.” ASV, Rel. Lim. S. Severina., 1625. “… in Cathedrali retentum decentius cernitur Brachium Santae titulari S. Anastasiae Virginis, et Martyris in Cappella, quam Aulam is instruxi, Cum iugiter ardenti lampada ad in olivarum à me praedio attributo.” ASV, Rel. Lim. S. Severina., 1645.
[cxxxi] “Sacella quatuor eiusdem magnificentiae complectitur, marmore quoque vario exornata. Reliquias obtinet aliquas, et prae aliis brachium S. Anast.ae, carne adhuc sana et incorrupta.” ASV, Rel. Lim. S. Severina., 1656.
[cxxxii] “Titulus eiusdem Ecc.ae est sub invocat.ne S.ae Anastasiae Senioris Virg. et Mart. cuius festum celebratur sub die 29 octobris, et eius effiges in latere sinistro Altaris maioris in propria Cappella collocata conspicitur, eiusque insignis Reliquia in brachio argenteo in ea conservatur.” ASV, Rel. Lim. S. Severina., 1666.
[cxxxiii] “Vi sono in detta Chiesa cinque Cappelle, parte coperte a lamia e due a modo di cupola, due di esse sono ornate di marmo fino e due altre sono ornate con colonne di verde d’ordine dorico, e sono quella della Madonna degli Angeli e quella di S. Anastasia, sopra del quale ornamento vi stà conservato il braccio di S. Anastasia. Un apprezzo della città di Santa Severina, in Siberene, Cronaca del Passato per le Diocesi di Santaseverina – Crotone – Cariati (a cura di Scalise G. B.), p. 104.
[cxxxiv] “Aram Princepem, vario mox marmore obductam, Divaeque Anastasiae Virg., et Mart. sacellum argenteis Crucibus, Candelabris, vasibusque, et tabellis exornavi;”. ASV, Rel. Lim. S. Severina, 1709.
[cxxxv] “Eadem Metropolis Cathedralis Eccl(esi)a Deo in honorem Romanae Virg.s, et Martiris Anastasiae dicata (Cuius brachium Carne adhuc incorrupta vestitum, argentea theca reconditum, inter caeteras quamplurimas SS.rum Reliquias, in discreto Sacrario honorifice asservatas maxima totius Populi veneratione sub tit: Patronae colitur in propria Cappella) …”. ASV, Rel. Lim. S. Severina., 1725.
[cxxxvi] “Appena terminata d.a burrasca, ci fu riferito che concorso il popolo in d.a Chiesa, aveano osservato et una stavano osservando il volto del quadro di S. Anastasia Titulare nella prop.a sua Cappella, tutto mutato di volto, e ch’era umettato di sudori.” Una testimonianza non sospetta, in Siberene, Cronaca del Passato per le Diocesi di Santaseverina – Crotone – Cariati (a cura di Scalise G. B.), pp. 72 -73.
[cxxxvii] “in Cornu Epistolae” “Secundum (altare) in eodem Cornu est S(an)ctae Anastasiae Principali Patronae sacrum, ex lapide pariter formatum, et in Armario lapideo super ipsum sito asservatur brachium integrum cum pelle visibili ipsius Sanctae, in theca argentea collocatum, nec non Lignum S(an)ctae Crucis, aliaeque reliquiae permultae.” ASV, Rel. Lim. S. Severina., 1765.
The post La cattedrale di Santa Severina dedicata a Santa Anastasia Romana tra Alto e Basso Medioevo appeared first on Archivio Storico Crotone.